Dopo vent'anni ho riletto...
Jostein Gaarder

 La filosofia può essere estremamente interessante! "Il mondo di Sofia"
La filosofia può essere estremamente interessante! "Il mondo di Sofia"
Dopo vent'anni ho riletto...
Jostein Gaarder


Da “Il padrone del mondo” di Robert Hugh Benson
*Il Panteismo, come egli lo intendeva, era la sua fede. * *Iddio era per lui l'insieme degli esseri viventi, in perpetua evoluzione; sua essenza, l'unità impersonale. Quindi la rivalità individuale costituiva la grande eresia che metteva l'uno contro l'altro arrestando il progresso, che, secondo lui, consisteva nell'assorbimento dell'individuo nella famiglia, della famiglia nella nazione, della nazione nel continente, del continente nel mondo. Ed il mondo stesso, in ogni suo momento, non era più che la manifestazione d'una vita impersonale. * *Era questa in realtà l'idea cattolica, m...
*Il Panteismo, come egli lo intendeva, era la sua fede. * *Iddio era per lui l'insieme degli esseri viventi, in perpetua evoluzione; sua essenza, l'unità impersonale. Quindi la rivalità individuale costituiva la grande eresia che metteva l'uno contro l'altro arrestando il progresso, che, secondo lui, consisteva nell'assorbimento dell'individuo nella famiglia, della famiglia nella nazione, della nazione nel continente, del continente nel mondo. Ed il mondo stesso, in ogni suo momento, non era più che la manifestazione d'una vita impersonale. * *Era questa in realtà l'idea cattolica, m...
LINEAMENTI DI STORIA DELLA
FILOSOFIA
“Colui che non è in grado di darsi conto di tremila
anni di storia rimane al buio e vive alla giornata”. (W. Goethe)
anni di storia rimane al buio e vive alla giornata”. (W. Goethe)
Tutti noi abbiamo la necessità di trovare una risposta a due domande fondamentali: “Chi siamo?” e “Perché viviamo?”. Chiedersi perché esistiamo non è un interesse occasionale. Sapere come sono stati creati l’universo, la terra e la vita “Esiste una volontà o un significato che sta dietro a ciò che accade?” “C’è qualche forma di vita dopo la morte?” “Come possiamo venire a capo di queste domande?” E soprattutto: “Come dovremmo vivere?”. Le risposte a queste domande non sono contenute in nessuna enciclopedia, però se vogliamo mettere a punto un nostro modo di vedere la vita, può esserci d’aiuto leggere quello che altri uomini hanno pensato.
Molti antichi misteri sono stati risolti poco per volta dalla scienza. La cosa più triste è che crescendo, ci abituiamo al mondo così com’è. In altre parole perdiamo a poco a poco la capacità di stupirci per quello che il mondo ci offre. Ed è questa una perdita grave, perché l’unica di cui abbiamo bisogno per capire la vita è la capacità di stupirci. Circa 600 anni a.C. nacque in Grecia un nuovo modo di pensare: “la Filosofia”. Prima di quell’epoca erano le diverse religioni a fornire le risposte a tutte quelle domande che gli uomini si ponevano. I filosofi greci cercarono di dimostrare agli uomini che queste interpretazioni dell’universo erano inattendibili. Il mito cerca di chiarire un avvenimento che gli esseri non saprebbero spiegarsi altrimenti.
“L’IMMAGINE MITOLOGICA DEL MONDO”
Come in tutti i paesi, anche i greci avevano una rappresentazione mitologica del mondo nel momento in cui nacque la filosofia. Per secoli vennero trasmessi oralmente di generazione in generazione i racconti sugli dei. Verso il 700 a.C. molti dei miti greci furono messi per iscritto da Omero ed Esiodo. Non appena i miti furono scritti, fu possibile cominciare a discutere. I primi filosofi greci criticarono la mitologia di Omero sia perché gli dei assomigliavano molto agli uomini da un punto di vista fisico sia perché erano egoisti e inaffidabili come noi.
Per la prima volta si sostenne che i miti non erano altro che rappresentazioni umane. “I mortali ritengono che gli dei nascono, abbiano vesti, voce e figura come loro”, (Senofonte 570 a.C.)
In quel periodo i greci fondarono molte Città-Stato in Grecia e nelle colonie greche dell’Italia meridionale e dell’Asia Minore. Qui tutto il lavoro manuale ricadeva sugli schiavi, e i liberi cittadini potevano dedicarsi alla cultura e alla politica.
Siamo di fronte a una svolta: da un modo di pensare mitologico si passa a un tipo di ragionamento che ha come base l’esperienza e la logica. L’obiettivo dei primi filosofi era quello di trovare spiegazioni naturali a processi della natura, (stagioni, siccità, eclissi ecc.). I filosofi vedevano con i propri occhi i continui cambiamenti che avvenivano in natura. Ma come erano possibili queste mutazioni? Per non parlare di come un bambino potesse nascere e crescere nel grembo materno! In questo modo la filosofia si rese indipendente dalla religione, cioè pensando in modo “scientifico”.
Il primo filosofo di cui si hanno notizie è Talete, originario della colonia greca di Mileto, in Asia Minore.
TALETE
Talete (640 a.C./625 a.C. – circa 547 a.C.) è stato un filosofo greco antico. È comunemente considerato il primo filosofo della storia occidentale. « Talete di Mileto fu senza dubbio il più importante tra quei sette uomini famosi per la loro sapienza – e infatti tra i Greci fu il primo scopritore della geometria, l’osservatore sicurissimo della natura, lo studioso dottissimo delle stelle » (Apuleio, Florida, 18)

Talete
Secondo Diogene Laerzio, che cita Erodoto, Duride e Democrito, Talete fu figlio di Examio e Cleobulina, di origine fenicia; non è certo se egli fosse nato a Mileto nel I anno della 39a olimpiade (624 a.C.), come riportato da Apollodoro di Atene nella sua Cronologia – ma altri lo fanno nascere al tempo della 35a Olimpiade (circa 640 a.C.) – o se ne ricevesse la cittadinanza dopo essere stato esiliato dalla Fenicia.
Avrebbe per primo ricevuto l’attributo di “sapiente” al tempo dell’arcontato di Damasia in Atene (582 a.C. – 581 a.C.), come attesta Platone che, nel dialogo Protagora (343 a) lo inserisce in una lista di sette nomi (i cosiddetti Sette savi): «Talete di Mileto, Pittaco di Mitilene, Biante di Priene, il nostro Solone, Cleobulo di Lindos, Misone di Chene e settimo Chilone di Sparta; tutti costoro furono emuli, ammiratori e discepoli della costituzione spartana».
Erodoto attribuisce a Talete la previsione dell’eclissi di sole verificatasi il 28 maggio 585 a.C. che avrebbe impressionato talmente i Medi ed i Lidi, in guerra tra loro, da smettere di combattere nonché l’elaborazione d’un espediente che avrebbe permesso all’esercito di Creso, il re della Lidia in guerra contro il persiano Ciro il Grande, di attraversare il fiume Halys.
Racconta Erodoto (Storie, I, 75): « …giunto sul fiume Halys, Creso proseguì. Secondo me, fece passare l’esercito sui ponti lì esistenti, mentre secondo la voce corrente fra gli Elleni sarebbe stato Talete di Mileto a farlo passare. Si dice che Creso fosse molto imbarazzato per il passaggio dell’esercito oltre il fiume, perché allora non vi sarebbero stati ponti. Talete, che si trovava nell’accampamento, avrebbe fatto in modo che il fiume, che scorreva alla sinistra dell’esercito, scorresse anche alla sua destra, ricorrendo a un espediente. Da un punto a nord del campo avrebbe fatto scavare un profondo canale a semicerchio, in modo che il fiume, deviato in parte dall’antico letto, raggiungesse alle spalle le truppe accampate e poi, oltrepassato il campo, sfociasse nel corso antico, cosicché, diviso, il fiume, avrebbe avuto due bracci entrambi guadabili. »
È da notare come questo intervento sul fiume presupponga da parte di Talete la sfiducia nell’esistenza delle divinità fluviali – si ricordi il noto episodio della lotta fra il dio fluviale Scamandro e Achille narrata da Omero nell’Iliade. Erodoto ricorda ancora Talete nelle vesti di saggio politico quando, prevedendo la conquista delle singole città elleniche dell’Asia Minore da parte dell’Impero persiano, suggeriva la costituzione di uno Stato confederato della Ionia greca, esortando gli Ioni a «disporre di un unico Consiglio, a Teo, città nel centro della Ionia, considerando le altre città dei demi, pur sussistendo esattamente come prima».
Diogene Laerzio riferisce ancora che Talete avrebbe sconsigliato un’alleanza antipersiana di Mileto con Creso, prevedendo la sconfitta di quest’ultimo. La tradizione narra anche che questo re avrebbe donato a Talete un Trìpode d’oro, in riconoscimento della sua grande sapienza; e con l’uso della sapienza sarebbe facile arricchire, sostiene Ieronimo di Rodi, narrando come si arricchisse Talete il quale, prevedendo un’abbondante produzione di olive, affittò tutti i frantoi di un’ampia regione, monopolizzandone la molitura.
L’aneddoto è raccolto, oltre che da Cicerone, da Aristotele, il quale nella Politica (A 11, 1259 a) scrive che: « …siccome, povero com’era, gli rinfacciavano l’inutilità della filosofia, avendo previsto in base a calcoli astronomici un’abbondante raccolta di olive, ancora in pieno inverno, pur disponendo di poco denaro, si accaparrò tutti i frantoi di Mileto e di Chio per una cifra irrisoria, dal momento che non ve n’era alcuna richiesta; quando giunse il tempo della raccolta, cercando in tanti urgentemente tutti i frantoi disponibili, egli li affittò al prezzo che volle imporre, raccogliendo così molte ricchezze e dimostrando che per i filosofi è molto facile arricchirsi, ma tuttavia non si preoccupano di questo. »
Descritto da Ateneo come un solitario, probabilmente secondo quella tradizione, di origine nobiliare, che vuole il sapiente necessariamente aristocratico e sprezzatore della massa, sembra anche che non si sia mai sposato, per quanto si dice che abbia adottato il figlio, di nome Cibisto, di una sorella e alle sollecitazioni della madre a prender moglie, rispondesse che non fosse ancora il momento e, anni dopo, precisasse che ormai quel momento era passato; Anacarsi scrive che Talete non volle avere figli proprio per amore dei figli.
È sempre Diogene Laerzio, citando un’opera perduta di Ermippo di Smirne, Le Vite, a riferire quanto è anche attribuito a Socrate, ossia che Talete sarebbe stato grato al destino per «essere nato uomo e non animale, maschio e non femmina e greco e non barbaro». Fu contemporaneo e concittadino di Anassimandro, a sua volta, forse, maestro di Anassimene, gli altri due primi filosofi nella storia della cultura occidentale. Si dice che sia morto assistendo a una gara atletica, al tempo della 58ª Olimpiade: a questo proposito Diogene Laerzio lo ricorda con l’epigramma: « Assistendo un tempo a una gara ginnica, Zeus Elio, il sapiente Talete strappasti dallo stadio.
È bene che tu l’abbia accolto: ormai vecchio, dalla terra non vedeva più le stelle »
È bene che tu l’abbia accolto: ormai vecchio, dalla terra non vedeva più le stelle »
e sostiene che la sua tomba recasse il seguente epitaffio: « Piccola tomba ma di gloria grande come il cielo questa di Talete il sapientissimo »
Nulla è rimasto dei suoi scritti, se pure egli scrisse mai; gli furono attribuite, con nessun credito, un’ Astronomia nautica, che sarebbe di Foco di Samo ed è perduta e che dovrebbe essere quell’ Astrologia presuntivamente attribuitagli nel De Pythiae oraculis da Plutarco, due altre opere intitolate Sul solstizio e Sull’equinozio mentre Galeno gli attribuisce un’opera in due libri, intitolata Dei principi, citandone un passo: « I tanto decantati quattro elementi, dei quali diciamo che l’acqua è il primo e lo poniamo quasi unico elemento, si mescolano fra loro al fine di un’aggregazione, coagulazione e unione delle cose terrestri. Come ciò avvenga, l’ho detto nel primo libro. »
Ai maggiori intellettuali di quell’epoca, denominati per questo “sapienti”, vengono variamente attribuite delle sentenze; a Talete sono attribuiti gli apoftegmi:
- L’essere più antico è Dio, perché non generato
- Il più bello è il mondo, perché opera divina
- Il più grande lo spazio, perché tutto comprende
- Il più veloce l’intelletto, perché passa attraverso tutto
- Il più forte la necessità, perché tutto domina
- Il più saggio il tempo, perché tutto rivela
Ma la più famosa e prestigiosa sentenza (attribuita in un primo momento a Talete e riconosciuta successivamente a Socrate) è il «Conosci te stesso», riportato da Antistene di Rodi nelle sue Successioni dei filosofi.
A chi gli domandava se fosse venuta prima la notte o il giorno, rispondeva che era precedente la notte, di un giorno; diceva anche che la cosa più semplice è dare consigli a un altro; che la cosa più piacevole è avere successo; la più sgradevole è vedere un tiranno esser potuto invecchiare; che il divino è ciò che non ha né inizio né fine; che gli ingiusti non possono sfuggire all’attenzione degli dei, neanche solo pensando di fare un’ingiustizia; che lo spergiuro non è peggiore dell’adulterio; che la sventura si sopporta più facilmente se ci si rende conto che ai propri nemici le cose vanno peggio; che si vive virtuosamente non facendo quello che rinfacciamo agli altri; che è felice chi è sano nel corpo, ricco nell’anima e ben educato; di ricordarsi degli amici, presenti e assenti, di non abbellirsi nell’aspetto ma nei comportamenti, di non arricchirsi in modo malvagio, di non cadere in discredito agli occhi di coloro con i quali si è legati da un patto, di aspettarsi dai figli gli stessi benefici arrecati ai genitori.
Infine, sosteneva che la morte non è diversa in nulla dalla vita. A chi gli obbiettava perché allora non morisse, rispondeva che era perché non c’era alcuna differenza.
ANASSIMANDRO
Il secondo filosofo è Anassimandro, anche lui di Mileto secondo cui il nostro è solo uno dei molti mondi che nascono da qualcosa e muoiono in qualcosa che egli chiamò “ápeiron”, cioè infinito o illimitato.

Anassimandro
ANASSIMENE
Il terzo filosofo è Anassimene, vissuto anch’esso a Mileto intorno al 586-528 a.C. Secondo lui, la materia di cui sono formate tutte le cose doveva essere l’aria.
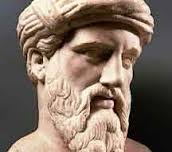
Anassimene
Tutti e tre i filosofi di Mileto ritenevano che esistesse un solo principio da cui originava tutto il resto. Ma come faceva un principio a trasformarsi in qualcosa di completamente diverso?
A partire dal 500 a.C., alcuni filosofi che abitavano nella colonia greca di Elea, nell’Italia meridionale (eleatici), si occuparono di queste questioni.
I FILOSOFI DELLA NATURA
Ma anche che niente può trasformarsi in qualcosa di diverso da quello che è. Consapevole del fatto che la natura è una serie di continui mutamenti egli, per mezzo dei sensi registrava il modo in cui si trasformavano. Non riuscendo a far coincidere quanto percepiva con i sensi con quello che gli diceva la ragione, decise di fidarsi della ragione. Come filosofo capì che il suo compito era quello di smascherare tutte le forme di inganno dei sensi. Questa fede così radicata nella ragione umana venne chiamata “razionalismo” da “logos-ragione”. Un razionalista crede che la ragione umana sia la fonte del nostro sapere sul mondo.
Secondo Eraclito (550-480 a.C.) originario di Efeso, in Asia Minore, il tratto costitutivo della natura è dato proprio dai suoi continui cambiamenti, “tutto scorre” tutto è in movimento e niente dura in eterno. Per questo “non si può discendere due volte nel medesimo fiume”, perché quando mi immergo nel fiume per la seconda volta, sia io che il fiume siamo diversi.

Eraclito
Spiegò anche che il mondo è caratterizzato da stati contrari. Se non ci si ammala, non si potrebbe capire che cosa significa star bene, così vale per la fame, la sete ecc.. Sia il bene che il male occupano un posto necessario nell’unità. Se non ci fosse un continuo gioco tra gli opposti, il mondo finirebbe. Anche se noi uomini non la pensiamo tutti allo stesso modo, o non siamo dotati dello stesso buonsenso, deve esistere una forma di “buon ordine” che guida e domina tutto quello che succede in natura. Tuttavia per Eraclito la maggior parte degli uomini vive seguendo la propria ragione privata.
Parmenide dice: – niente può cambiare e….
– per questo le impressioni dei sensi sono inattendibili.
Eraclito invece: – tutto cambia “tutto scorre”.
– le impressioni dei sensi sono attendibili.
– per questo le impressioni dei sensi sono inattendibili.
Eraclito invece: – tutto cambia “tutto scorre”.
– le impressioni dei sensi sono attendibili.
Parmènide di Elea (Elea, 515 a.C. – 450 a.C.) è stato un filosofo greco antico, presocratico. Fu il maggiore esponente della scuola eleatica.
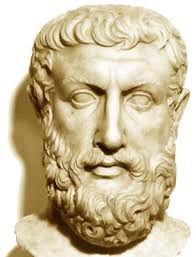
Parmenide
Parmenide nacque in Magna Grecia, ad Elea (Velia in epoca romana, oggi Ascea), da una famiglia aristocratica. Della sua vita si hanno poche notizie. Fu probabilmente discepolo di Senofane. Dai suoi concittadini sarebbe stato chiamato a redigere le leggi della sua città. Ad Elea fondò inoltre una scuola, insieme al suo discepolo prediletto Zenone. Platone nel Parmenide riferisce di un viaggio che negli anni della vecchiaia Parmenide intraprese alla volta di Atene, dove conobbe Socrate da giovane col quale ebbe una vivace discussione.
«…Orbene io ti dirò, e tu ascolta accuratamente il discorso, quali sono le vie di ricerca che sole sono da pensare: l’una che “è” e che non è possibile che non sia, e questo è il sentiero della Persuasione (infatti segue la Verità); l’altra che “non è” e che è necessario che non sia, e io ti dico che questo è un sentiero del tutto inaccessibile: infatti non potresti avere cognizione di ciò che non è (poiché non è possibile), né potresti esprimerlo. … Infatti lo stesso è pensare ed essere. »
L’unica opera di Parmenide è il poema in esametri intitolato Poema sulla natura, di cui alcune parti sono citate da Simplicio in De coelo e nei suoi commenti alla Fisica aristotelica, da Sesto Empirico e da altri scrittori antichi. Di tale poema ci sono giunti ad oggi diciannove frammenti, alcuni dei quali allo stato di puro stralcio, che comprendono un Proemio e una trattazione in due parti: La via della Verità e La via dell’Opinione; di quest’ultima abbiamo solo pochi versi.
Nel Poema sulla natura Parmenide sostiene che la molteplicità e i mutamenti del mondo fisico sono illusori, e afferma, contrariamente al senso comune, la realtà dell’Essere: immutabile, ingenerato, finito, immortale, unico, omogeneo, immobile, eterno. La narrazione si snoda intorno al percorso intellettuale del filosofo che racconta il suo viaggio immaginario verso la dimora della dea Diche (dea della Giustizia) la quale lo condurrà al «cuore inconcusso della ben rotonda verità». Secondo alcuni, la splendida donna rappresenterà d’ora in poi il significato della filosofia. La dea mostra al filosofo la via dell’opinione, che conduce all’apparenza e all’inganno, e la via della verità che conduce alla sapienza e all’Essere .
Pur non specificando cosa sia questo essere, Parmenide è il filosofo che per primo ne mette a tema esplicitamente il concetto; su di esso egli esprime soltanto una lapidaria formula, la più antica testimonianza in materia, secondo la quale «l’essere è, e non può non essere», «il non-essere non è, e non può essere»:« è, e non è possibile che non sia… non è, ed è necessario che non sia » (Parmenide, Sulla Natura, fr. 2, vv 3;5). Con queste parole Parmenide intende affermare che niente si crea dal niente, e nulla può essere distrutto nel nulla. Già i primi filosofi greci avevano cercato l’origine (o ἀρχή, archè) della mutevolezza dei fenomeni in un principio statico che potesse renderne ragione, non riuscendo a spiegarsi il divenire. Ma i cambiamenti e le trasformazioni a cui è soggetta la natura, tali per cui alcune realtà nascono, altre scompaiono, secondo Parmenide non hanno semplicemente motivo di esistere, essendo pura illusione. La vera natura del mondo, il vero essere della realtà, è statico e immobile. A tali affermazioni Parmenide giunge promuovendo per la prima volta un pensiero basato non più su spiegazioni mitologiche del cosmo, ma su un metodo razionale, servendosi in particolare della logica formale di non-contraddizione, da cui si traggono le seguenti conclusioni:
- L’Essere è immobile perché se si muovesse sarebbe soggetto al divenire, e quindi ora sarebbe, ora non sarebbe.
- L’Essere è Uno perché non possono esserci due Esseri: se uno è l’essere, l’altro non sarebbe il primo, e sarebbe quindi non-essere. Allo stesso modo per cui, se A è l’essere, e B è diverso da A, allora B non è: qualcosa che non sia Essere non può essere, per definizione.
- L’Essere è eterno perché non può esserci un momento in cui non è più, o non è ancora: se l’essere fosse solo per un certo periodo di tempo, a un certo momento non sarebbe, e si avrebbe contraddizione.
- L’Essere è dunque ingenerato e immortale, poiché in caso contrario implicherebbe il non essere: la nascita significherebbe essere, ma anche non essere prima di nascere; e la morte significherebbe non essere, ovvero essere solo fino a un certo momento.
- L’Essere è indivisibile, perché altrimenti richiederebbe la presenza del non-essere come elemento separatore.
L’Essere risulta così vincolato dalla necessità (ἀνάγχη, anànche), che è il suo limite ma al contempo il suo fondamento costitutivo: «la dominatrice Necessità lo tiene nelle strettoie del limite che lo rinserra tutto intorno; perché bisogna che l’essere non sia incompiuto». Parmenide paragona l’Essere a una sfera perfetta, sempre uguale a se stessa nello spazio e nel tempo, chiusa e finita (per gli antichi greci il finito era sinonimo di perfezione). La sfera è infatti l’unico solido geometrico che non ha differenze al suo interno, ed è uguale dovunque la si guardi; l’ipotesi collima suggestivamente con la teoria della relatività di Albert Einstein che nel 1900 dirà: «Se prendessimo un binocolo e lo puntassimo nello spazio, vedremmo una linea curva chiusa all’infinito» in tutte le direzioni dello spazio, ovvero, complessivamente, una sfera (per lo scienziato infatti l’universo è finito sebbene illimitato, fatto di uno spazio tondo ripiegato su se stesso). Fuori dell’Essere non può esistere nulla, perché il non-essere, secondo logica, non è, per sua stessa definizione. Il divenire attestato dai sensi, secondo cui gli enti ora sono e ora non sono, è una mera illusione (che appare ma in realtà non è). La vera conoscenza dunque non deriva dai sensi, ma nasce dalla ragione. «Non c’è nulla di errato nell’intelletto che prima non sia stato negli erranti sensi» è la frase che d’ora in poi sarà attribuita a Parmenide.
Il pensiero è dunque la via maestra per cogliere la verità dell’Essere: «ed è lo stesso il pensare e pensare che è. Giacché senza l’essere… non troverai il pensare», a indicare come l’Essere si trovi nel pensiero. Pensare il nulla è difatti impossibile, il pensiero è necessariamente pensiero dell’essere. Di conseguenza, poiché è sempre l’essere a muovere il pensiero, la pensabilità di qualcosa dimostra l’esistenza dell’oggetto pensato. Tale identità immediata di essere e pensiero, a cui si giunge scartando tutte le impressioni e i falsi concetti derivanti dai sensi, abbandonando ogni dinamismo del pensiero, accomuna Parmenide alla dimensione mistica delle filosofie apofatiche orientali, come il buddhismo, il taoismo e l’induismo. Una volta stabilito che l’Essere è, e il non-essere non è, restava tuttavia da spiegare come nascesse l’errore dei sensi, dato che nell’Essere non ci sono imperfezioni, e perché gli uomini tendano a prestare fede al divenire attribuendo l’essere al non-essere. Parmenide si limita ad affermare che gli uomini si lasciano guidare dall’opinione (δόξα, doxa), anziché dalla verità, ossia giudicano la realtà in base all’apparenza, secondo procedimenti illogici. L’errore in definitiva è una semplice illusione, e dunque, in quanto non esiste, non si può trovargli una ragione. Compito del filosofo è unicamente quello di rivelare la nuda verità dell’Essere nascosta sotto la superficie degli inganni.
Il tema sarà ripreso da Platone che cercherà una soluzione al conflitto tra l’essere e il molteplice; per sciogliere il dramma umano costituito dal senso greco del divenire (per cui tutto muta) che si scontra con una ragione, altra dimensione fondamentale della grecità, che è portata a negarlo, Platone concepirà il non-essere non più alla maniera di Parmenide staticamente e assolutamente contrapposto all’essere, ma come diverso dall’essere in senso relativo, nel tentativo di dare una spiegazione razionale anche al tempo e al molteplice. Il rigore logico di Parmenide gli valse inoltre l’appellativo di “venerando e terribile” da parte di Platone. La fiducia di Parmenide in un sapere completamente dedotto dalla ragione, e viceversa la sua totale sfiducia nei confronti dei sensi e di una conoscenza empirica, fa di lui un filosofo profondamente razionalista. Parmenide fu il fondatore della scuola di Elea, dove ebbe vari discepoli, il più importante dei quali fu Zenone. Il metodo usato dagli eleati era la dimostrazione per assurdo, con cui confutavano le tesi degli avversari giungendo a dimostrare la verità dell’Essere, nonché la falsità del divenire e delle impressioni dei sensi, per una “impossibilità logica di pensare altrimenti”.
Stupiva i contemporanei un ragionamento che scaturiva dalla radicale contrapposizione essere/non-essere e da un’immediata conseguenza del principio di non-contraddittorietà dell’essere e del pensiero, teorizzato in seguito da Aristotele come evidenza prima e indimostrabile alla ragione senza la quale diverrebbe impossibile qualsiasi conoscenza necessaria-filosofica, restando solo il mondo dell’opinione. Parmenide e gli eleati si contrapponevano soprattutto al pensiero di Eraclito, loro contemporaneo, filosofo del divenire che basava la conoscenza interamente sui sensi. Nella prospettiva della storia della filosofia, sarà quindi Hegel a concepire l’essere in maniera radicalmente opposta a Parmenide. Anche l’atomismo democriteo intese contrapporsi alla teoria eleatica dell’Essere (che aveva cercato una soluzione al problema dell’archè negando alla radice un fondamento originario al divenire), presupponendo gli atomi e uno spazio vuoto, diverso dagli atomi, in cui essi potessero muoversi, ipotizzando in un certo senso una convivenza di essere e non-essere. In seguito furono i sofisti a cercare di confutare il pensiero degli eleati, opponendo al loro sapere certo e indubitabile (επιστήμη, epistéme) sia il relativismo di Protagora, sia il nichilismo di Gorgia. Uno dei maggiori problemi sollevati da Parmenide riguardava in particolare l’impossibilità di oggettivare l’Essere, di darne un predicato, di sottrarlo all’astrattezza formale con cui Parmenide l’aveva enunciato, e che sembrava contrastare con la pienezza totale del suo contenuto. Fu seguendo questa strada che Platone, nel tentativo di risolvere il problema, approderà al mondo delle idee.
Fu Empedocle di Agrigento che riuscì a dipanare l’intricata matassa in cui si trovava la filosofia. Secondo lui sia Parmenide che Eraclito avevano ragione in una delle loro affermazioni, ma sbagliavano in un punto entrambi: davano per scontato che esiste un solo principio. Se fosse vero, il divario tra ciò che dice la ragione e quello che vediamo con nostri occhi sarebbe incolmabile. L’acqua non può diventare pesce però vediamo che in natura avvengono continuamente mutamenti. Empedocle arrivò alla conclusione che la natura è costituita da quattro radici: la terra, l’aria, il fuoco e l’acqua. Tutti i cambiamenti che avvengono in natura sono dovuti al mescolarsi e al separarsi delle quattro radici. Se un pittore ha un solo colore, es. il rosso, non può dipingere gli alberi verdi, ma se ha il giallo, il rosso, il blu e il nero, allora può dipingere centinaia di colori diversi mescolandoli in proporzioni differenti.
Si avvertono il crepitio e uno scoppiettare del legno: si tratta dell’acqua. Qualcosa sale sotto forma di fumo: è l’aria. Il fuoco lo vediamo davanti a noi e, quando si spegne, rimane ancora qualcosa: la cenere (cioè la terra). Ma qual è la causa che spinge le radici a mescolarsi in modo da far crescere una nuova vita? E cosa fa separare? Lui le chiama Amore (o amicizia) e Odio (o discordia). La prima lega le cose la seconda le separa. Forse Empedocle osservò come bruciava un pezzo di legno. In sintesi si può dire che qualcosa si dissolve.
A detta invece di Anassagora (499 – 428 a.C.) originario di Clazomene, Asia Minore la natura viene costruita partendo da particelle minuscole che l’occhio non può vedere. “Come infatti potrebbe prodursi da ciò che non è capello il capello e la carne da ciò che non è carne?”.

Anassagora chiamò questi principi infinitamente divisibili “semi”. E anche per lui esiste una specie di forza che “organizza”, il noûs, cioè “l’intelletto”. Trasferitosi ad Atene nel 462 a.C., nel 432 venne processato per aver sostenuto che gli dei non esistevano e fu costretto a fuggire. Aveva anche affermato che il sole non era un dio, bensì una massa incandescente molto più grande della penisola del Peloponneso.
L’ultimo dei grandi filosofi della natura fu Democrito (460-370 a.C.) originario di Abdera a nord sulla costiera del mar Egeo. Concordava che i suoi predecessori nell’affermare che i cambiamenti in natura non si spiegavano con il fatto che qualcosa “mutasse” realmente. Per questo ipotizzò che tutto fosse composto da mattoncini invisibili ciascuno dei quali era eterno e immutabile, a questi elementi minimi diede il nome di “atomi”, átomos = indivisibile, (Atomo: 1 miliardesimo di mm., i neutroni, protoni in esso contenuti sono 10.000 volte più piccoli e ancora particelle chiamate quark. I fisici che studiano l’infinitamente piccolo pensano che vi siano particelle ancora più piccole ma come sopra detto, sono concordi nell’affermare vi sia un limite) era fondamentale sottolineare che gli elementi con cui viene costruita ogni cosa non potevano essere divisi all’infinito: se così fosse stato non si sarebbero potuti utilizzare come mattoni da costruzione, la natura avrebbe cominciato a fluire come una zuppa sempre più liquida.

Democrito
Oggi possiamo affermare che la teoria di Democrito sugli atomi era giusta. La natura è veramente “costruita” da atomi che si aggregano e si separano. La scienza ha tuttavia scoperto che gli atomi si possono dividere in particelle ancora più piccole: protoni, neutroni e elettroni e anche queste a loro volta possono essere scisse. Ma i fisici sono concordi nell’affermare che ci deve essere un limite.
SOCRATE
Socrate – Atene, 470 a.C./469 a.C. – Atene, 399 a.C.) è stato un filosofo greco antico, uno dei più importanti esponenti della tradizione filosofica occidentale. Socrate fu il primo filosofo ad essere ritratto. Tutte le altre immagini dei filosofi presocratici sono opere di fantasia. Il contributo più importante che egli ha dato alla storia del pensiero filosofico consiste nel suo metodo d’indagine: il dialogo che utilizzava lo strumento critico dell’elenchos,”confutazione”) applicandolo prevalentemente all’esame in comune di concetti morali fondamentali. Per questo Socrate è riconosciuto come padre fondatore dell’etica o filosofia morale. Per le vicende della sua vita e della sua filosofia che lo condussero al processo e alla condanna a morte è stato considerato, dal filosofo e classicista austriaco Theodor Gomperz, il primo martire occidentale della libertà di pensiero.
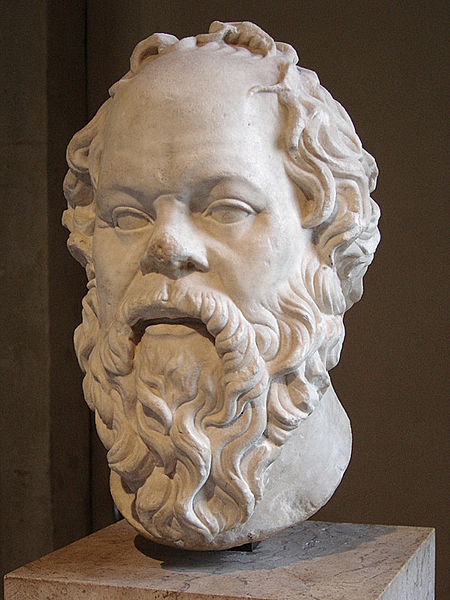
Testa di Socrate – Scultura di epoca romana conservata al Museo del Louvre.
LE FONTI SULLA VITA
È ben noto il fatto che Socrate non abbia lasciato alcuno scritto. Ricaviamo quindi il pensiero di Socrate dalle opere dei suoi discepoli, tra cui spicca soprattutto il sopraccitato Platone che fu per lungo tempo uno di essi e che condivise, negli scritti giovanili, il pensiero del maestro, a tal punto che risulta difficile distinguere il pensiero socratico da quello platonico, che acquisì poi una maggiore originalità solo nella maturità e nella vecchiaia.
Un’altra fonte della vita e del pensiero di Socrate è rappresentata dalle opere cosiddette socratiche (Apologia di Socrate, Simposio, Detti memorabili di Socrate) dello storico Senofonte discepolo di Socrate che la storiografia ottocentesca ha apprezzato per le notizie sulla vita del maestro mentre quella novecentesca le ha considerate di scarso interesse soprattutto se confrontate alle opere platoniche. Dalle opere di Senofonte dedicate al maestro complessivamente l’immagine di Socrate che emergerebbe sarebbe quella di un uomo virtuoso e morigerato, cittadino modello, timorato degli dei, instancabile nel predicare la virtù e nell’esortare i giovani all’obbedienza verso i genitori e alle leggi dello Stato. «La critica più recente guarda tuttavia con maggiore equilibrio agli scritti senofontei, riconoscendogli chiarezza e coerenza; la figura di Socrate che se ne ricava spicca per il carattere morale e una certa forma di ascetismo. Molto spazio viene dedicato all’intellettualismo socratico e alle nozioni di bene e di virtù, nonché alla dialettica del maestro…»
Dalle opere socratiche di Senofonte complessivamente l’immagine di Socrate che emerge è quella di un uomo virtuoso e morigerato, cittadino modello, timorato degli dei, instancabile nel predicare la virtù e nell’esortare i giovani all’obbedienza verso i genitori e alle leggi dello Stato.
Un’altra testimonianza la troviamo ne Le nuvole, commedia di Aristofane dove Socrate viene rappresentato come veniva visto da alcuni ad Atene e cioè come un pedante seccatore perso nelle sue discussioni astratte e campate in aria. Aristofane infatti mostra Socrate dentro una cesta che cala dalle nuvole mentre è tutto intento a delle ricerche strambe e ridicole, come calcolare quanto è lungo il salto della pulce, o quale sia l’origine del ronzio delle zanzare. Aristofane vuole evidentemente fare una caricatura di queste ricerche naturalistiche che egli impropriamente attribuisce a Socrate, e anche avvertire che chi si dedica allo studio della natura in genere è un ateo, che rigetta la religione tradizionale, nella sua commedia ridicolmente sostituita dal culto delle Nuvole.
Testimone del pensiero socratico è Aristotele che però risulta poco attendibile poiché egli tende a esporre il pensiero dei filosofi precedenti interpretandolo secondo il suo personale punto di vista, operando distorsioni e fraintendimenti sui concetti originali. Aristotele infatti, presenta la dottrina socratica come incentrata, in un primo tentativo fallito, nell’individuare la definizione del concetto. A questo, secondo Aristotele, mirava la ricerca che si esprimeva nel continuo interrogare (ti estì “che cos’è?”) che Socrate effettuava nel dialogo: la definizione precisa della cosa di cui si stava parlando. In particolare Aristotele attribuiva a Socrate la scoperta del metodo della definizione e induzione, che considerava l’essenza del metodo scientifico. Stranamente però, Aristotele affermava pure che tale metodo non fosse adatto all’etica. Socrate invece avrebbe erroneamente applicato questo suo metodo all’esame dei concetti morali fondamentali del tempo, come ad esempio le virtù di pietà, saggezza, temperanza, coraggio, e di giustizia.
Probabilmente Socrate frequentò il gruppo degli amici di Pericle e conobbe le dottrine dei filosofi naturalisti Ionici di cui apprezzava in particolare Anassimandro, fattogli conoscere da Archelao. Nel 454 a.C. essendo presenti ad Atene Parmenide e Zenone di Elea, Socrate ebbe modo di conoscere la dottrina degli eleati come pure fu in rapporti con i sofisti Protagora, Gorgia e Prodico.
Si sa che fu molto interessato al pensiero di Anassagora ma se ne allontanò per la teoria del Nous (“Mente”) che metteva ordine nel caos primigenio degli infiniti semi. Secondo alcuni interpreti Socrate pensava che questo principio ordinatore dovesse essere identificato con il sommo principio del Bene, un principio morale alla base dell’universo, ma quando invece si accorse che per Anassagora il Nous doveva invece rappresentare un principio fisico, una forza materiale, ne fu deluso e abbandonò la sua dottrina.
BIOGRAFIA
Il periodo storico in cui visse Socrate è caratterizzato da due date fondamentali: il 469 a.C. e il 404 a.C. La prima data, quella della sua nascita, segna la definitiva vittoria dei Greci sui Persiani (battaglia dell’Eurimedonte). La seconda si riferisce a quando all’età dell’oro di Pericle seguirà, dopo il 404 con la vittoria spartana, l’avvento del governo dei Trenta Tiranni. La vita di Socrate si svolge dunque nel periodo della maggiore potenza ateniese ma anche del suo declino.
Il padre di Socrate, Sofronisco, fu uno scultore del demo di Alopece, ed è possibile che trasmise tale mestiere al giovane figlio, anche se nessuna testimonianza gli attribuisce alcun mestiere; in tal senso, secondo Diogene Laerzio, opera di Socrate sarebbero state le Cariti, vestite, sull’Acropoli di Atene. Sua madre, Fenarete, che aveva già avuto un figlio di nome Patrocle da un precedente matrimonio con Cheredemo sarebbe stata una levatrice. Probabilmente Socrate era di famiglia benestante, di origini aristocratiche: nei dialoghi platonici non risulta che egli esercitasse un qualsiasi lavoro e del resto sappiamo che egli combatté come oplita[17] nella battaglia di Potidea, e in quelle di Delio e di Anfipoli. È riportato nel dialogo Simposio di Platone che Socrate fu decorato per il suo coraggio. In un caso, si racconta, rimase al fianco di Alcibiade ferito, salvandogli probabilmente la vita. Durante queste campagne di guerra dimostrò di essere straordinariamente resistente, marciando in inverno senza scarpe né mantello.
Nel 406 come membro del Consiglio dei Cinquecento (Bulé), Socrate fece parte della Pritania quando i generali della Battaglia delle Arginuse furono accusati di non aver soccorso i feriti in mare e di non aver seppellito i morti per inseguire le navi spartane. Socrate ricopriva la carica di Epistate ed unico nell’assemblea si oppose alla richiesta illegale di un processo collettivo contro i generali. Nonostante pressioni e minacce bloccò il procedimento fino alla conclusione del suo mandato quando infine sei generali ritornati ad Atene furono condannati a morte.
Nel 404, i Trenta Tiranni ordinarono a Socrate e ad altri quattro cittadini di arrestare il democratico Leonzio di Salamina. Socrate si oppose all’ordine e la sua morte fu evitata solo dalla successiva caduta dei Tiranni. Socrate è descritto da Platone come un uomo avanti negli anni e piuttosto brutto, e aggiunge anche che era come quelle teche apribili, installate di solito ai quadrivi, raffiguranti spesso un satiro che custodivano all’interno la statuetta di un dio. Questo pare quindi fosse l’aspetto di Socrate, fisicamente simile a un satiro, e tuttavia sorprendentemente buono nell’animo, per chi si soffermava a discutere con lui. Diogene Laerzio riferisce che, secondo alcuni antichi, Socrate avrebbe collaborato con Euripide alla composizione delle tragedie, ispirando in esse temi profondi di riflessione.
Socrate fu sposato con Santippe, che gli diede tre figli: Lampsaco, Sofronisco e Menesseno. Tuttavia, secondo Aristotele e Plutarco, due di questi li avrebbe avuti da una concubina di nome Mirto). Santippe ebbe fama di donna insopportabile e bisbetica. Socrate stesso attestò che avendo imparato a vivere con lei era divenuto ormai capace di adattarsi a qualsiasi altro essere umano, esattamente come un domatore che avesse imparato a domare cavalli selvaggi, si sarebbe trovato a suo agio con tutti. Egli d’altra parte era talmente preso dalle proprie ricerche filosofiche al punto da trascurare ogni altro aspetto pratico della vita, tra cui anche l’affetto della moglie, finendo per condurre un’esistenza quasi vagabonda. Socrate viene anche rappresentato come un assiduo partecipante a simposi, intento a bere e a discutere. Fu un bevitore leggendario, soprattutto per la capacità di tollerare bene l’alcool al punto che quando il resto della compagnia era ormai completamente ubriaca egli era l’unico a sembrare sobrio.
L’ATENE DI SOCRATE

L’Acropoli con il Partenone, raffigurazione del nazionalismo greco al tempo di Pericle
Socrate visse dunque durante un periodo di transizione, dall’apice del potere di Atene fino alla sua sconfitta per mano di Sparta e alla sua coalizione nella guerra del Peloponneso (404). Dopo la sconfitta s’insediò ad Atene un regime oligarchico e filospartano guidato da Crizia, un nobile sofista negatore della religione. Dopo appena un anno, il governo dei Trenta tiranni decadde e s’instaurò un governo democratico conservatore formato da esiliati politici, guidato da Trasibulo. Egli giudicò Socrate un nemico politico per i rapporti che aveva avuto con Alcibiade, suo scapestrato discepolo e presunto amante, accusato di avere tradito Atene per Sparta.
Il nuovo regime democratico voleva riportare la città allo splendore dell’età di Pericle instaurando un clima di pacificazione generale: infatti non perseguitò, com’era abitudine, i nemici del partito avverso ma concesse un’amnistia. Si voleva tornare a creare in Atene una compattezza e solidarietà sociale riproponendo ai cittadini gli antichi ideali e i principi morali che avevano fatto grande Atene. Ma nella città si diffondeva l’insegnamento, seguito con entusiasmo da molti, specie giovani, dei sofisti i quali invece esercitavano una critica corrosiva di ogni principio e verità che si volesse dare per costituita dalla religione o dalla tradizione.
LA DOTTRINA SOCRATICA
Molti studiosi di storia della filosofia concordano nell’attribuire a Socrate la nascita di quel peculiare modo di pensare che ha consentito l’origine e lo sviluppo della riflessione astratta e razionale, che sarà il fulcro portante di tutta la filosofia greca successiva. Il primo a sviluppare questa interpretazione della dottrina socratica fu Aristotele che attribuì a Socrate la scoperta del metodo della definizione e induzione, che egli considerava uno, ma non l’unico, degli assi portanti del metodo scientifico.
SAPERE DI NON SAPERE
Paradossale fondamento del pensiero socratico è il “sapere di non sapere”, un’ignoranza intesa come consapevolezza di non conoscenza definitiva, che diventa però movente fondamentale del desiderio di conoscere. La figura del filosofo secondo Socrate è completamente opposta a quella del saccente, ovvero del sofista che si ritiene e si presenta come sapiente, perlomeno di una sapienza tecnica come quella della retorica. Le fonti storiche che ci sono pervenute descrivono Socrate come un personaggio animato da una grande sete di verità e di sapere, che però sembravano continuamente sfuggirgli. Egli diceva di essersi convinto così di non sapere, ma proprio per questo di essere più sapiente degli altri.
Nell’Apologia di Socrate ci viene descritto come egli abbia preso coscienza di ciò a partire da un singolare episodio. Un suo amico, Cherefonte, aveva chiesto alla Pizia, la sacerdotessa dell’oracolo di Apollo a Delfi, chi fosse l’uomo più sapiente e questa aveva risposto che era Socrate. Egli sapeva di non essere il più sapiente e quindi volle dimostrare come l’oracolo si fosse sbagliato andando a dialogare con quelli che avevano fama di essere molto sapienti, in particolare i politici. Ma alla fine del confronto, racconta Socrate, questi, messi di fronte alle proprie contraddizioni (l’aporia socratica) e inadeguatezze, provarono stupore e smarrimento, apparendo per quello che erano: dei presuntuosi ignoranti che non sapevano di essere tali. «Allora capii, dice Socrate, che veramente io ero il più sapiente perché ero l’unico a sapere di non sapere, a sapere di essere ignorante. In seguito quegli uomini, che erano coloro che governavano la città, messi di fronte alla loro pochezza presero ad odiare Socrate».
«Ecco perché ancora oggi io vo d’intorno investigando e ricercando…se ci sia alcuno…che io possa ritenere sapiente; e poiché sembrami che non ci sia nessuno, io vengo così in aiuto al dio dimostrando che sapiente non esiste nessuno». Egli quindi “investigando e ricercando” conferma l’oracolo del dio, mostrando così l’insufficienza della classe politica dirigente. Da qui le accuse dei suoi avversari: egli avrebbe suscitato la contestazione giovanile insegnando con l’uso critico della ragione a rifiutare tutto ciò che si vuole imporre per la forza della tradizione o per una valenza religiosa. Socrate in realtà (sempre secondo la testimonianza di Platone) non intendeva affatto contestare la religione tradizionale, né corrompere i giovani incitandoli alla sovversione.
LA SCOPERTA DELL’ANIMA UMANA
Secondo l’interpretazione data da John Burnet (1863-1928), Alfred Edward Taylor (1869-1945), Werner Jaeger, anche se non condivisa da tutti, Socrate fu di fatto il primo filosofo occidentale a porre in risalto il carattere personale dell’anima umana. È l’anima, infatti, a costituire la vera essenza dell’uomo. Sebbene la tradizione orfica e pitagorica avessero già identificato l’uomo con la sua anima, in Socrate questa parola risuona in forma del tutto nuova e si carica di significati antropologici ed etici: « Tu, ottimo uomo, poiché sei ateniese, cittadino della Polis più grande e più famosa per sapienza e potenza, non ti vergogni di occuparti delle ricchezze, per guadagnarne il più possibile, e della fama e dell’onore, e invece non ti occupi e non ti dai pensiero della saggezza, della verità, e della tua anima, perché diventi il più possibile buona? » (Apologia di Socrate)
Mentre gli Orfici e i Pitagorici consideravano l’anima ancora alla stregua di un demone divino, Socrate la fa coincidere con l’io, con la coscienza pensante di ognuno, di cui egli si propone come maestro e curatore. Non sono i sensi ad esaurire l’identità di un essere umano, come insegnavano i sofisti, l’uomo non è corpo ma anche ragione, conoscenza intellettiva, che occorre rivolgere ad indagare la propria essenza. Non solo Platone in diversi passi dei suoi dialoghi, ma anche la cosiddetta tradizione “indiretta” testimoniano come Socrate, al contrario dei sofisti, riconducesse la cura dell’anima alla conoscenza dell’intima natura umana nel senso su indicato. Socrate affermava di credere, oltre agli dèi riconosciuti dalla polis, anche in una particolare divinità minore, appartenente alla mitologia tradizionale, che egli indicava con il nome di dáimōn. Il dáimon per Socrate non aveva il significato anche negativo che altri autori greci classici evidenzieranno ma era un essere divino inferiore agli dèi ma superiore agli uomini che possiamo intendere anche con il termine genio. Socrate si diceva tormentato da questa voce interiore che si faceva sentire non tanto per indicargli come pensare e agire, ma piuttosto per dissuaderlo dal compiere una certa azione.
CONOSCI TE STESSO
Il motto (“Gnòthi seautòn, «Conosci te stesso»), risalente alla tradizione religiosa di Delfi, voleva significare, nella sua laconica brevità, la caratteristica dell’antica sapienza greca: quella dei sette sapienti. Il significato originario, dedotto da alcune formule a noi pervenute (Nulla di troppo, Ottima è la misura, Non desiderare l’impossibile), era quello di voler ammonire a conoscere i propri limiti, «conosci chi sei e non presumere di essere di più»; era dunque una esortazione a non cadere negli eccessi, a non offendere la divinità pretendendo di essere come il dio. Del resto tutta la tradizione antica mostra come l’ideale del saggio, colui che possiede la sophrosyne (“saggezza”), sia quello di conseguire la moderazione e di rifuggire il suo opposto: la tracotanza e la superbia.
LA MAIEUTICA
Il termine maieutica viene dal greco maieutiké (sottinteso: téchne). Letteralmente, sta per “l’arte della levatrice” (o “dell’ostetrica”), ma l’espressione designa il metodo socratico così come è esposto da Platone nel Teeteto. L’arte dialettica, cioè, viene paragonata da Socrate a quella della levatrice, il mestiere di sua madre: come quest’ultima, il filosofo di Atene intendeva “tirar fuori” all’allievo pensieri assolutamente personali, al contrario di quanti volevano imporre le proprie vedute agli altri con la retorica e l’arte della parola come facevano i sofisti. Parte integrante di questo metodo è il ricorso a battute brevi (brachilogia) in opposizione ai lunghi discorsi (macrologia) del metodo retorico dei sofisti.
DIFFERENZE CON I SOFISTI
Socrate, a differenza dei sofisti, mirava a convincere l’interlocutore non ricorrendo ad argomenti retorici e suggestivi, ma sulla base di argomenti razionali. Socrate si presenta così come una persona anticonformista, che in opposizione alle convinzioni della folla rifugge il consenso e l’omologazione: garanzia di verità è per lui non la condivisione irriflessa, ma la ragione che porta alla reciproca persuasione. Si è detto inoltre come egli non lasciò niente di scritto della sua filosofia perché pensava che la parola scritta fosse come il bronzo che percosso dà sempre lo stesso suono. Lo scritto non risponde alle domande e alle obiezioni dell’interlocutore, ma interrogato dà sempre la stessa risposta. Per questo i dialoghi socratici appaiono spesso “inconcludenti”, nel senso non che girano a vuoto, ma piuttosto che non chiudono la discussione, perché la conclusione rimane sempre aperta, pronta ad essere rimessa nuovamente in discussione.
Come è stato evidenziato tuttavia, la filosofia stessa di Socrate segna il passaggio da un tipo di cultura orale, basata sulla tradizione mimetico-poetica, ad una mentalità di tipo concettuale-dialettico, preludio di un’alfabetizzazione maggiormente diffusa. Socrate è ancora l’ultimo rappresentante della cultura orale, ma in lui già si avvertirebbe l’esigenza di un sapere astratto e definitivo, da esprimere in forma scritta, esigenza che sarà fatta propria da Platone che d’altra parte conserverà nello scritto filosofico la forma dialogica che svanirà nelle opere della vecchiaia dove il dialogo sarà semplicemente quello dell’anima con se stessa. Lo stesso Platone d’altronde affermava che la sua filosofia va ricercata altrove rispetto ai suoi scritti. Il fatto che Socrate preferisse il discorso orale a quello scritto è il motivo per cui egli era stato confuso con i sofisti. Secondo Platone è questa una delle colpe di Socrate: lui che era vero sapiente si dichiarava ignorante e i sofisti, veri ignoranti, facevano professione di sapienza. In questo modo il maestro contribuiva a confondere il vero ruolo della filosofia ed egli stesso al processo, pur avendo rifiutato l’aiuto di un celebre “avvocato” sofista, per l’abitudine di dialogare con chiunque in strada e nei più diversi luoghi, era stato ritenuto dagli ateniesi un sofista.
MAESTRO DELLA PAIDEIA
È pur vero che Socrate come i sofisti metteva in discussione un certo modo di intendere l’ideale educativo della paideia, ma con intenti del tutto opposti: i sofisti con lo scopo di dissolverlo, Socrate invece con lo scopo di tutelarlo. La paideia esaltava lo spirito di cittadinanza e di appartenenza costituendolo come elemento fondamentale alla base dell’ordinamento politico-giuridico delle città greche. L’identità dell’individuo era pressoché inglobata da quell’insieme di norme e valori che costituivano l’identità del popolo stesso: per questo più che un procedimento educativo o di socializzazione potrebbe essere definito come processo di uniformazione all’ethos politico. La dottrina dei sofisti si poneva contro questa omologazione della paideia, da essi giudicata “conservatrice” e prevaricatrice; essi miravano perciò a contestarne la verità, tramite l’arte della retorica e a far apparire vero ciò che a loro conveniva, prevalendo con la parola sull’altro e ad annullare qualsiasi valore di verità e giustizia sostituendovi il proprio egoistico interesse. Socrate invece voleva piuttosto verificare e smascherare se sotto quell’ideale educativo non vi fosse quello di addormentare le coscienze critiche a scopi di potere personale. Ed è così che la scoperta socratica dell’anima umana assume toni decisamente educativi e morali. Secondo Platone, infatti, Socrate è l’unico che intende correttamente il senso della politica, come capacità di rendere migliori i cittadini. Socrate li esorta a occuparsi, più che delle cose della città, della città stessa. In lui c’è pertanto uno stretto legame tra filosofia e politica, che in Platone diventerà esplicito, ma in Socrate già affiora come esigenza di anteporre sempre il bene della città e il rispetto delle leggi agli egoismi dei singoli.
« Questo, vedete, è il comandamento che mi viene da Dio. E sono convinto che la mia patria debba annoverare fra i benefici più grandi questa mia dedizione al volere divino. Tutta la mia attività, lo sapete, è questa: vado in giro cercando di persuadere giovani e vecchi a non pensare al fisico, al denaro con tanto appassionato interesse. Oh! pensate piuttosto all’anima: cercate che l’anima possa divenir buona, perfetta. » (Apologia di Socrate)
BRACHILOGIA ED IRONIA
D’altra parte è vero che anche lui esaltava la parola, ma, al contrario dei sofisti che usavano il monologo e che praticamente parlavano da soli, il suo discorrere era un dià logos, una parola che attraversava i due interlocutori. Mentre i sofisti infatti miravano ad abbindolare l’interlocutore usando il macròs logos, il grande e lungo discorso che non dava spazio alle obiezioni, Socrate invece dialogava con brevi domande e risposte – la cosiddetta brachilogia (letteralmente “breve dialogare”) socratica – proprio per dare la possibilità di intervenire e obiettare ad un interlocutore che egli rispettava per le sue opinioni. Un’altra caratteristica del dialogo socratico, che lo distingueva dal discorso torrentizio dei sofisti, era il continuo domandare di Socrate su quello che stava affermando l’interlocutore; sembrava quasi che egli andasse alla ricerca di una precisa definizione dell’oggetto del dialogo. «Ti estì» ,”che cos’è” [quello di cui parli]? È questa l’ironia di Socrate che, per non demotivare l’interlocutore e per fare in modo che egli senza imposizioni si convinca, finge di non sapere quale sarà la conclusione del dialogo, accetta le tesi dell’interlocutore e le prende in considerazione, portandola poi ai limiti dell’assurdo in modo che l’interlocutore stesso si renda conto che la propria tesi non è corretta. Chi dialoga con Socrate tenterà varie volte di dare una risposta precisa ma alla fine si arrenderà e sarà costretto a confessare la sua ignoranza. Proprio questo sin da principio sapeva e voleva Socrate: la sua non era fastidiosa pedanteria ma il voler dimostrare che la presunta sapienza dell’interlocutore fosse in realtà ignoranza.
LE ACCUSE POLITICHE
«… questo ha sotto scritto e giurato Meleto di Meleto, Pitteo, contro Socrate di Sofronisco, Alopecense. Socrate è colpevole di non riconoscere come Dei quelli tradizionali della città, ma di introdurre Divinità nuove; ed è anche colpevole di corrompere i giovani. Pena: la morte». (lettera d’accusa contro Socrate presentata da Meleto in Diogene Laerzio, Vita e dottrine dei filosofi, II, 5, 40.)
Il continuo dialogare di Socrate, attorniato da giovani affascinati dalla sua dottrina e da importanti personaggi, nelle strade e piazze della città fece sì che egli venisse scambiato per un sofista dedito ad attaccare imprudentemente e direttamente i politici. Il filosofo, infatti, dialogando con loro dimostrò come la loro vantata sapienza in realtà non esistesse. Socrate venne quindi ritenuto un pericoloso nemico politico che contestava i tradizionali valori cittadini. Per questo Socrate, che aveva attraversato indenne i regimi politici precedenti, che era rimasto sempre ad Atene e che non aveva mai accettato incarichi politici, fu accusato e messo sotto processo, dal quale poi sarebbe derivata la sua condanna a morte. Causa materiale del processo furono due esponenti di rilievo del regime democratico, Anito e Licone, i quali, servendosi di un prestanome, Meleto, un giovane ambizioso, fallito letterato, accusarono il filosofo di:
- corrompere i giovani insegnando dottrine che propugnavano il disordine sociale;
- non credere negli dei della città e tentare di introdurne di nuovi.
L’accusa di “ateismo”, che rientrava in quella di “empietà” (asebia), condannato da un decreto di Diopeithes all’incirca nel 430 a.C., fu evidentemente un pretesto giuridico per un processo politico, poiché l’ateismo era sì ufficialmente riprovato e condannato ma tollerato e ignorato se affermato privatamente. Poiché la religione e la cittadinanza erano ritenute un tutt’uno, accusando Socrate di ateismo lo si incolpò di avere cospirato contro le istituzioni e l’ordine pubblico. D’altra parte Socrate non aveva mai negato l’esistenza degli dei della città ed eluse facilmente l’accusa sostenendo di credere in un dáimon, creatura minore figlia delle divinità tradizionali. Lisia si offrì di difendere Socrate, ma egli rifiutò probabilmente perché non voleva confondersi con i sofisti e preferì difendersi da solo. Descritto da Platone nella celebre Apologia di Socrate, il processo evidenziò due elementi:
- che da chi non lo conosce, Socrate è stato confuso con i sofisti considerati corruttori morali dei giovani e
- che egli era odiato dai politici.
Riguardo all’accusa di corrompere i giovani essa va spiegata col fatto che Socrate era stato maestro di Crizia e di Alcibiade, due personaggi che nell’Atene della restaurazione democratica godevano di pessima fama. Crizia era stato il capo dei Trenta tiranni e Alcibiade, per sfuggire al processo che gli era stato intentato, aveva tradito Atene ed era passato a Sparta, combattendo contro la propria patria. Furono tali rapporti di educatore che ebbe con questi due personaggi a porre le basi dell’accusa di corrompere i giovani.
IL PROCESSO
Il processo si tenne nel 399 a.C. innanzi a una giuria di 501 cittadini di Atene, e – com’era da aspettarsi per una figura come quella di Socrate – fu atipico: egli si difese contestando le basi del processo, anziché lanciarsi in una lunga e pregevole difesa o portando in tribunale la sua famiglia per impietosire i giudici, come di solito si faceva. Fu riconosciuto colpevole per uno stretto margine di voti – appena trenta. Dopodiché, come previsto dalle leggi dell’Agorà, sia Socrate che Meleto dovettero proporre una pena per i reati di cui l’imputato era stato accusato. Socrate sfidò i giudici proponendo loro di essere mantenuto a spese della collettività nel Pritaneo, poiché riteneva che anche a lui dovesse essere riconosciuto l’onore dei benefattori della città, avendo insegnato ai giovani la scienza del bene e del male. Poi consentì di farsi multare – seppur di una somma ridicola (una mina d’argento dapprima, cioè tutto quello che egli possedeva; trenta mine poi, sotto pressione dei suoi seguaci, che si fecero garanti per lui). Meleto chiese invece la morte. Furono messe ai voti le proposte: con ampia maggioranza – 360 voti a favore contro 140 contrari – gli ateniesi, più per l’impossibilità di punire Socrate, multandolo di una somma così ridicola, che per effettiva volontà di condannarlo a morte, accolsero la proposta di Meleto e lo condannarono a morire mediante l’assunzione di cicuta. Era pratica diffusa autoesiliarsi dalla città pur di sfuggire alla sentenza di morte, ed era probabilmente su questo che contavano gli stessi accusatori. Socrate dunque intenzionalmente irritò i giudici, che non erano in realtà mal disposti verso di lui. Ma perché lo fece? Socrate in effetti aveva già deciso di non andare in esilio, in quanto anche fuori di Atene avrebbe persistito nella sua attività: dialogare con i giovani e mettere in discussione tutto quello che si vuol far credere verità certa. «Perciò, – sostenne Socrate, – mi ritroverò a rivivere la stessa situazione che mi ha portato alla condanna: qualcuno dei parenti dei miei giovani discepoli si irriterà della mia ricerca della verità e mi accuserà». Del resto egli non temeva la morte, che nessuno sa se sia o no un male, ma la preferiva all’esilio, questo sì un male sicuro.
ACCETTAZIONE DELLA CONDANNA
Come racconta Platone nel dialogo del Critone, Socrate, pur sapendo di essere stato condannato ingiustamente, una volta in carcere rifiutò le proposte di fuga dei suoi discepoli, che avevano organizzato la sua evasione corrompendo i carcerieri. Ma Socrate non sfuggirà alla sua condanna poiché «è meglio subire ingiustizia piuttosto che farla», egli accetterà la morte che d’altra parte non è un male perché o è un sonno senza sogni, oppure darà la possibilità di visitare un mondo migliore dove, dice Socrate, s’incontreranno interlocutori migliori con cui dialogare. Quindi egli continuerà persino nel mondo dell’aldilà a professare quel principio a cui si è attenuto in tutta la sua vita: il dialogo.
LA MORTE DI SOCRATE
« È giunto ormai il tempo di andare, o giudici, io per morire, voi per continuare a vivere. Chi di noi vada verso una sorte migliore, è oscuro a tutti, tranne che al Dio. »

Morte di Socrate
La morte di Socrate ci viene dettagliatamente descritta da Platone, che tuttavia non era presente alla fine del maestro, nel dialogo del Fedone. Socrate trascorre serenamente, secondo le sue abitudini, la sua ultima giornata in compagnia dei suoi amici e discepoli, dialogando di filosofia come aveva sempre fatto, e in particolare affrontando il problema dell’immortalità dell’anima e del destino dell’uomo nell’aldilà. Quindi Socrate si reca in una stanza a lavarsi per evitare alle donne il fastidio di accudire al suo cadavere. Tornato nella cella, dopo aver salutato i suoi tre figlioli (Sofronisco, dal nome del nonno, Lamprocle e il piccolo Menesseno) e le donne di casa, li invita ad andarsene. Scende il silenzio nella prigione sino a quando giunge il messo degli Undici ad annunciare a quel singolare prigioniero, così diverso dagli altri, come egli dice, per la sua gentilezza, mitezza e bontà, che è giunto il tempo di morire. L’amico Critone vorrebbe che il maestro, come hanno sempre fatto gli altri condannati a morte, rimandasse ancora l’ultima ora poiché non è ancora il tramonto, il tempo stabilito dalla condanna, ma Socrate:
«È naturale che costoro facciano così perché credono d’aver qualcosa da guadagnare…[io] credo di non aver altro da guadagnare, bevendo un poco più tardi [il veleno], se non di rendermi ridicolo a’ miei stessi occhi, attaccandomi alla vita e facendone risparmio quando non c’è più niente da risparmiare… » (Platone, Apologia di Socrate)
Giunto il carceriere incaricato della somministrazione della cicuta Socrate si rivolge a lui, poiché in questo “dialogo” è lui il più “sapiente”, chiedendogli che cosa si deve fare e se si può libare a un qualche dio. Il boia risponde che basta bere il veleno che è della giusta quantità per morire e non è quindi possibile usarne una parte per onorare gli dei. Socrate allora dice che si limiterà a pregare la divinità perché gli assicuri un felice trapasso e, così detto, beve la pozione. Gli amici a questo punto si abbandonano alla disperazione ma Socrate li rimprovera facendo, lui che sta morendo, a loro coraggio: «Che stranezza è mai questa, o amici, Non per altra ragione io feci allontanare le donne perché non commettessero di tali discordanze. E ho anche sentito dire che con parole di lieto augurio bisogna morire. Orsù dunque state quieti e siate forti ». Il paralizzarsi e il raffreddarsi delle membra, divenute insensibili, dai piedi verso il torace, segnala il progressivo avanzare del veleno: «E ormai intorno al basso ventre era quasi tutto freddo; ed egli si scoprì – perché s’era coperto – e disse, e fu l’ultima volta che udimmo la sua voce: «O Critone, noi siamo debitori di un gallo ad Asclepio: dateglielo e non dimenticatevene!»
IL GALLO DI ASCLEPIO
Queste ultime parole di Socrate morente hanno dato luogo a varie interpretazioni da parte degli studiosi: quella più semplice e diffusa è che egli, che non vuole lasciare debiti irrisolti né con gli uomini né con gli dei, prega Critone di ringraziare per suo conto il dio Asclepio (l’Esculapio per i romani) per avergli reso la morte indolore.
PLATONE
Platone (Atene, 428 a.C./427 a.C. – Atene, 348 a.C./347 a.C.) è stato un filosofo ateniese. Assieme al suo maestro Socrate e al suo allievo Aristotele ha posto le basi del pensiero filosofico occidentale. Nacque ad Atene da genitori aristocratici: il padre Aristone, che vantava tra i suoi antenati Codro, l’ultimo leggendario re d’Atene, gli impose il nome del nonno, cioè Aristocle; anche la madre, Perittione, secondo Diogene Laerzio, discendeva dal famoso legislatore Solone. La sua data di nascita viene fissata da Apollodoro di Atene, nella sua Cronologia, all’ottantottesima Olimpiade, nel settimo giorno del mese di Targellione, ossia alla fine di maggio del 428 a.C. Ebbe due fratelli, Adimanto e Glaucone, citati nella sua Repubblica, e una sorella, Potone, madre di Speusippo, futuro allievo e successore, alla sua morte, alla direzione dell’Accademia di Atene.

Platone
Fu un altro Aristone, un lottatore di Argo, suo maestro di ginnastica, a chiamarlo Platone (dal greco πλατύς, platýs, che significa “ampio”) date le ampie spalle; altri danno del nome un’altra derivazione, come l’ampiezza della fronte o la maestà dello stile letterario. Diogene Laerzio, riferendosi ad Apuleio, a Olimpiodoro e a Eliano, informa che avrebbe coltivato la pittura e la poesia, scrivendo ditirambi, liriche e tragedie, che avrebbero avuto in seguito, insieme ai mimi, un’importanza fondamentale per la scrittura dei suoi dialoghi.
I VIAGGI E L’INCONTRO CON SOCRATE
Frequentò l’eracliteo Cratilo e il parmenideo Ermogene, ma non è certo se la notizia sia reale o se voglia giustificare la sua successiva dottrina, influenzata sotto diversi aspetti dal pensiero dei suoi due grandi predecessori, Eraclito e Parmenide, da lui considerati gli autentici fondatori della filosofia. Avrebbe partecipato a tre spedizioni militari, durante la guerra del Peloponneso, a Tanagra, a Corinto e a Delio, dal 409 a.C. al 407 a.C., anno in cui, conosciuto Socrate, avrebbe distrutto tutte le sue composizioni poetiche per dedicarsi completamente alla filosofia. Fondamentale il suo incontro con Socrate che, dopo la parentesi del governo, oligarchico e filo-spartano, dei Trenta tiranni, del quale faceva parte lo zio di Platone Crizia, fu accusato dal nuovo governo democratico di empietà e di corruzione dei giovani e condannato a morte nel 399 a.C. Dopo la morte del maestro sarebbe andato a Megara insieme con altri allievi di Socrate, poi a Cirene, frequentando il matematico Teodoro di Cirene e ancora in Italia, dai pitagorici Filolao ed Eurito. Di qui, si sarebbe recato in Egitto, dove i sacerdoti l’avrebbero guarito da una malattia. Ma la fondatezza della notizia di questi viaggi è molto dubbia.
I PRIMI DIALOGHI
A partire dal 395 a.C. Platone dovrebbe aver iniziato a scrivere i primi dialoghi, nei quali affronta il problema culturale rappresentato dalla figura di Socrate e la funzione dei sofisti: nascono così, in un possibile ordine cronologico:
- l’Apologia (il suo primo dialogo);
- il Critone, in cui Socrate discute la legittimità delle leggi;
- lo Ione, parodia ironica di poeti;
- l’Eutifrone;
- il Carmide;
- il Lachete;
- il Liside;
- l’Alcibiade I;
- l’Alcibiade II (queste due attribuzioni a Platone sono tuttavia discusse);
- l’Ippia Maggiore;
- l’Ippia Minore;
- il Trasimaco (che confluirà nella Repubblica come primo libro);
- il Menesseno;
- il Protagora;
- il Gorgia.
IL PRIMO VIAGGIO A SIRACUSA
Certo è invece che Platone, intorno al 388 a.C., dopo aver conosciuto il pitagorico Archita, governatore di Taranto, sia stato a Siracusa, governata da Dionigi I, dove strinse amicizia col cognato del tiranno, Dione, che guardò con favore ai programmi politici di Platone. Ma opposto fu l’atteggiamento di Dionigi che costrinse Platone ad abbandonare Siracusa per Atene; fatto sbarcare nell’isola di Egina, nemica di Atene, vi venne fatto prigioniero e reso schiavo; per sua fortuna, il socratico Anniceride di Cirene lo riscattò. Ma anche quest’episodio, narrato con varianti da Diogene Laerzio, è molto dubbio.
LA FONDAZIONE DELL’ACCADEMIA
Platone è ad Atene; acquistato un parco dedicato ad Academo, vi fonda una scuola che intitola Accademia in onore dell’eroe e la consacra ad Apollo e alle Muse. Sull’esempio opposto a quello della scuola fondata da Isocrate nel 391 a.C. e basata sull’insegnamento della retorica, la scuola di Platone ha le sue radici nella scienza e nel metodo da essa derivato, la dialettica; per questo motivo, l’insegnamento si svolge attraverso dibattiti, a cui partecipano gli stessi allievi, diretti da Platone o dagli allievi più anziani, e conferenze tenute da illustri personaggi di passaggio ad Atene. In vent’anni, dalla creazione dell’Accademia al 367 a.C., Platone scrive i dialoghi in cui si sforza di determinare le condizioni che permettono la fondazione della scienza; tali sono:
- il Clitofonte (tuttavia di incerta attribuzione);
- il Menone;
- il Fedone;
- l’Eutidemo;
- il Convito;
- la Repubblica;
- il Cratilo;
- il Fedro;
- il Clitofonte (tuttavia di incerta attribuzione);
- il Menone;
- il Fedone;
- l’Eutidemo;
- il Convito;
- la Repubblica;
- il Cratilo;
- il Fedro.
IL SECONDO VIAGGIO A SIRACUSA
Nel 364 a.C., poco prima dell’arrivo di Aristotele nell’Accademia, Platone è a Siracusa, invitato da Dione che, con la morte di Dionigi il Vecchio e la successione al potere di suo nipote Dionigi il Giovane, conta di poter attuare le riforme impedite dal precedente tiranno. Ma i contrasti con Dionigi, che sospetta nello zio intenzioni di ribellione, portano all’esilio di Dione: Platone può tuttavia rimanere a Siracusa come consigliere di Dionigi e coltivare i suoi progetti di trasformazione istituzionale dello Stato siracusano. Nel 365 a.C. Siracusa è in guerra e Platone torna ad Atene, con la promessa di poter tornare a Siracusa alla fine della guerra insieme con Dione. Ad Atene scrive il Parmenide, il Teeteto, e il Sofista.
IL TERZO VIAGGIO IN SICILIA
Nel 361 a.C. Platone compie il suo terzo e ultimo viaggio in Sicilia. Non c’è però Dione, verso il quale Dionigi manifesta un’aperta ostilità; i tentativi di Platone di difendere l’amico portano alla rottura dei rapporti con il tiranno siracusano che arriva a imprigionare il filosofo. Liberato grazie all’intervento di Archita, il pitagorico tiranno di Taranto, amico di entrambi, nel 360 a.C. Platone può ripartire per Atene; durante il viaggio sbarca a Olimpia per incontrare per l’ultima volta Dione. Questi progettava una guerra contro Dionigi, dalla quale Platone cercò invano di dissuaderlo: nel 357 a.C. riuscirà a impadronirsi del potere a Siracusa ma vi sarà ucciso tre anni dopo. Ad Atene Platone scrisse le ultime opere:
- il Timeo;
- il Crizia;
- il Politico;
- il Filebo;
- le Leggi.
Morì nel 347 a.C. e la guida dell’Accademia venne assunta dal nipote Speusippo. La scuola sopravviverà fino al 529 d.C., anno in cui venne definitivamente chiusa da Giustiniano dopo vari periodi di alterne interruzioni della sua attività.
OPERE
Di Platone sono pervenute tutte le opere, che comprendono 36 dialoghi e 13 lettere.
LA SUPERIORITA’ DEL DISCORSO ORALE
Platone si avvale del dialogo perché lo ritiene l’unico strumento in grado di riportare l’argomento alla concretezza storica di un dibattito fra persone e di mettere in luce il carattere di ricerca della filosofia, elemento chiave del suo pensiero. Egli vuole inoltre evidenziare col ricorso al dialogo la superiorità del discorso orale rispetto allo scritto. Certo la parola scritta è più precisa e meditata rispetto all’oralità, ma mentre questa permette un immediato scambio di opinioni sul tema in discussione quella scritta interrogata non risponde. In genere, si suole riunire i dialoghi platonici in vari gruppi. Secondo una linea interpretativa piuttosto datata, i primi dialoghi sarebbero caratterizzati dalla viva influenza di Socrate (primo gruppo); quelli della maturità in cui avrebbe sviluppato la teoria delle idee (secondo gruppo); e l’ultimo periodo quando sentì l’urgenza di difendere la propria concezione dagli attacchi alla sua filosofia, attuando una profonda autocritica della teoria delle idee (terzo gruppo). Secondo il nuovo paradigma interpretativo introdotto dalla scuola di Tubinga e di Milano, invece, i dialoghi platonici, al di là dello stile in evoluzione, presentano una coerenza sistematica di fondo, dove la dottrina delle idee, per quanto importante, non costituisce più la parte fondamentale del mondo sovrasensibile. Lo stile, che imita fedelmente la peculiarità del dialogo socratico, muta notevolmente da un periodo all’altro: nei periodi giovanili si hanno interventi brevi e briosi che danno vivacità al dibattito; negli ultimi, invece, vi sono interventi lunghi, che danno all’opera il carattere di un trattato e non di un dibattito, trattandosi piuttosto di un dialogo dell’anima con se stessa, ma senza giungere mai a esporre compiutamente la propria dottrina in forma di scienza assoluta. La rinuncia, come già in Socrate, a comunicare in forma scritta il nucleo della propria dottrina porterebbe per di più a pensare che non solo la scrittura, ma anche l’oralità non fosse per Platone in grado di trasmetterla. In genere il protagonista dei dialoghi è Socrate; soltanto negli ultimi dialoghi costui assume una parte secondaria, fino a scomparire del tutto nell’Epinomide e nelle Leggi. La caratteristica di questi dialoghi è che il soggetto principale che dà il titolo all’opera è solito discorrere molto più dell’interlocutore a cui si rivolge, il quale si limita solamente a confermare o disapprovare quello che il protagonista espone.
ORDINAMENTO IN TRILOGIE
Una diversa, e più antica classificazione risale ad Aristofane di Bisanzio (III secolo a.C.), che ordinò le opere platoniche in cinque trilogie:
- Repubblica, Timeo, Crizia
- Sofista, Politico, Cratilo
- Leggi, Minosse, Epinomide
- Teeteto, Eutifrone, Apologia di Socrate
- Critone, Fedone, Lettere
FILOSOFIA E POLITICA
Quella che in termini storici possiamo chiamare “filosofia platonica” – ovvero il corpus di idee e di testi che definiscono la tradizione storica del pensiero platonico – è sorta dalla riflessione sulla politica. Come scrive Alexandre Koyré: «tutta la vita filosofica di Platone è stata determinata da un avvenimento eminentemente politico, la condanna a morte di Socrate». Occorre tuttavia distinguere la “riflessione sulla politica” dall'”attività politica”. Non è certo in quest’ultima accezione che dobbiamo intendere la centralità della politica nel pensiero di Platone. Come egli scrisse, in tarda età, nella Lettera VII del suo epistolario, proprio la rinuncia alla politica attiva segna la scelta per la filosofia, intesa però come impegno “civile”. La riflessione sulla politica diventa, in altre parole, riflessione sul concetto di giustizia, e dalla riflessione su questo concetto sorge un’idea di filosofia intesa come processo di crescita dell’Uomo come membro organicamente appartenente alla polis. Fin dalle prime fasi di questa riflessione, appare chiaro che per il filosofo ateniese risolvere il problema della giustizia significa affrontare il problema della conoscenza. Da qui la necessità di intendere la genesi del “mondo delle idee” come frutto di un impegno “politico” più complessivo e profondo.
IL PROBLEMA SOCRATE
La capacità di agire secondo giustizia presuppone, socraticamente, la conoscenza di che cosa è il bene. Solo questo sapere contraddistingue il filosofo come tale,] poiché chi compie il male lo fa per ignoranza. Ad Atene c’era molta confusione sulla figura del filosofo, ed in un certo senso lo stesso Socrate aveva alimentato questa confusione: presentandosi infatti come colui che sapeva di non sapere, professava una falsa ignoranza che nascondeva una vera sapienza. Egli si confondeva così con i sofisti, i quali dicevano di sapere ma in effetti non sapevano, perché non credevano nella verità. Per dirimere questa confusione, per Platone era necessario andare oltre Socrate, delineando con chiarezza i criteri che distinguono il filosofo dal sofista: mentre il primo ricerca i principi della verità, senza la presunzione di possederla, il secondo si lascia guidare dall’opinione, facendone l’unico parametro valido della conoscenza. L’altro problema legato alla figura di Socrate è la sua condanna a morte, cioè il fatto che sia stato trattato come un criminale pur essendo «il più giusto» tra gli uomini. Ciò significò per Platone dover constatare che tra filosofia e vita politica esisteva quell’incompatibilità già conosciuta da Socrate che nella Apologia accenna alla quasi ineluttabilità della sua condanna da parte dei politici e rifiuta la proposta di andare in esilio. Compito dei filosofi è allora quello di fare in modo che la filosofia non sia in contrasto con lo stato, dove non accada più che un giusto sia condannato a morte.
ARISTOTELE
Aristotele (Aristotéles; Stagira, 384 a.C. o 383 a.C. – Calcide, 322 a.C.) è stato uno scienziato e filosofo greco antico, noto come il “filosofo dell’immanenza”. È considerato una delle menti filosofiche più innovative, prolifiche e influenti del mondo antico occidentale, dove era stimato come l’emblema dell’uomo sapiente per la vastità dei suoi campi di conoscenza, di cui fu un precursore di scoperte.

Aristotele
Aristotele nacque nel 384/3 a.C. a Stagira, l’attuale Stavro, città macedone nella penisola Calcidica, situata sulla costa nord-orientale della Grecia. Si dice che il padre, Nicomaco, sia vissuto presso Aminta, re dei Macedoni, prestandogli i servigi di medico e di amico. Aristotele, come figlio del medico reale, doveva pertanto risiedere nella capitale del Regno di Macedonia, Pella. Fu probabilmente per l’attività di assistenza al lavoro del padre che Aristotele fu avviato alla conoscenza della fisica e della biologia, aiutandolo nelle dissezioni anatomiche. Secondo gli studiosi la biografia di Aristotele può essere suddivisa in tre periodi. Il primo periodo ebbe inizio quando, rimasto orfano in tenera età, dovette trasferirsi dal tutore Prosseno ad Atarneo, cittadina dell’Asia Minore nella regione della Misia situata nel nord-ovest dell’attuale Turchia, di fronte all’isola di Lesbo. Prosseno, verso il 367 a.C., lo mandò ad Atene per studiare nell’Accademia fondata da Platone circa vent’anni prima, dove rimarrà fino alla morte del suo maestro. Aristotele non fu dunque mai un cittadino di Atene, ma un meteco. Quando il diciassettenne Aristotele entra nell’Accademia, Platone è a Siracusa da un anno, su invito di Dione, parente di Dionigi I, e tornerà ad Atene solo nel 364 a.C.; in questi anni, secondo l’impostazione didattica dell’Accademia, Aristotele dovette iniziare con lo studio della matematica, per passare tre anni dopo alla dialettica. A reggere la scuola è Eudosso di Cnido, uno scienziato che dovette molto influenzare il giovane studente che, molti anni dopo, nell’Etica Nicomachea scriverà che i ragionamenti di Eudosso «avean acquistato fede più per la virtù dei suoi costumi che per se stessi: appariva di un’insolita temperanza, sembrando ragionare, nell’identificare il bene col piacere, non perché amante del piacere, ma perché pensava che la cosa stesse veramente così».
L’ABBANDONO DELL’ACCADEMIA
Il secondo periodo ha inizio quando nel 347 a.C. muore Platone e alla direzione dell’Accademia, più per motivi economici che per meriti riconosciuti, viene chiamato Speusippo, nipote del grande filosofo ateniese. Aristotele, che evidentemente doveva ritenersi più degno di costui, lascia la scuola insieme con Senocrate, altro pretendente alla guida dell’Accademia, per ritornare ad Atarneo, dove aveva trascorso l’adolescenza, invitato da Ermia, allora tiranno della città. Ermia era stato già da lui conosciuto ai tempi dell’Accademia, ed era poi riuscito con un rovesciamento politico a diventare successore di Eubulo, signore di Atarneo, e ad impossessarsi di Asso. Nella corte di Ermia Aristotele ritrova altri due ex allievi di Platone, Erasto e Coristo. Nello stesso anno tutti e quattro si trasferiscono ad Asso, divenuta intanto la nuova sede della corte, dove fondano una scuola che Aristotele battezza come unica vera scuola platonica. Ad essa aderiscono anche il figlio di Coristo, Neleo, e il futuro successore di Aristotele nella scuola di Atene, Teofrasto, suo brillante allievo. Nel 344 a.C., su invito dello stesso Teofrasto, Aristotele va a Mitilene, sull’isola di Lesbo, dove fonda un’altra scuola, anch’essa battezzata come la sola aderente ai canoni platonici. V’insegna fino al 342, anno in cui è chiamato a Pella, in Macedonia dal re Filippo II perché faccia da precettore al figlio Alessandro Magno. Aristotele svolgerà questo incarico per circa tre anni, fino a quando Alessandro non sarà chiamato a partecipare alle spedizioni militari del padre. Non sappiamo molto dell’educazione che Aristotele impartisce ad Alessandro ma si suppone che le lezioni si basassero prevalentemente sui fondamenti della cultura greca (a partire da Omero) facendo così di Alessandro un uomo greco per gli ideali trasmessigli, ma anche soprattutto sulla politica, dato il destino che attendeva Alessandro. È inoltre possibile che durante questo incarico Aristotele abbia concepito il progetto di una grande raccolta di Costituzioni.
LA FONDAZIONE DEL PERIPATO (LICEO)
Quando nel 340 a.C. Alessandro diviene reggente del regno di Macedonia, cominciando anche ad avvicinarsi alla cultura orientale, il suo maestro Aristotele, che è intanto rimasto vedovo e convive con la giovane Erpillide da cui ha avuto il figlio Nicomaco, nell’ultimo periodo della sua vita torna forse a Stagira e, intorno al 335 a.C., si trasferisce ad Atene, dove in un pubblico ginnasio, detto Liceo perché sacro ad Apollo Licio, fonda una sua famosissima e celebrata scuola, chiamata Peripato – passeggiata, dall’uso istituito dallo Stagirita di insegnare passeggiando nel giardino che la circonda. Probabilmente non è Aristotele ad acquistare la scuola; egli l’affitta perché per la città di Atene egli era uno straniero e non aveva diritto di proprietà. La scuola viene inoltre finanziata dallo stesso Alessandro. Aristotele promuove attività di ricerca nella città di Atene soprattutto per quanto riguarda materie scientifiche quali zoologia, botanica, astronomia. Riguardo alla scuola abbiamo notizie vaghe; comunque sappiamo per certo che gli alunni erano chiamati per dieci giorni a dirigere la scuola in prima persona: Aristotele ci teneva a istruire i suoi allievi a questo ruolo. Inoltre i pasti venivano consumati in comune secondo un’usanza dei pitagorici e ogni mese si organizzava un simposio filosofico con giudizio (iudicio) guidato dalla saggezza del maestro. Le lezioni si svolgevano di mattina; di pomeriggio e di sera invece Aristotele teneva, sempre nella scuola, delle conferenze aperte al pubblico; le materie erano appunto di interesse pubblico quindi politica e retorica, ad esempio, ma non materie astratte come la metafisica e la logica. Nel 323 a.C. muore Alessandro Magno e ad Atene si manifestano i mai sopiti odii antimacedoni; Aristotele, guardato con ostilità per il suo legame con la corte macedone, è accusato di empietà: lascia allora Atene e con la famiglia si rifugia a Calcide, la città materna, dove muore l’anno dopo.
IL TESTAMENTO
«Andrà senz’altro bene, ma qualora capitasse qualcosa, Aristotele ha steso le seguenti disposizioni: tutore di tutti, sotto ogni aspetto, dev’essere Antipatro; però, Aristomene, Timarco, Ipparco, Diotele e Teofrasto, se è possibile, si prendano cura dei figli, di Erpillide [la sua convivente] e delle cose da me lasciate, fino all’arrivo di Nicanore. E al momento giusto, mia figlia [Piziade] sia data in sposa a Nicanore […] Se invece Teofrasto vorrà prendersi cura di mia figlia, allora sia padrone lui […]. I tutori e Nicanore, ricordandosi di me, si prendano cura anche di Erpillide, sotto ogni aspetto e anche se vorrà risposarsi, in modo che non sia data in sposa indegnamente, visto che è stata premurosa con me. In particolare, le vengano dati, oltre a quello che ha già ottenuto, anche un tallero d’argento e tre schiave, quelle che vuole, la schiava che già ha e lo schiavo Pirro. E se vorrà abitare a Calcide, le sia data la casa per gli ospiti vicino al giardino; se invece vorrà stare a Stagira, le sia data la mia casa paterna […]. Sia libera Ambracide e le si diano, alle nozze di mia figlia, cinquecento dracme e la giovane serva che già possiede […] Sia liberato Ticone quando mia figlia si dovesse sposare, e così anche Filone, Olimpione e il suo ragazzino. Non vendano nessuno dei giovani schiavi che attualmente mi servono, ma siano impiegati; una volta dell’età giusta, siano liberati, se lo meritano […]. Ovunque sia costruita la mia tomba, là siano portate e deposte le ossa di Piziade, come lei stessa ordinò; dedichino poi anche da parte di Nicanore, se sarà ancora vivo – come ho pregato a suo favore – statue di pietra alte quattro cubiti a Zeus Salvatore e ad Atena Salvatrice a Stagira».
LE OPERE
Degli scritti di Aristotele si sogliono distinguere le opere giovanili, a cui egli cominciò a lavorare già nel 364 a.C., da quelle della maturità.
SULLA RETORICA
Intorno al 360 a.C. il giovane Aristotele scrive la sua prima opera intitolata Grillo o Sulla retorica; in reazione a una serie di scritti di elogio – composti da alcuni retori ateniesi, fra i quali Isocrate, per celebrare Grillo, figlio di Senofonte, morto nel 362 a.C. nella battaglia di Mantinea – lo Stagirita polemizzava contro la retorica come mezzo per agire sugli affetti, sulla parte irrazionale dell’anima. Già Platone, nel Gorgia, aveva sostenuto che la retorica non era un’arte, né una scienza, ma semplicemente una εμπειρία (empeirìa), una pratica persuasiva che può avere successo solo sugli ignoranti. Il successo del Grillo nell’Accademia procurò ad Aristotele l’incarico di tenere un corso di retorica, nel quale, seguendo il Fedro platonico, sostenne che la retorica doveva fondarsi sulla dialettica. A tal proposito si è tramandato negli anni che egli esordì nella prima lezione con la frase: «È cosa turpe tacere e lasciar parlare Isocrate».
SULLE IDEE
Scritto poco dopo il Grillo, il trattato Sulle Idee è andato perduto tranne pochi frammenti, trasmessi da Alessandro d’Afrodisia. Vi si affrontava la difficoltà di intendere il rapporto tra idee e cose, concepito da Platone come partecipazione delle cose alle idee, che da esse sono tuttavia separate. Eudosso sosteneva che tra le idee e le cose non ci fosse né separazione, né partecipazione, bensì mixis, mescolanza: le idee e le cose sono mescolate tra loro. Aristotele non accetta la teoria eudossiana, che non risolve il problema, ma critica anche la teoria platonica della separazione, delle cui aporie lo stesso Platone era del resto ben consapevole, come mostra il suo dialogo Parmenide. Per Aristotele il principio di tutte le cose non risiede nelle idee trascendenti, ma nelle loro “forme” immanenti.
SUL BENE
Nel tentativo di superare un’altra difficoltà contenuta nella teoria delle idee, le quali, essendo molteplici, hanno bisogno secondo Platone di essere giustificate da un principio unitario, Platone introdusse i principi dell’Uno (identificato con il Bene) e della Diade (il grande e il piccolo); il primo ha la funzione di principio formale e il secondo ha la funzione di principio materiale. È probabile che le conclusioni del trattato aristotelico Sul Bene, scritto intorno al 358 a.C. e del quale rimangono pochi frammenti, fossero quelle esposte nella matura Metafisica: «Platone chiamò idee gli esseri diversi da quelli sensibili e disse che di tutte le cose sensibili si parla in dipendenza dalle idee e secondo le idee: infatti le cose molteplici che hanno lo stesso nome delle idee esistono per partecipazione […] ma che cosa fosse la partecipazione o l’imitazione delle idee è un problema che Platone e i pitagorici lasciarono aperto. Inoltre Platone dice che oltre alle cose sensibili e alle idee esistono le cose matematiche, che sono intermedie e differiscono dalle cose sensibili perché sono eterne e immobili, e differiscono dalle idee per il fatto che ce ne sono molte simili tra loro, mentre ciascuna idea è unica in sé […]. Come principi, Platone poneva la Diade, cioè il grande e il piccolo, come materia, e poneva l’Uno come sostanza; dal grande e dal piccolo, per partecipazione all’Uno, si costituiscono le idee, che sono i numeri che nascono da quei principi […] Platone sosteneva una tesi vicina a quella dei Pitagorici, e si poneva sulle loro posizioni, quando diceva che i numeri sono la causa della sostanza delle altre cose […] egli ricorre soltanto a due cause, l’essenza e la causa materiale, perché le idee sono la causa dell’essenza delle altre cose, mentre l’Uno è causa dell’essenza delle idee». Aristotele respinse dunque già nel primo periodo della sua formazione la teoria delle idee nella lunga elaborazione fatta da Platone, ma dalla meditazione su di essa trasse la personale dottrina della causa formale e della causa materiale.
L’EUDEMO O SULL’ANIMA
Nel 354 a.C., alla morte in guerra, presso Siracusa, dell’amico e compagno di studi Eudemo di Cipro, Aristotele scrisse, in forma consolatoria e non speculativa, un altro dialogo, pervenuto in frammenti, l’Eudemo o Sull’anima, nel quale, prendendo a modello il Fedone platonico, sosterrebbe la tesi dell’immortalità dell’anima razionale, come indicato nella forma pur problematica della posteriore Metafisica: «Se rimanga qualche cosa dopo l’individuo, è una questione ancora da esaminare. In alcuni casi, nulla impedisce che qualcosa rimanga: per esempio, l’anima può essere una cosa di questo genere, non tutta, ma solo la parte intellettuale; perché è forse impossibile che tutta l’anima sussista anche dopo». Per l’Aristotele maturo, l’anima non è un’idea ma una sostanza informante il corpo: nell’Eudemo è invece netta è l’opposizione fra anima e corpo, sicché lo Jaeger la considerava dimostrazione dell’adesione completa del giovane Aristotele al platonismo; i sostenitori della precoce presa di distanza dello Stagirita da Platone intendono invece questa dichiarata opposizione come dipendente dall’intento consolatorio del dialogo, nel quale Aristotele avrebbe volutamente accentuato il destino ultraterreno dell’anima. In ogni caso, i frammenti dell’Eudemo non permettono di dedurre un’adesione alle dottrine platoniche delle idee separate dagli oggetti sensibili e della conoscenza fondata sulla reminiscenza.
IL PROTREPTICO
Il Protreptico o Esortazione alla filosofia, conosciuto dalle numerose citazioni contenute nell’opera di eguale titolo di Giamblico, dedicato a Temisone, re di una città di Cipro, dovette essere scritto intorno al 350 a.C. Il Protreptico è un’esortazione alla filosofia, essendo questa il più grande dei beni, dal momento che ha per scopo se stessa, mentre le altre scienze hanno per fine qualcosa di diverso da sé. Aristotele individua nell’essere umano la divisione fra anima e corpo: «una parte di noi è l’anima e una parte è il corpo, l’una comanda e l’altra è comandata, l’una si serve dell’altra e l’altra sottostà come uno strumento […] Nell’anima ciò che comanda e giudica per noi è la ragione, mentre il resto ubbidisce e per natura è comandato […] dunque l’anima è migliore del corpo, essendo più adatta al comando, e di questa è migliore la parte che possiede ragione e pensiero», una divisione non vista come opposizione, come nell’Eudemo, ma come collaborazione: il corpo è lo strumento dell’agire dell’anima, della parte razionale dell’anima. «Delle cose che sono generate, alcune sono generate dall’intelligenza e dall’arte, per esempio, la casa e la nave; altre sono generate non per arte ma per natura: degli esseri viventi e delle piante, infatti, la causa è la natura e per natura sono generate tutte le cose di tal specie; altre però sono generate anche per caso, e sono tutte quelle non generate né per arte, né per natura, né da necessità, e tutte queste cose, molto numerose, noi diciamo che sono generate per caso». Non vi è finalità nel caso ma vi è nell’arte e nella natura: la natura è l’ordine tendente a un fine, e il fine dell’uomo è la conoscenza. La filosofia è sia buona che utile, ma la bontà va privilegiata rispetto all’utilità: «alcune cose, senza le quali è impossibile vivere, le amiamo in vista di qualcosa di diverso da esse: e queste bisogna chiamarle necessarie e cause concomitanti; altre invece le amiamo per se stesse, anche se non ne consegua nulla di diverso, e queste dobbiamo chiamarle propriamente beni […] Sarebbe quindi del tutto ridicolo cercare di ogni cosa un’utilità diversa dalla cosa stessa, e domandare: “Che cosa ci è giovevole? Che cosa ci è utile?”. Colui che ponesse queste domande non assomiglierebbe in nulla a uno che conosce ciò che è bello e buono né a uno che sappia riconoscere che cosa è causa e che cosa è concomitante». È una polemica, questa, contro le posizioni di Isocrate che, nel suo Antidosis, scritto contro l’Aristotele del Grillo, attaccava una conoscenza che fosse priva di utilità pratica. Inoltre quest’opera, essendo certamente datata, è fondamentale per gli studi storiografici in quanto ci consente di creare un abbozzo cronologico di alcuni libri della Metafisica in base alla presenza (o meno) in essi di temi già trattati nel Protreptico. Del resto, che fare filosofia sia per Aristotele comunque necessario lo dimostra il fatto che «chi pensa sia necessario filosofare, deve filosofare e chi pensa che non si debba filosofare, deve filosofare per dimostrare che non si deve filosofare; dunque si deve filosofare in ogni caso o andarsene di qui, dando l’addio alla vita, poiché tutte le altre cose sembrano essere solo chiacchiere e vaniloquio».
IL DE PHILOSOPHIA
Il De Philosophia, pervenuto in frammenti, fu scritto intorno al 355 a.C. e si divide in tre libri: nel primo Aristotele definisce filosofia la conoscenza dei principi della realtà; nel secondo critica la dottrina platonica delle idee e delle idee-numeri; nel terzo espone la sua teologia. Ribadisce la non trascendenza delle idee e nega le idee-numero o numeri ideali, introdotti dal tardo Platone: «se le idee sono un’altra specie di numero, non matematico, non potremmo averne alcuna comprensione; chi, fra noi, comprende un tipo di numero diverso?». È Cicerone a citare, criticamente, il terzo libro del De philosophia: «Aristotele nel terzo libro della sua opera Della filosofia confonde molte cose dissentendo dal suo maestro Platone. Ora infatti attribuisce tutta la divinità a una mente, ora dice che il mondo stesso è dio, ora prepone al mondo un altro essere e gli affida il compito di reggere e governare il moto del mondo per mezzo di certe rivoluzioni e moti retrogradi, talora dice che dio è l’etere, non comprendendo che il cielo è una parte di quel mondo che altrove ha designato come potere divino». La dimostrazione della necessità e dell’immutabilità di Dio è fornita dalla testimonianza di Simplicio: «dove c’è un meglio, c’è anche un ottimo: poiché, fra ciò che esiste, c’è una realtà superiore a un’altra, esisterà di conseguenza una realtà perfetta, che dovrà essere la potenza divina […] e ne deduce la sua immutabilità». Puro pensiero e immutabile, Dio non può creare il mondo, che è anch’esso eterno, come riporta Cicerone: «il mondo non ha mai avuto origine, poiché non vi è stato alcun inizio, per il sopravvenire di una nuova decisione, di un’opera così eccellente» e attesta anche la concezione della divinità degli astri: «Le stelle poi occupano la zona eterea. E poiché questa è la più sottile di tutte ed è sempre in movimento e sempre mantiene la sua forza vitale, è necessario che quell’essere vivente che vi nasca sia di prontissima sensibilità e di prontissimo movimento. Per la qual cosa, dal momento che sono gli astri a nascere nell’etere, è logico che in essi siano insite sensibilità e intelligenza. Dal che risulta che gli astri devono essere ritenuti nel numero delle divinità».
LE OPERE DELLA MATURITA’
Della produzione filosofica aristotelica più matura ci sono giunti solo gli scritti composti per il suo insegnamento nel Peripato, detti libri acroamatici (in greco: “ciò che si ascolta”) o esoterici; oltre a questi, come esposto in precedenza, Aristotele aveva scritto e pubblicato, durante la sua precedente permanenza nell’Accademia di Platone, anche dei dialoghi destinati al pubblico, per questo motivo detti essoterici, che sono però pervenuti in frammenti. Questi dialoghi giovanili furono letti e discussi dai commentatori fino al VI secolo d.C. A seguito della chiusura dell’Accademia ateniese ordinata nel 529 da Giustiniano e alla diaspora di quegli accademici, queste opere si dispersero e furono dimenticate, mentre di Aristotele rimasero solo i trattati esoterici; questi, a loro volta, erano stati dimenticati a lungo dopo la morte del Maestro fino ad essere ritrovati, alla fine del II secolo a.C., da un bibliofilo ateniese, Apellicone di Teo, in una cantina appartenente agli eredi di Neleo, figlio di Corisco, entrambi seguaci di Aristotele nella scuola di Asso. Apellicone li acquistò, portandoli ad Atene, e qui Silla li sequestrò nel saccheggio di Atene dell’84 a.C., portandoli quindi a Roma, dove furono ordinati e pubblicati da Andronico da Rodi.
LA FILOSOFIA: SCIENZA DELLE CAUSE E RICERCA DELLE ESSENZE
La filosofia di Aristotele muove dalla stessa esigenza platonica di ricercare un princìpio eterno e immutabile che spieghi il modo in cui avvengono i mutamenti della natura. Come il suo maestro Platone, Aristotele ha ben presente la contrapposizione filosofica venutasi a creare tra Parmenide ed Eraclito; anche lui pertanto si propone di conciliare le loro rispettive posizioni di pensiero: l’Essere statico del primo con l’incessante divenire del secondo. Per cui tutto muta in natura, tutto «scorre», ma non a caso: seguendo sempre certi schemi o regole fisse. A differenza di Platone, tuttavia, Aristotele ritiene che le forme in grado di guidare la materia non si trovino al di fuori di essa: non ha senso secondo lui sdoppiare gli enti per cercare poi di riconciliarli in qualche modo; ogni realtà invece deve avere in se stessa, e non in cielo, le leggi del proprio costituirsi. Il fatto che tutti i fenomeni naturali siano soggetti a costante mutamento significa per Aristotele che nella materia è sempre insita la possibilità di raggiungere una forma precisa. Compito della filosofia è proprio quello di scoprire le cause che determinano il perché un oggetto tenda ad evolversi in un certo modo e non diversamente. Aristotele parla in proposito di quattro cause, che sono le seguenti:
- causa formale: consiste nelle qualità specifiche dell’oggetto stesso, nella sua essenza;
- causa materiale: la materia è il sostrato senza cui l’oggetto non esisterebbe;
- causa efficiente: è l’agente che determina operativamente il mutamento;
- causa finale: la più importante di tutte, in virtù della quale esiste un’intenzionalità nella natura; è lo scopo per cui una certa realtà esiste.
La scienza delle cause consente di affrontare in maniera più sistematica e razionale il problema dell’Essere e delle sue possibili determinazioni, sorto la prima volta con Parmenide. Quest’ultimo aveva detto dell’Essere soltanto che è, e non può non essere, ma non aveva aggiunto cosa esso sia, lasciandolo senza un predicato. Ne risultava un concetto evanescente, che rischiava di venir confuso col non-essere. Aristotele con la sua ontologia si propone allora di mostrare che l’essere è determinato in una molteplicità di attributi, che lo rendono multilaterale pur nella sua unità.
ONTOLOGIA E METAFISICA
L’ontologia, in quanto metafisica (secondo la terminologia introdotta da Andronico di Rodi), è la “filosofia prima” aristotelica, che ha come suo primario oggetto di indagine l’essere in quanto tale, e solo in via subordinata l’ente (dal greco ὄντος, genitivo di ὤν, essente). “In quanto tale” significa a prescindere dai suoi aspetti accidentali, e quindi in maniera scientifica. Solo di ciò che permane come sostrato fisso e immutabile, infatti, si può avere una conoscenza sempre valida e universale, a differenza degli enti soggetti a generazione e corruzione, ragion per cui «del particolare non si dà scienza». Per conoscere gli enti occorrerà dunque fare sempre riferimento all’Essere; Aristotele intende per ente tutto ciò che esiste (da ex-sistentia, essere da), a differenza dell’Essere che invece è in sé e per sé: mentre l’Essere è uno, gli enti non sono tutti uguali. Per il filosofo essi hanno vari significati: l’ente è un “pòllachos legòmenon” (dal greco πόλλακος λεγόμενον), ossia si può «dire in molti modi». Ente sarà ad esempio un uomo, così come il suo colore della pelle. Introducendo gli enti, Aristotele cerca di risolvere il problema ontologico di conciliare l’essere parmenideo col divenire di Eraclito, facendo dell’ente un sinolo indivisibile di materia e forma: come già accennato, infatti, la materia possiede un suo modo specifico di evolversi, ha in sé una possibilità che essa tende a mettere in atto. Ogni mutamento della natura è quindi un passaggio dalla potenza alla realtà, in virtù di un’entelechia, di una ragione interna che struttura e fa evolvere ogni organismo secondo leggi sue proprie. Cercando di superare il dualismo di Platone in seno all’essere, Aristotele sostiene così l’immanenza dell’universale. La sua soluzione tuttavia risente fortemente dell’impostazione platonica, perché, come già il suo predecessore, anche lui concepisce l’essere in forma gerarchica, per cui da un lato vi è l’Essere eterno e immutabile, identificato con la vera realtà, che basta a se stesso in quanto perfettamente realizzato; dall’altro vi è l’essere in potenza, proprio degli enti, che per costoro è soltanto la possibilità di attuare se stessi, di realizzare la loro forma in atto, la loro essenza. Anche il non-essere quindi in qualche modo è, almeno come poter-essere. E il divenire consiste propriamente in questo perenne passaggio verso l’essere in atto.
LA SOSTANZA: PRIMA E SECONDA
Il genere sommo di cui il filosofo si occupa maggiormente è quello di sostanza, classificata in sostanza prima e sostanza seconda. La prima è relativa ad un singolo essere, un determinato uomo, un certo animale o una pianta, ossia tutto ciò che ha sussistenza autonoma. La sostanza seconda invece è costituita da sostantivi generici che determinano un oggetto in un certo modo, è la risposta a “che cos’è” quell’oggetto, ti estì (dal greco τί ἐςτι), specificando meglio la sostanza prima. Nella frase «il Sole è un astro» ad esempio, Sole, nome proprio e specifico di una stella, è sostanza prima, mentre astro, nome generico che ne specifica l’essenza o la natura, è sostanza seconda. Di fatto, se si prescinde dall’aspetto materiale, la sostanza è sinonimo di essenza (οὐσία, usìa). Ogni realtà può essere detta che “è” in quanto esprime la sostanza. Un altro termine utilizzato per indicarla è sinolo di materia e forma. Nonostante le molteplici valenze che assumono gli enti, tutti richiamano inevitabilmente in un modo o nell’altro il concetto di sostanza, termine introdotto da Aristotele per indicare ciò che è in sé e per sé, e che per essere non ha bisogno di esistere. La sostanza è uno dei dieci predicamenti dell’essere, ossia di quelle dieci categorie entro cui classificare gli enti sulla base della loro differenza. Esse sono: sostanza, qualità, quantità, dove, quando, relazione, agire, subire, avere, giacere. Le dieci categorie possono anche essere definite generi massimi, poiché permettono la completa classificazione degli enti. Non vanno confuse con i cinque generi sommi platonici, perché se Platone cercava categorie universali cui partecipassero tutte le idee, Aristotele cerca categorie cui gli enti partecipino in base alla loro diversità: non esiste infatti una categoria a cui tutti gli enti tangibili partecipino, proprio perché il suo scopo non è quello della reductio ad unum (l’omologazione, il confluire di tutti gli oggetti di studio in un unico grande calderone). A differenza della sostanza, le nove rimanenti categorie si devono invece definire “accidenti” in quanto non hanno vita indipendente, ma esistono solo nel momento in cui ineriscono alla sostanza. Il giallo, per esempio, non è un ente autonomo come un uomo. Perciò nella frase «il Sole è giallo», Sole è sempre sostanza prima, mentre giallo è accidente della sostanza, appartenente alla categoria della qualità. Lo stesso filosofo afferma quanto sia inutile ogni scienza che si occupi di enti dotati delle medesime caratteristiche: la matematica studia gli enti astratti deducibili solo con l’astrazione (in numeri), la fisica gli elementi naturali della physis (greco φύσις), l’ontologia, invece, studia gli enti. Ma in base a che cosa gli enti sono accomunati? Non certo il fatto di esistere, perché, come già detto, il filosofo nega a priori l’esistenza di una categoria che collochi in se tutti gli enti (la categoria dell’essere che, infatti, li accomunerebbe tutti). Il termine ente è comunque una parola ambigua, proprio come “salutare”. Esso vuol dire sano o indicare l’azione del cordiale saluto, tutto comunque richiama allo stesso concetto di salute.
TEOLOGIA
Soltanto l’essere in atto fa sì che un ente in potenza possa evolversi; l’argomento ontologico diventa così teologico per passare alla dimostrazione della necessità dell’essere in atto. Si è visto come il movimento sia originato dalle quattro cause. Ogni oggetto è mosso da un altro, questo da un altro ancora, e così via a ritroso, ma alla fine della catena deve esistere un motore immobile, cioè Dio: “motore” perché è la meta finale a cui tutto tende, “immobile” perché causa incausata, essendo già realizzato in se stesso come «atto puro». Tutti gli enti risentono della sua forza d’attrazione perché l’essenza, che in costoro è ancora qualcosa di potenziale, in Lui giunge a coincidere con l’esistenza, cioè è tradotta definitivamente in atto: il Suo essere non è più una possibilità, ma una necessità. In Lui tutto è compiuto perfettamente, e non v’è nessuna traccia del divenire, perché questo è appunto solo un passaggio. Non vi è neppure l’imperfezione della materia che continua invece a sussistere negli enti inferiori, i quali sono ancora una mescolanza, un insieme non coincidente di essenza ed esistenza, di potenza ed atto, di materia e forma.
« Il primo motore dunque è un essere necessariamente esistente, e in quanto la sua esistenza è necessaria si identifica col bene, e sotto tale profilo è principio. […] Se, pertanto, Dio è sempre in uno stato di beatitudine, che noi conosciamo solo qualche volta, un tale stato è meraviglioso; e se la beatitudine di Dio è ancora maggiore essa deve essere oggetto di meraviglia ancora più grande. Ma Dio, è appunto, in tale stato! » (Aristotele, Metafisica XII (Λ), 1072, b 9-30)
« Il primo motore dunque è un essere necessariamente esistente, e in quanto la sua esistenza è necessaria si identifica col bene, e sotto tale profilo è principio. […] Se, pertanto, Dio è sempre in uno stato di beatitudine, che noi conosciamo solo qualche volta, un tale stato è meraviglioso; e se la beatitudine di Dio è ancora maggiore essa deve essere oggetto di meraviglia ancora più grande. Ma Dio, è appunto, in tale stato! » (Aristotele, Metafisica XII (Λ), 1072, b 9-30)
Come nell’Essere di Parmenide, Dio è pienezza della sostanza e quindi pensiero puro. Per Aristotele infatti la migliore delle azioni è quella legata all’attività noetica, non essendo soggetta alla corruzione del divenire. Ma cosa pensa Dio? Evidentemente il pensiero più alto e cioè se stesso. La sua caratteristica principale è dunque la contemplazione autocosciente, fine a se stessa, intesa come «pensiero di pensiero».
GNOSEOLOGIA
Nell’ambito della filosofia della conoscenza, Aristotele sembra rivalutare l’importanza dell’esperienza sensibile, e tuttavia, al pari di Platone, mantiene fermo il presupposto secondo cui l’intelletto umano non si limita a recepire passivamente le impressioni sensoriali, ma svolge un ruolo attivo che gli consente di andare oltre le particolarità transitorie degli oggetti e di coglierne le cause. Esistono vari gradi del conoscere: secondo Aristotele all’inizio non ci sono idee innate nella nostra mente; questa rimane vuota se non percepiamo qualcosa attraverso i sensi. Ciò tuttavia non vuol dire che l’essere umano non abbia delle capacità innate di ordinare le conoscenze, raggruppandole in diverse classi e riuscendo a penetrare l’essenza propria di ciascuna di esse, con le quali stabilisce una corrispondenza. Al livello più basso c’è la sensazione, che ha per oggetto entità particolari. La sensazione in potenza può sentire di tutto, ma solo nel momento in cui mette in atto una percezione specifica avviene il «sentire di sentire», che appartiene al cosiddetto senso «comune». La sensazione in atto rende attuale lo stesso oggetto percepito, ad esempio è l’udito a dare vita al suono, facendolo passare all’essere. Al grado successivo interviene la fantasia, facoltà dell’anima, che ha la capacità di rappresentare gli oggetti non più presenti ai sensi, producendo le immagini: queste vengono ricevute dall’intelletto potenziale, per essere poi, in seguito a vari filtri, conservate dalla memoria, da cui nasce la generalizzazione dell’esperienza. Anche l’intelletto potenziale ha bisogno a sua volta di una realtà già in atto per potersi attivare. Ecco dunque che la conoscenza deve culminare infine con un trascendente intelletto attivo, che superando la potenza sappia vedere l’essenza in atto, ossia la forma. Questo passaggio supremo è reso possibile dall’intuizione (nous), la quale presuppone che la mente umana sia capace di pensare se stessa, ovvero sia dotata di consapevolezza e libertà; solo così essa può riuscire ad “astrarre” l’universale dalle realtà empiriche. L’approdo dal particolare all’universale, inizialmente avviato tramite i sensi dall’epagoghè (termine traducibile impropriamente con induzione) non possiede infatti nessun carattere di necessità o di conseguenzialità logica, dato che la logica di Aristotele, a differenza di quella moderna, è solo deduttiva. L’induzione per lui funge unicamente da stimolo, o sollecitazione, di un processo definitorio che comporta alla fine un’esperienza di tipo contemplativo:
« Non si può dire che il definire qualcosa consista nello sviluppare un’induzione attraverso i singoli casi manifesti, stabilendo cioè che l’oggetto nella sua totalità deve comportarsi in un certo modo […] Chi sviluppa un’induzione, infatti, non prova cos’è un oggetto, ma mostra che esso è, oppure che non è. In realtà, non si proverà certo l’essenza con la sensazione, né la si mostrerà con un dito. » (Aristotele, Analitici secondi II, 7, 92a-92b)
« Non si può dire che il definire qualcosa consista nello sviluppare un’induzione attraverso i singoli casi manifesti, stabilendo cioè che l’oggetto nella sua totalità deve comportarsi in un certo modo […] Chi sviluppa un’induzione, infatti, non prova cos’è un oggetto, ma mostra che esso è, oppure che non è. In realtà, non si proverà certo l’essenza con la sensazione, né la si mostrerà con un dito. » (Aristotele, Analitici secondi II, 7, 92a-92b)
La conoscenza noetica che ne risulterà consiste quindi nella corrispondenza tra realtà e intelletto: come la sensazione si identifica con ciò che è sentito, così l’intelletto attivo o agente (indicato col termine nùs poietikòs) coincide con la verità del suo stesso oggetto, implicando una componente divina in grado di farlo passare all’atto, per cui ad esempio un libro è un oggetto in potenza, che diventa un libro in atto solo quando viene pensato.
LOGICA
Distinta dall’intelletto è la Logica (diànoia, o ragione), che Aristotele teorizza nella forma rigorosamente deduttiva del sillogismo. Le leggi che la guidano, non dimostrabili ma intuibili con un atto immediato, sono il principio di identità, per il quale A = A, e quello di non-contraddizione, per cui A ≠ non-A. Il sillogismo è un ragionamento concatenato che, partendo da due premesse di carattere generale, una “maggiore” e una “minore”, giunge ad una conclusione coerente su un piano particolare. Sia le premesse che la conclusione sono proposizioni espresse nella forma soggetto-predicato. Un esempio di sillogismo è il seguente:
- Tutti gli uomini sono mortali;
- Socrate è uomo;
- dunque Socrate è mortale.
Attraverso il sillogismo, la logica permette di ordinare in gruppi o categorie tutto ciò che si trova in natura, a condizione però di partire da premesse vere e certe: i sillogismi infatti di per sé non danno nessuna garanzia di verità. Questo perché i princìpi primi, da cui il ragionamento prende le mosse, non possono essere a loro volta dimostrati, dato che proprio da essi deve scaturire la dimostrazione; solo l’intuizione intellettuale, opera dell’intelletto attivo, può dare loro un fondamento oggettivo e universale, tramite quel processo conoscitivo sovra-razionale, che partendo come si è visto dall’epagoghé, culmina nell’astrazione dell’essenza. Da questa poi la logica trarrà soltanto delle conseguenze coerenti da un punto di vista formale, facendo ricorso ai giudizi predicativi che corrispondono alle dieci categorie dell’essere.
DIALETTICA
Mentre la logica o analitica studia la deduzione a partire da premesse vere, la dialettica in Aristotele è semplicemente la tecnica con la quale uscire vittoriosi da una discussione. Questo successo, che non esclude comunque un effettivo raggiungimento della verità, deriva dal prevalere con la propria tesi su quella sostenuta dall’avversario, nel rispetto di premesse su cui ci si è messi d’accordo prima dell’inizio del confronto: difatti la confutazione, l’aver ottenuto ragione e quindi l’aver vinto, si basava proprio sul portare l’interlocutore ad autocontraddirsi, mostrando dunque come la sua tesi, se sviluppata, avrebbe condotto a risultati illogici nei confronti delle premesse iniziali, considerate vere da entrambi. Certo era necessario che le premesse fossero considerate vere dal pubblico che assisteva al confronto, pertanto non di rado si sceglieva di accordarsi su premesse che fossero ritenute vere dai membri più influenti della società, così che essi potessero influenzare anche l’opinione altrui. La tecnica dialettica necessitava di un’ottima conoscenza delle parole e dei modi di unirle in proposizioni e, ancora, in periodi, pertanto il filosofo postula alcune teorie, quali quella della proposizione e quella del sillogismo, che permettono di capire come debba funzionare nei vari casi la parola. Prima di queste teorie, si sofferma sulla spiegazione dell’esistenza di parole univoche ed equivoche, ovvero da uno o più significato: deve essere la loro conoscenza accurata il primo necessario requisito per l’esperto di dialettica.
TEORIA E PROPOSIZIONE
Una proposizione è un insieme di termini (o parole) i quali danno vita a un’affermazione, un giudizio. Questo può essere vero o falso, in base al riscontro con la realtà, mentre i singoli termini di per sé non possono essere veri o falsi se considerati da soli. Neppure tutte le proposizioni però rientrano nella dimensione del vero o falso: preghiere, invocazioni, ordini, sono destinati all’ambito poetico e di questi Aristotele non si occupa. Egli invece si occupa delle frasi a cui sole può essere riconosciuta la possibilità di essere vere o false, chiamandole categoriche, o dichiarative, o apofantiche. Le proposizioni categoriche possono avere qualità affermativa o negativa, e quantità universale (quando il soggetto è un genere e vi sono inclusi tutti gli appartenenti) particolare (si fa riferimento solo a una parte degli enti di un genere) o singolari (il soggetto è un individuo singolo), in base alla maggiore o minore generalità del soggetto. Aristotele non si preoccupa delle proposizioni singolari, soffermandosi solo sulle proposizioni affermative e negative, universali e particolari. Combinando questi tipi di proposizioni, risultano esserci quattro tipi di proposizioni-modello per il filosofo:
- universale affermativa,
- universale negativa,
- particolare affermativa,
- particolare negativa.
L’ETICA
«La dignità non consiste nel possedere onori ma nella coscienza di meritarli.» (Aristotele)
L’etica di cui tratta Aristotele attiene alla sfera del comportamento (dal greco ethos), ossia alla condotta da tenere per poter vivere un’esistenza felice. Coerentemente con la sua impostazione filosofica, l’atteggiamento più corretto è quello che realizza l’essenza di ognuno. Ne consegue l’identificazione di essere e valore: quanto più un ente realizza la propria ragion d’essere, tanto più esso vale. L’uomo in particolare realizza se stesso praticando tre forme di vita: quella edonistica, incentrata sulla cura del corpo, quella politica, basata sul rapporto sociale con gli altri, e infine la via teoretica, situata al di sopra delle altre, che ha come scopo la conoscenza contemplativa della verità. Le tre modalità di condotta vanno comunque integrate fra loro, senza privilegiare l’una a discapito dell’altra. L’uomo infatti deve saper sviluppare e assecondare armonicamente tutte e tre le potenzialità dell’anima che contraddistinguono il proprio essere o entelechia, e da Aristotele identificate con:
- l’anima vegetativa, comune anche alle piante e agli animali, che attiene ai processi nutritivi e riproduttivi;
- l’anima sensitiva, comune agli animali, che attiene alle passioni e ai desideri;
- l’anima razionale, che appartiene soltanto all’uomo, e consiste nell’esercizio dell’intelletto.
Sulla base di questa tripartizione, Aristotele individua il piacere e la salute come scopo finale dell’anima vegetativa, risultante dall’equilibrio tra gli eccessi opposti, evitando ad esempio di mangiare troppo, o troppo poco. All’anima sensitiva egli assegna invece le cosiddette virtù etiche, che sono abitudini di comportamento acquisite allenando la ragione a dominare sugli impulsi, attraverso la ricerca del «giusto mezzo» fra estreme passioni: ad esempio il coraggio è l’atteggiamento mediano da preferire tra la viltà e la temerarietà. Essendo l’uomo un «animale sociale», l’equilibrio è ciò che deve guidare i suoi rapporti con gli altri; questi devono essere improntati al giusto riconoscimento degli onori e del prestigio derivanti dall’esercizio delle cariche pubbliche. Le diverse virtù etiche sono quindi tutte riassunte dalla virtù della giustizia.
Virtù etiche
- Giustizia
- Coraggio
- Temperanza
- Liberalità
- Magnificenza
- Magnanimità
- Mansuetudine
Virtù dianoetiche
- Virtù calcolative
- Arte
- Prudenza
- Virtù scientifiche
- Sapienza
- Scienza
- Intelligenza
- Sapienza
All’anima razionale infine Aristotele assegna le cosiddette virtù dianoetiche, suddivise in calcolative e scientifiche. Le facoltà calcolative hanno una finalità pratica, sono strumenti in vista di qualcos’altro: l’arte (tèchne) ha un fine produttivo, la saggezza o prudenza (phrònesis) serve a dirigere le virtù etiche, oltre a guidare l’azione politica. Se queste virtù vanno perseguite in vista di un bene più alto, alla fine tuttavia deve pur sussistere un bene da perseguire per se stesso. Le facoltà scientifiche, mirando alla conoscenza disinteressata della verità, non si prefiggono appunto nessun altro obiettivo al di fuori della sapienza in sé (sophìa). A questa virtù suprema concorrono le due facoltà conoscitive della gnoseologia: la scienza (epistème), che è la capacità della logica di compiere dimostrazioni; e l’intelligenza (nùs), che fornisce i princìpi primi da cui scaturiscono quelle dimostrazioni. Aristotele introduce così una concezione della sapienza intesa come “stile di vita” slegato da ogni finalità pratica, e che pur rappresentando l’inclinazione naturale di tutti gli uomini solo i filosofi realizzano a pieno, mettendo in atto un sapere che non serve a nulla, ma proprio per questo non dovrà piegarsi a nessuna servitù: un sapere assolutamente libero. La contemplazione della verità è quindi un’attività fine a se stessa, nella quale consiste propriamente la felicità (eudaimonìa), ed è quella che distingue l’uomo dagli altri animali rendendolo più simile a Dio, già definito da Aristotele come «pensiero di pensiero», pura riflessione autosufficiente che nulla deve ricercare al di fuori di sé. « Se in verità l’intelletto è qualcosa di divino in confronto all’uomo, anche la vita secondo esso è divina in confronto alla vita umana. ». (Aristotele, Etica Nicomachea, X.7, 1177 b30-31)
L’etica di Aristotele, che pone l’accento sul «giusto mezzo» come via maestra per diventare persone felici e armoniche, segue da vicino i dettami della scienza medica greca, basata similmente sull’equilibrio e la moderazione. Allo stesso modo, le tre possibili forme politiche dello Stato (monarchia, aristocrazia, e democrazia) devono guardarsi dall’estemismo delle loro rispettive degenerazioni: tirannide, oligarchia e oclocrazia.
IL CONCETTO DI PHILIA
Nell’ottavo e nel nono libro dell’Etica Nicomachea Aristotele tratta anche del concetto d’amicizia (in greco philìa, φιλία). Il filosofo comincia facendo l’analisi dei diversi fondamenti dell’amicizia: l’utile, il piacere e il bene; da questi derivano le tre tipologie d’amicizia: quella di utilità, di piacere, e di virtù. L’amicizia di utilità è tipica dei vecchi, quella di piacere degli uomini maturi e dei giovani; gli amici in queste due tipologie non si amano di per se stessi ma solamente per i vantaggi che traggono dal loro legame: per tale motivo questi tipi di amicizia, basandosi sui bisogni e desideri umani, che sono volubili, si creano e si dissolvono con facilità. L’unica vera amicizia è quella di virtù, stabile perché si fonda sul bene, caratteristica degli uomini buoni. L’amicizia di virtù presuppone due condizioni fondamentali: l’uguaglianza fra gli amici (a livello di intelligenza, ricchezza, educazione ecc.) e la consuetudine di vita. L’amicizia si distingue dalla benevolenza, che può non essere corrisposta, e dall’amore, perché nell’amore entrano in gioco fattori istintuali. Aristotele tuttavia non esclude che un rapporto d’amore possa trasformarsi poi in una vera e propria amicizia. La philia aristotelica esprime quindi il legame tra amicizia e reciprocità, fondato sul riconoscimento dei meriti e sul reciproco desiderio del bene per l’altro.
ASTRONOMIA
Aristotele tratta nelle sue opere (in particolare nella Fisica) della conformazione dell’universo. Aristotele propone un modello geocentrico, che pone cioè la Terra al centro dell’universo. Secondo Aristotele, la Terra è formata da quattro elementi: la terra, l’aria, il fuoco e l’acqua. Le varie composizioni degli elementi costituiscono tutto ciò che si trova nel mondo. Ogni elemento possiede due delle quattro qualità (o «attributi») della materia:
- il secco (terra e fuoco),
- l’umido (aria ed acqua),
- il freddo (acqua e terra),
- il caldo (fuoco e aria).
Ogni elemento ha la tendenza a rimanere o a tornare nel proprio luogo naturale, che per la terra e l’acqua è il basso, mentre per l’aria e il fuoco è l’alto. La Terra come pianeta, quindi, non può che stare al centro dell’universo, poiché è formata dai due elementi tendenti al basso, e il “basso assoluto” è proprio il centro dell’universo. Riguardo a ciò che si trova oltre la Terra, Aristotele lo riteneva composto di un quinto elemento (o essenza): l’etere. L’etere, che non esiste sulla Terra, sarebbe privo di massa, invisibile e, soprattutto, eterno ed inalterabile: queste due ultime caratteristiche sanciscono un confine tra i luoghi sub-lunari del mutamento (la Terra) e i luoghi immutabili (il cosmo).
Aristotele riteneva che i corpi celesti si muovessero su sfere concentriche (in numero di cinquantacinque, ventidue in più delle 33 di Callippo). Oltre la Terra per lui vi erano, in ordine, la Luna, Mercurio, Venere, il Sole, Marte, Giove, Saturno, il cielo delle stelle fisse e, infine, il primo mobile, che metteva tutte le altre sfere in movimento, e della cui natura peraltro Aristotele ebbe qualche difficoltà a dare una definizione precisa. Esso risulta mosso direttamente dalla causa prima, identificabile con la divinità suprema (mentre le altre divinità risiedevano all’interno del cosmo), in una maniera tuttavia non meccanica o causale, dato che Dio, essendo «atto puro», è assolutamente immobile, oltre ad essere privo di materia e quindi non localizzabile da nessuna parte. Il primo mobile piuttosto si muove per un desiderio di natura intellettiva, cioè tende a Dio come propria causa finale. Cercando dunque di imitare la sua perfetta immobilità, esso è contraddistinto dal moto più regolare e uniforme che ci sia: quello circolare. Aristotele era convinto dell’unicità e della finitezza dell’universo: l’unicità perché se esistesse un altro universo sarebbe composto sostanzialmente dei medesimi elementi del nostro, i quali tenderebbero, per i luoghi naturali, ad avvicinarsi al nostro fino a ricongiungersi completamente con esso, ciò che prova l’unicità del nostro universo; la finitezza perché in uno spazio infinito non potrebbe esistere alcun centro, ciò che contravverrebbe alla teoria dei luoghi naturali.
BIOLOGIA
Aristotele ha fondato la biologia come scienza empirica, compiendo un importante salto di qualità (almeno stando alle fonti che ci sono rimaste) nell’accuratezza e nella completezza descrittiva delle forme viventi, e soprattutto introducendo importanti schemi concettuali che si sono conservati nei secoli successivi. L’Historia animalium contiene la descrizione di 581 specie diverse, osservate per lo più durante la permanenza in Asia Minore e a Lesbo. Questi dati biologici vengono organizzati e classificati nel De partibus animalium, nel quale vengono introdotti concetti fondamentali come quello di viviparità e oviparità, e sono impiegati criteri di classificazione delle specie in base all’habitat o a precise caratteristiche anatomiche, che sono in gran parte rimasti inalterati fino a Linneo. Un altrettanto importante conquista intellettuale è lo studio sistematico di quella che oggi chiamiamo anatomia comparata, che permette ad esempio ad Aristotele di classificare Delfini e Balene tra i mammiferi (essendo essi dotati di polmoni e non di branchie come i pesci). Il De generatione animalium si occupa del modo in cui gli animali si riproducono. In quest’opera la generazione viene interpretata come trasmissione della forma (di cui è portatore il seme maschile) alla materia (rappresentata dal sangue mestruale femminile). Secondo Aristotele le specie sono eterne ed immutabili, e la riproduzione non determina mai cambiamenti nella sostanza, ma solo negli accidenti dei nuovi individui. Molto interessante è lo studio che Aristotele compie sugli embrioni, grazie al quale egli comprende che essi non si sviluppano attraverso la crescita di organi già tutti presenti fin dal concepimento, ma con la progressiva aggiunta di nuove strutture vitali. Alcuni limiti della biologia aristotelica (come la generale sottovalutazione del ruolo del cervello, che Aristotele credeva destinato a raffreddare il sangue) furono superati con la scoperta, avvenuta in epoca ellenistica, del sistema nervoso, in molti altri casi un superamento della biologia aristotelica si è avuto solo nel Settecento. Alcune delle sue osservazioni in ambito zoologico tuttavia sono state confermate solo nel XIX secolo.
LA FORTUNA DI ARISTOTELE
La fortuna di Aristotele in Occidente si deve, tra le altre cose, al fatto che è stato lui a fondare e ordinare le diverse forme di conoscenza, creando i presupposti e i paradigmi dei linguaggi specialistici che vengono usati ancora oggi in campo scientifico. Mirando a creare un sistema globale del pensiero, furono di importanza basilare le sue formulazioni sulla fisica e sulla metafisica, sulla teologia, sull’ontologia, sulla matematica, sulla poetica, sul teatro, sull’arte, sulla musica, sulla logica, sulla retorica, sulla politica e sui governi, sull’etica, sulla grammatica, sull’oratoria e sulla dialettica, sulla linguistica, sulla biologia e sulla zoologia. Come pochi altri filosofi Aristotele ha avuto larga influenza su diversi pensatori delle epoche successive, che ammirarono il suo genio e analizzarono profondamente i suoi concetti: auctoritas metafisica nella Scolastica di Tommaso d’Aquino, oltre che nella tradizione islamica ed ebraica del Medioevo, il pensiero di Aristotele venne spesso ripreso nel Rinascimento. Anche Dante Alighieri lo ricorda nella Divina Commedia: « Poi ch’innalzai un poco più le ciglia, vidi ‘l maestro di color che sanno seder tra filosofica famiglia. Tutti lo miran, tutti onor li fanno. »
Secondo Aristotele l’uomo ha “un’anima vegetativa”, “un’anima sensitiva” e “un’anima intellettiva o razionale”. L’essere umano è felice solo quando si serve di tutte le sue capacità e possibilità. Usando questi tre elementi con equilibrio e moderazione l’uomo diventa felice e armonico. Secondo Aristotele l’uomo è un “animale politico”: senza la società non siamo veri uomini. Vi sono tre forme di vita: la prima ha come fine il piacere del corpo: è la vita edonistica. La seconda ha come fine l’onore, cioè il prestigio connesso con le cariche pubbliche: è la vita politica. La terza ha come fine la conoscenza della verità: è la vita teoretica (o contemplativa). Aristotele sottolinea che queste tre condizioni devono essere presenti contemporaneamente perché un uomo viva un’esistenza felice. Rifiutò ogni forma di parzialità. Una persona che pensa solo a sviluppare il proprio corpo vive in modo parziale e riduttivo. Lo stesso vale per chi usa solo la testa. Questi due estremi sono espressione di un atteggiamento distorto della vita. L’opinione che Aristotele ha sulla donna non è incoraggiante in quanto afferma che alla donna manca qualcosa: in altre parole è un “uomo incompleto”. Nell’atto riproduttivo la donna è passiva, inoltre, il bambino eredita soltanto le qualità del padre, poiché esse sono contenute nel seme dell’uomo. La donna è il terreno mentre l’uomo è il seminatore. L’uomo da la forma, la donna contribuisce con la materia. E’ evidente che Aristotele non poteva avere molta esperienza pratica riguardo alla vita delle donne e dei bambini, per commettere un errore così madornale nel valutare il rapporto che esiste tra i due sessi. Inoltre ci fa vedere con chiarezza fino a che punto ci si possa sbagliare quando gli uomini detengono il potere assoluto nella filosofia e nella scienza. Lo Stato ideale sarebbe quello in cui tutti sapessero virtuosamente comandare da vecchi, dopo aver virtuosamente obbedito da giovani. Aristotele diceva che dell’educazione le radici sono amare ma il frutto è dolce. Gli fu domandato quanto differiscano gli uomini colti dagli incolti, egli rispose: -“Tutto, quanto i vivi dai morti”.
Aristotele cita la risposta di Simonide (poeta lirico greco 556 – 468 ca.) alla moglie di Gerone (tiranno di Siracusa, favorì le arti – ebbe alla sua corte, Pindaro, Eschilo, Simonide, ecc.), se fosse meglio essere saggi o ricchi: “Ricchi, poiché vediamo i saggi che trascorrono il loro tempo davanti alla porta dei ricchi. Ma la ricchezza è semplicemente un mezzo; in se stessa non soddisfa veramente nessuno tranne l’avaro; e, poiché è relativa, raramente soddisfa l’uomo per molto tempo”.
Diceva che:
- “dell’educazione le radici sono amare ma il frutto è dolce”.
- “La felicità non è in ciò che hai ne in ciò che sei ma in ciò che persegui”.
- Sedendo et quiescendo anima efficetur sapiens; (sedendo e riposando l’anima diventa sapiente).
- “Lo Stato ideale sarebbe quello in cui tutti sapessero virtuosamente comandare da vecchi, dopo aver virtuosamente obbedito da giovani”.
I SOFISTI
Esponenti della filosofia e cultura greche del sec. V a.C. . Letteralmente “grandi sapienti”. Le origini del movimento sono strettamente connesse a quel vasto rivolgimento politico e sociale che portò al governo in gran parte del mondo greco regimi democratici e dette l’avvio a un vasto processo di rinnovamento culturale e di critica radicale della tradizione: onde il frequente parallelismo istituito tra l’età dei sofisti e quella dell’Illuminismo. La nuova situazione richiedeva, come dicevano i greci, una nuova areté, una nuova “virtù”, nel senso tipico di “capacità e abilità”, e, nello stesso tempo, essendo la democrazia greca di quel periodo diretta e non rappresentativa, tutti avevano la possibilità di partecipare direttamente alle pubbliche discussioni, onde la necessità di far prevalere le proprie tesi mediante l’abilità persuasiva dei discorsi con cui venivano proposte. Il fatto di proporsi a un tempo come maestri di virtù e come maestri di discorsi è la caratteristica che accomuna tutti i maggiori rappresentanti di questo movimento (Gorgia di Leontini, Protagora di Abdera, Anassagora, Prodico di Ceo, Ippia di Elide, eccetera), a prescindere dalla varietà delle loro dottrine particolari: il soggettivismo gnoseologico, il relativismo morale, la svalutazione delle grandi ipotesi naturalistiche, il prevalente interessamento per i problemi umani, il contrasto tra ciò che è per natura e ciò che è solo per convenzione, le varie teorie retoriche, linguistiche e dialettiche. La parola “sofisma” divenne sinonimo di ragionamento capzioso, impeccabile o addirittura geniale sul piano logico, assurdo sul piano sostanziale. I sofisti divennero il simbolo di una tendenza, nella società ateniese, di ricerca del successo, del denaro, del piacere, della carriera e di un certo annebbiamento degli ideali e della morale. Nel campo sociale predicarono l’estremo individualismo in quanto, contro le artificiose leggi dello stato, l’umano deve tornare alla natura senza soffrire restrizione alcuna.
I CINICI
Si dice che più di una volta Socrate, osservando la grande quantità di merci in vendita su una bancarella, commentasse: “Di quante cose non sento il bisogno!”. Questa affermazione potrebbe essere usata come motto della filosofia cinica, che venne fondata ad Atene, intorno al 400 a.C.. Antistene era stato allievo di Socrate ed era rimasto colpito dalla sua parsimonia e dalla sua moderazione. I cinici affermavano che la vera felicità non si ottiene grazie alla ricchezza, al potere politico o a una salute di ferro, bensì disprezzando le cose esteriori, casuali ed effimere. Tutti quindi possono ottenere la felicità e, una volta ottenuta, non la si può più perdere. Il cinico più famoso è Diogene di Sinope, allievo di Antistene. Si dice che vivesse in una botte e che non possedesse altro che un mantello, un bastone e una bisaccia in cui raccoglieva le cibarie. Secondo i cinici, un essere umano non deve preoccuparsi della propria salute, della sofferenza e della morte e, non deve interessarsi del dolore altrui. A giorno d’oggi i termini “cinico” e “cinismo” vengono usati per indicare un atteggiamento indifferente e insensibile verso gli altri esseri umani.
DIOGENE
Diogene di Sinope (Diogénes, “figlio di Zeus”) detto il Cinico e il Socrate pazzo (Sinope, 412 a.C. ca. – Corinto, 10 giugno 323 a.C.) è stato un filosofo greco antico. Considerato uno dei fondatori della scuola cinica insieme al suo maestro Antistene, secondo Diogene Laerzio, storico greco antico, perì nello stesso giorno in cui Alessandro Magno trapassò a Babilonia. « [Alessandro] si fece appresso a Diogene, andandosi a mettere tra lui e il sole. “Io sono Alessandro, il gran re”, disse. E a sua volta Diogene: “Ed io sono Diogene, il cane”. Alessandro rimase stupito e chiese perché si dicesse cane. Diogene gli rispose: “Mi dico cane perché faccio le feste a chi mi dà qualcosa, abbaio contro chi non dà niente e mordo i ribaldi.” » (Diogene Laerzio, Vite dei filosofi, Vita di Diogene il Cinico).

Diogene
Socrate cercava di scoprire il modo in cui l’uomo potesse vivere una vita felice. I cinici e gli stoici lo interpretavano nel senso che l’uomo deve liberarsi dai beni materiali e dalle passioni. Tra gli allievi di Socrate, ce ne fu uno, di nome Aristippo, secondo il quale lo scopo della vita doveva essere il raggiungimento del massimo piacere dei sensi. Aristippo identificava quindi il bene con il piacere e, di conseguenza, il male con il dolore. Sua intenzione era sviluppare un’arte del vivere che potesse evitare ogni forma di dolore. Il fine per i cinici e gli stoici era quello di sopportare il dolore.Suo padre, Icesio, era un cambiavalute e fu imprigionato oppure esiliato perché accusato di alterare le monete. Diogene si trovò anch’esso sotto accusa, e si spostò ad Atene con un assistente che poi abbandonò, dicendo: “Se Mane può vivere senza Diogene, perché non Diogene senza Mane?”. Attratto dagli insegnamenti ascetici di Antistene, divenne presto suo discepolo, a dispetto della rudezza con la quale era trattato e del fatto che costui non lo voleva come allievo, ma ben presto superò il maestro sia in reputazione che nel livello di austerità della vita. Le storie che si raccontano di lui sono probabilmente vere; ad ogni modo, sono utili per illustrare la coerenza logica del suo carattere e la sua irriverenza. Si espose alle vicissitudini del tempo vivendo in una piccola vasca aperta che apparteneva al tempio di Cibele. Distrusse l’unica sua proprietà terrena, una ciotola di legno, vedendo un ragazzo bere dall’incavo delle mani. In viaggio verso Egina, venne fatto prigioniero dai pirati e venduto come schiavo a Creta ad un uomo di Corinto chiamato Xeniade (o Seniade). Venendo interrogato sul suo prezzo, replicò che non conosceva altro scambio possibile che quello con un uomo di governo, e che desiderava essere venduto ad un uomo che avesse bisogno di un maestro.
«E chiedendogli l’araldo che cosa sapesse fare, Diogene rispose: Comandare agli uomini. Fu allora che egli additò un tale di Corinto che indossava una veste pregiata di porpora, il predetto Seniade, e disse: Vendimi a quest’uomo: ha bisogno di un padrone.» (Diogene Laerzio, Vite dei Filosofi VI, Vita di Diogene, 32)
Come tutore dei due figli di Xeniade, nonché suo amministratore domestico, visse a Corinto per il resto della sua vita, che dedicò interamente a predicare le virtù dell’autocontrollo e dell’autosufficienza, abitando in una botte. Ai Giochi Istmici tenne discorsi a un pubblico consistente che lo seguiva dal periodo di Antistene.

Diogene e Alessandro Magno
«Il re in persona andò da lui e lo trovò che stava disteso al sole. Al giungere di tanti uomini egli si levò un poco a sedere e guardò fisso Alessandro. Questi lo salutò e gli rivolse la parola chiedendogli se aveva bisogno di qualcosa; e quello: “Scostati un poco dal sole”. A tale frase si dice che Alessandro fu così colpito e talmente ammirò la grandezza d’animo di quell’uomo, che pure lo disprezzava, che mentre i compagni che erano con lui, al ritorno, deridevano il filosofo e lo schernivano, disse:”Se non fossi Alessandro, io vorrei essere Diogene”. » (Plutarco, Vite parallele, Vita di Alessandro Magno). Diogene Laerzio, a differenza di Plutarco, riferisce che successivamente, forse irritato dalla mancanza di rispetto, Alessandro, per farsi gioco di lui che veniva chiamato “cane”, gli mandò un vassoio pieno di ossi e lui lo accettò ma gli mandò a dire: “Degno di un cane il cibo, ma non degno di re il regalo”. Alla sua morte, a 89 anni, sulla quale ci sono più testimonianze, i Corinzi eressero un pilastro alla sua memoria, sul quale v’era, inciso, un cane di marmo pario. « Il medesimo Eubulo attesta che Diogene invecchiò presso Seniade e, morto, fu seppellito dai suoi figli. Chiedendogli al tempo Seniade come volesse essere seppellito, egli replicò: Sulla faccia. Domandandogliene quello la ragione, Diogene soggiunse: Perché tra poco quel che è sotto si sarà rivoltato all’insù. Disse questa battuta perché ormai i Macedoni dominavano, o da umili erano diventati potenti.» (Vita di Diogene, 74)
IL PENSIERO
«Tutto appartiene agli dei; i sapienti sono amici degli dei; i beni degli amici sono comuni. Perciò i sapienti posseggono ogni cosa» (Diogene di Sinope, citato da Diogene Laerzio)
La virtù, per lui, consisteva nell’evitare qualsiasi piacere fisico superfluo: tuttavia Diogene rifiuta drasticamente, non senza esibizionismo, le convenzioni e i tabù sociali, oltre che i valori tradizionali come la ricchezza, il potere, la gloria; sofferenza e fame erano positivamente utili nella ricerca della bontà; tutte le crescite artificiali della società gli sembravano incompatibili con la verità e la bontà; la moralità porta con sé un ritorno alla natura e alla semplicità. Citando le sue parole, “l’Uomo ha complicato ogni singolo semplice dono degli Dei.” È accreditato come uno strenuo sostenitore delle sue idee, al punto da arrivare a comportamenti indecenti; tuttavia, probabilmente, la sua reputazione ha risentito dell’indubbia immoralità di alcuni dei suoi eredi. Diogene rivendica la libertà di parola, ma rifiuta la politica, rivelando un concetto proto-anarchico. Secondo quanto ci tramanda il sesto libro della “Vita dei filosofi” di Diogene Laerzio, Diogene è stata la prima persona conosciuta ad aver utilizzato il termine “cosmopolita”. Difatti, interrogato sulla sua provenienza, Diogene rispose: “Sono cittadino del mondo intero”. Si trattava di una dichiarazione sorprendente in un’epoca dove l’identità di un uomo era intimamente legata alla sua appartenenza ad una polis particolare. Al filosofo megarico Diodoro Crono, che negava il movimento, Diogene rispose semplicemente mettendosi a camminare.
DIOGENE IL “CINICO”
«Durante un banchetto gli gettarono degli ossi, come a un cane. Diogene, andandosene, urinò loro addosso, come fa un cane.» (Diogene Laerzio, Vite dei Filosofi,VI,46)
Molti aneddoti su Diogene riportano i suoi comportamenti paragonabili a quelli di un cane, e i suoi elogi per le virtù del cane. Non è noto se Diogene sia stato insultato con l’epiteto “cinico” (da kynikos, l’aggettivo derivante da kyon, cane) ed abbia scelto di considerarlo un elogio, o se sia stato lo stesso filosofo a sceglierlo per sé. Diogene riteneva che gli esseri umani vivessero in modo artificiale e ipocrita e che dovessero studiare gli atteggiamenti del cane. Oltre a praticare in pubblico le fisiologiche funzioni corporee senza essere a disagio, un cane mangerà di tutto, e non si preoccuperà di dove dorme. I cani vivono nel presente senza preoccupazioni e non si occupano di filosofia astratta. Inoltre, sanno istintivamente chi è amico e chi è nemico, al contrario degli uomini, che o ingannano o sono ingannati. Diogene aveva scelto di comportarsi come “critico” pubblico: la sua missione era quella di dimostrare agli antichi Greci che la civiltà è regressiva, e di dimostrare con l’esempio che la saggezza e la felicità appartengono all’uomo che è indipendente dalla società. Diogene si fece beffe non solo della famiglia e dell’ordine politico e sociale, ma anche delle idee sulla proprietà e sulla buona reputazione. Una volta uscì con una lanterna di giorno, e, alla domanda su che cosa stesse facendo, rispose: “cerco l’uomo!”, intendendo “un uomo onesto”. Uno degli aspetti più clamorosi della sua filosofia era il suo rifiuto delle normali concezioni sulla decenza. Secondo gli aneddoti, Diogene mangiava in pubblico, viveva in una botte, defecava nel teatro pubblico, e non esitava ad insultare apertamente i suoi interlocutori. Diogene svolgeva in pubblico anche atti sessuali. I suoi ammiratori lo consideravano un uomo devoto alla ragione e di onestà esemplare. Per i suoi detrattori era un folle fastidioso e maleducato.
Diogene scrisse 14 dialoghi, 7 tragedie e numerose lettere, ma non rimane nulla di ciò, solo frammenti della sua Repubblica, riportati da Diogene Laerzio, in cui provocatoriamente difende l’incesto, i cannibali e tutte le pratiche sociali considerate scandalose, affermando inoltre la sua contrarietà all’istituto matrimoniale e all’uso della moneta. Affermava che il vino migliore fosse quello altrui, e una volta si mise a parlare con una statua, al che, a chi gli chiedeva conto del suo strano comportamento, rispose di allenarsi a chiedere invano. Nonostante il suo aperto disprezzo per Platone e la sua filosofia astratta, Diogene ha una certa somiglianza con la personalità di Socrate, con il quale condivideva la missione di migliorare moralmente la società. Secondo Diogene Laerzio, Platone definì Diogene “un Socrate impazzito”. Ad Atene, Platone l’aveva incontrato alcune volte, ed ogni volta Diogene non perdeva occasione per deridere la teoria delle idee platoniche. Polemizzò anche con Aristotele. Diogene venne considerato degno di rispetto persino da molti neoplatonici: scrive l’imperatore Giuliano: a differenza dei cinici dell’epoca tarda «egli ubbidiva al dio di Pytho [ Apollo ] e della sua obbedienza non ebbe a pentirsi, e si sbaglierebbe a prendere per indizio di empietà il fatto che egli non frequentasse i templi e non venerasse le immagini e gli altari: Diogene non aveva niente da offrire, né incenso, né libagioni, né denaro, ma possedeva una giusta nozione degli dei e questo solo bastava. Perché egli li adorava con l’anima, offrendo il bene più prezioso, la consacrazione della sua anima attraverso il suo pensiero». Per Giuliano il cinismo di Diogene è come una statua di Sileno – riprendendo la metafora platonica su Socrate – che racchiude in sé l’immagine di un dio, e deriva anch’essa dal dio di Delfi, il creatore della filosofia greca. Anche tra gli stoici Diogene divenne un modello di vita e filosofia. Epitteto fa riferimento a lui nelle sue opere. Diogene il Cinico, oppure Diogene di Apollonia, viene citato da Dante nel Canto IV dell’Inferno (Divina Commedia), fra gli spiriti magni che quest’ultimo incontra nel primo Cerchio.
GLI EPICUREI
Nel 316 a.C., Epicuro (341 – 270 a.C.) fondò una scuola filosofica ad Atene e, sviluppando ulteriormente l’etica del piacere di Aristippo, la integrò con la teoria degli atomi di Democrito. Tale scuola situata in un giardino, era aperta a tutti (anche alle donne e gli schiavi). Da allora i seguaci di Epicuro (gli epicurei) vennero chiamati “quelli del giardino”.
GLI INDOEUROPEI
In sanscrito è “vidya” collegata al termine greco “idea”, latino “video” inglese “wise” saggio, e “wisdom”- saggezza, in tedesco “wissen”- sapere, in norvegese “viten” – sapere. Possiamo supporre che la “vista” fosse il senso più importante per gli indoeuropei.
Le due maggiori religioni orientali, l’induismo e il buddismo, hanno un’origine indoeuropea. Infatti nel buddismo e nell’induismo si da grande importanza alla riflessione filosofica. Per queste due religioni il divino è presente in ogni cosa (Panteismo) e l’essere umano può raggiungere l’unità con Dio attraverso la conoscenza religiosa. Perché ciò avvenga è necessario penetrare profondamente in se stessi attraverso la meditazione. In Oriente, un atteggiamento passivo, indifferente alla lusinghe del mondo, è considerato un ideale religioso. Il sistema monastico medioevale si ricollega sotto molti punti di vista a queste concezioni del mondo greco – romano. I semiti invece sono di un’area culturale completamente diversa e con un’altra lingua. Sono originari della penisola araba, ma la loro cultura si è diffusa in molte parti del mondo. Per oltre 2000 anni, gli ebrei hanno vissuto lontani dalla loro terra d’origine. La storia e la religione semitiche, si sono diffuse lontano dalle loro radici geografiche grazie al cristianesimo, si è estesa anche grazie all’espansione dell’islamismo. Tutte le religioni occidentali – ebraismo, cristianesimo e islamismo – hanno un’origine semitica. Sia il Corano, sia l’Antico Testamento sono scritti in lingue semitiche imparentate fra loro. Una delle parole che ricorre nell’Antico Testamento per indicare Dio ha la stessa radice linguistica dell’Allah dei mussulmani (Allah = Dio).
Il cristianesimo ha origini più complesse; ha origini semitiche, ma il Nuovo Testamento fu scritto in greco. Fin dagli inizi i semiti furono monoteisti, un’altra loro caratteristica è la visione lineare della storia. Un tempo Dio ha creato il mondo che finirà il giorno del giudizio. Vista l’importanza attribuita all’intervento divino nella storia, per molti secoli si sono occupati di storiografia: non ha caso le radici storiche stanno al centro delle loro sacre scritture. Gerusalemme è un centro religioso importantissimo per gli ebrei, i cristiani e i mussulmani. Anche questo dice qualcosa dell’origine storica comune di queste tre religioni. Se per gli indoeuropei il senso più importante era la vista, nell’area semitica invece fu l’udito. Non è un caso che l’atto di fede ebraico cominci con le parole: “Ascolta, Israele!”. Nell’Antico Testamento leggiamo come gli uomini “ascoltassero” la parola del Signore, e i profeti ebraici cominciavano le loro prediche con la formula: “Così dice Jahveh (Dio) “. Anche nel cristianesimo si da grande importanza all’ascolto” della parola di Dio. Le funzioni religiose ebraiche, cristiane e mussulmane sono caratterizzate dalla lettura ad alta voce.

Gli indoeuropei hanno sempre creato dipinti e sculture rappresentanti le divinità. Per i semiti invece era vietato raffigurare Dio. Nell’Islam è ancora diffusa una generale avversione verso le arti figurative e la fotografia perché l’uomo non deve concorrere con Dio nel “creare” qualcosa. Ma le chiese cristiane sono piene di immagini di Dio e di Gesù, questo costituisce un esempio di come il cristianesimo sia stato influenzato dal mondo greco-romano. Al contrario delle grandi religioni orientali, le tre occidentali pongono una netta divisione tra Dio e la sua creazione. La meta non è salvarsi dalla reincarnazione, ma essere liberati dal peccato e dalle colpe. Lo sfondo ebraico del cristianesimo. Tutto ebbe inizio quando Dio creò il mondo; a un certo punto l’uomo si ribellò a Dio. La punizione non si limitò alla cacciata di Adamo ed Eva dall’Eden: da quel momento la morte fece la sua comparsa. La disobbedienza degli uomini verso Dio rappresenta il filo conduttore di tutta la Bibbia. (Genesi – il diluvio, il patto con Abramo e il suo popolo, rinnovato quando Mosè ricevette le Tavole della Legge sul Sinai, intorno al 1200 a.C..
Nel 1000 a.C., molto tempo prima che nascesse la filosofia greca, furono i tre più grandi re d’Israele: Saul poi David e quindi Salomone. Tutti gli ebrei allora erano riuniti in un solo regno, soprattutto sotto David, vissero un periodo di splendore politico, militare e culturale. Quando i re venivano consacrati, erano unti dai sacerdoti. Per questo motivo prendevano il nome di Messia, che significa “unto”. Dal punto di vista religioso, il re era considerato un intermediario tra Dio e il popolo e per questo era chiamato anche “figlio di Dio”, mentre Israele era il “regno di Dio”. Questo “salvatore” veniva visto come un liberatore nazionale che avrebbe posto fine alle sofferenze degli ebrei sotto il dominio romano. Ma già un paio di secoli prima della nascita di Cristo, alcuni profeti ritenevano che il Messia promesso sarebbe stato il salvatore del mondo. Avrebbe liberato non solo gli ebrei ma anche tutti gli uomini dalla colpa, dal peccato e dalla morte. Nel 146 a.C., con la distruzione di Corinto, Roma conquista la Grecia e afferma definitivamente nell’area mediterranea la propria supremazia militare e politica. La nuova superpotenza conquistò tutti i regni ellenistici e, dal quel momento in poi, furono la cultura e la lingua romana a dominare dalla Spagna fino all’Asia.
RELIGIONE – FILOSOFIA – SCIENZA
Le religioni che nacquero durante l’ellenismo avevano due caratteristiche in comune: anzitutto si fondavano su dottrine che aspiravano a liberare gli esseri umani dall’angoscia della morte, inoltre erano per lo più segrete. Seguendo i loro precetti e compiendo determinati rituali, l’uomo poteva sperare di ottenere l’immortalità dell’anima e di raggiungere la vita eterna. Anche la filosofia divenne sempre più spesso una forma di salvezza e di consolazione per la vita. Il sapere filosofico infatti non solo possedeva un indiscusso valore intrinseco, ma avrebbe anche liberato l’uomo dalla paura della morte e dal pessimismo. In questo modo i confini tra religione e filosofia divennero assai labili. Anche la scienza ellenistica fu caratterizzata dalla fusione di esperienze culturali diverse. La città di Alessandria, in Egitto, svolse un ruolo chiave come punto d’incontro tra oriente e occidente. Mentre Atene conservò il suo ruolo di capitale della filosofia, Alessandria divenne il centro della scienza grazie alla sua enorme biblioteca, divenne il cuore degli studi di matematica, astronomia, biologia e medicina. La filosofia ellenistica intendeva fornire una risposta su come l’uomo avrebbe dovuto vivere e morire nel migliore dei modi. Fu dunque l’etica a far la parte del leone, e nella nuova società sovranazionale, il progetto filosofico più rilevante fu proprio questo: ci si chiedeva in che cosa consistesse la vera felicità e in quale modo fosse possibile raggiungerla. Correnti filosofiche che si occuparono di tali questioni.

Epicuro
Epicuro sottolineò che il risultato di un’azione incentrata sul piacere deve essere sempre valutato alla luce di eventuali effetti collaterali. Secondo Epicuro, il piacere non corrisponde necessariamente al godimento fisico, ma anche a valori come l’amicizia o l’apprezzamento di un’opera d’arte. La padronanza di sé, la temperanza e la serenità d’animo – ideali ricorrenti nella cultura greca fin dall’antichità rappresentano condizioni indispensabili per godere la vita: i desideri e le passioni infatti non vanno assecondati, ma dominati. “Il più terribile dei mali, la morte, non è niente per noi, dal momento che, quando noi ci siamo, la morte non c’è, e quando essa arriva, noi non siamo più”. E’ assurda la paura della morte, la quale non è nulla; il piacere, quando lo si intende correttamente, è a disposizione di tutti. Paragonare il compito del filosofo a quello del medico non era un fatto nuovo nel pensiero greco. Secondo Epicuro, l’uomo deve dotarsi di una “farmacia ambulante filosofica”. A differenza degli stoici, gli epicurei mostrarono uno scarso interesse per la politica e la società. “Vivi nascosto!”. Alla morte di Epicuro, alcuni dei suoi seguaci si orientarono unicamente verso una ricerca affannosa del piacere. Il motto divenne: “vivi l’istante”. Il termine epicureo viene oggi usato con significato dispregiativo per indicare una persona dedita soltanto ai piaceri mondani.
Nel 146 a.C. con la distruzione di Corinto, Roma conquista la Grecia e afferma nell’area mediterranea la propria supremazia militare e politica. Prima che Roma riuscisse a conquistare il mondo ellenistico, da un punto di vista culturale era una provincia greca, per cui la cultura e la filosofia greca continuarono a svolgere un ruolo importante anche dopo il tramonto politico della Grecia (dominio durato 300 anni).
SCETTICISMO
Lo scetticismo dichiara che l’uomo non può accedere alla verità ultima delle cose e che la più alta forma di intelligenza e di saggezza consiste proprio nel riconoscere questo fatto, inequivocabilmente dimostrato, secondo gli scettici, dalla molteplicità delle filosofie e delle teologie in lotta fra loro. Il fondatore fu Pirrone che visse in semplicità e morì vecchissimo verso il 270 a. C., partecipò alla Campagna d’Oriente con Alessandro Magno.
GLI STOICI
Il fondatore fu Zenone di Cizio, giunse ad Atene intorno al 312 a.C. e seguì gli insegnamenti di maestri cinici. Verso il 300 a.C. Zenone fondò la sua scuola e, dato che era solito accogliere i suoi ascoltatori sotto un portico, (in greco stoà) essa fu chiamata “stoica”. Come per Eraclito, anche per gli stoici tutti gli uomini partecipano della stessa ragione del mondo, o lògos; inoltre, ogni essere umano è un mondo in miniatura, un microcosmo che è riflesso del macrocosmo. Questa teoria portò alla convinzione che esiste un “diritto di natura”. Il diritto di natura che non muta nel tempo e nello spazio vale per tutti gli esseri umani, anche per gli schiavi. Per gli stoici le legislazioni dei diversi Stati erano soltanto copie imperfette di un “diritto” che si trova nella natura stessa. In questo modo, gli stoici eliminarono la differenza tra il singolo individuo e l’universo e negarono anche l’ipotesi che esiste un’opposizione tra spirito e materia, tale concezione viene chiamata “monismo” a differenza del chiaro “dualismo” di Platone.

Marco Aurelio

Cicerone

Lucio Anneo Seneca
Lo stoico Seneca (4 a.C. – 65 d.C.) disse alcuni anni più tardi che l’uomo è per l’uomo qualcosa di sacro, affermazione che diverrà il motto di tutto l’umanesimo. Gli stoici sottolinearono anche che tutti i processi naturali compresa la malattia e la morte, seguono le leggi immutabili della natura, e quindi l’uomo deve assecondare il proprio destino; analogamente anche le circostanze liete vanno vissute con tranquillità. Tale posizione è simile a quella dei cinici, i quali sostenevano la necessità di rimanere distaccati in ogni circostanza.
IL NEOPLATONISMO
I cinici, gli stoici e gli epicurei si rifacevano al pensiero socratico. Inoltre accoglievano motivi propri dei presocratici come Eraclito e Democrito. La corrente più importante si ispirò alla dottrina delle idee di Platone e per questo venne chiamata neoplatonismo.
Il suo esponente più significativo fu Plotino. Nato a Licopoli, in Egitto, tra il 202 e il 205 d.C., studiò filosofia ad Alessandria, città che per molti secoli era stato punto di incontro tra la filosofia greca e la mistica orientale. Intorno ai quarant’anni si trasferì a Roma, portandovi una dottrina di salvezza che, per così dire, entrò in concorrenza con quella cristiana, che proprio allora cominciava ad acquistare una certa importanza. Comunque il platonismo avrebbe esercitato una forte influenza sulla teologia cristiana. Platone distingueva tra il mondo delle idee e il mondo sensibile. Analogamente aveva introdotto una netta divisione tra l’anima umana e il corpo umano. Il corpo fatto di terra e polvere come tutto ciò che appartiene al mondo sensibile, l’anima immortale. Questa concezione era assai diffusa tra i greci già molto tempo prima di Platone. Plotino inoltre conosceva bene le concezioni analoghe diffuse in Asia. Alcune volte, nel corso della sua vita visse un’esperienza mistica: sentì cioè la sua anima fondersi con Dio. Si parla di un’esperienza mistica quando si ha il senso di un’unità con Dio o con l’anima del mondo. Alla base di questa esperienza c’è il sentimento che quello che noi chiamiamo “io” in realtà non sia il nostro vero io. Per brevi attimi ci possiamo sentire parte di un io più grande. Alcuni mistici lo chiamano Dio, per altri è l’anima del mondo o la natura nella sua totalità. Una volta un mistico disse: “Quando esisteva il mio io, non esisteva Dio. Adesso esiste Dio e io non esisto più”. Il mistico cristiano Angelus Silesius (1624-1677) affermò: “Oceano diventa ogni goccia quando raggiunge l’oceano e così l’anima diventa Dio quando raggiunge Dio”.
Fino al 300 il culto cristiano era perlopiù proibito, però nell’anno 313, il cristianesimo divenne una religione riconosciuta nell’impero romano: ciò avvenne sotto l’imperatore Costantino. Dal 380 divenne religione di Stato in tutto l’impero romano. Ma le fondamenta dell’impero romano avevano cominciato a scricchiolare. E’ stato uno dei mutamenti culturali più importante della storia. A partire dal 300, Roma venne minacciata sia dai popoli che premevano a Nord sia da conflitti interni. Nel 330 l’imperatore Costantino trasferì la capitale dell’impero romano a Costantinopoli, città che lui stesso aveva fondato sul mar Nero e che venne considerata la seconda Roma. Trasportando la capitale da Roma a Bisanzio, che prese il nome di Costantinopoli, diede il pratico avvio alla formazione dell’impero bizantino. Con l’instaurazione di un sistema di successione dinastica, l’adozione delle insegne del potere proprie dei despoti orientali e l’attuazione di un imponente complesso di riforme militari e amministrative in senso accentratore, concluse la trasformazione dell’impero in monarchia assoluta.
Nel 395 l’impero romano fu diviso in due: l’impero romano d’occidente, con Roma al centro e l’impero romano d’oriente con Costantinopoli come capitale. Nel 410 Roma, sotto l’imperatore Onorio, (Costantinopoli, 384 – Ravenna, 423) fu saccheggiata da tribù barbare guidate da Alarico e nel 476 l’impero romano d’occidente cessò di esistere. Quello d’oriente sopravvisse come Stato fino al 1453, quando i Turchi conquistarono Costantinopoli, e la città prese il nome di Istanbul. Un’altra data importante da ricordare è il 529: in quell’anno fu chiusa l’Accademia di Platone ad Atene e sempre nello stesso anno, fu istituito l’ordine dei Benedettini, il primo grande ordine monastico. Il 529 fu l’anno in cui la Chiesa cristiana pose un freno alla filosofia greca. Da allora, i monasteri e le abbazie ebbero il monopolio dell’insegnamento, sulle speculazioni filosofiche e su ogni tipo di approfondimento spirituale. Quando il cristianesimo penetra nel mondo greco – romano, avviene uno scontro drammatico tra due aree culturali, uno scontro gravido di conseguenze che implica tra l’altro uno dei più grandi mutamenti culturali della storia. Siamo nel punto di abbandonare l’antichità. Sono trascorsi quasi mille anni dai primi filosofi greci. Davanti abbiamo il Medioevo cristiano. Anche questo durò all’incirca mille anni.
Con Medioevo si intende il periodo che intercorre tra due altre epoche. Questo termine viene coniato nel Rinascimento che considerò il Medioevo una “notte lunghissima durata mille anni”, scesa sull’Europa tra l’antichità e il Rinascimento. Ancora oggi il termine “medioevale” ha un senso negativo: indica qualcosa di ottuso, di retrogrado. Tuttavia è stato anche definito “un periodo di crescita durato mille anni”. Per esempio, fu proprio nel Medioevo che il sistema scolastico prese forma. Già all’inizio del Medioevo nei monasteri sorsero le prime scuole, a partire dal XII secolo nacquero anche quelle annesse alle cattedrali e intorno al XIII secolo vennero fondate le prime università. Ancora oggi le materie le materie vengono suddivise in gruppi diversi o facoltà come si faceva nel Medioevo. Mille anni sono un arco di tempo molto lungo. Ma il cristianesimo ebbe bisogno di molto tempo per penetrare in profondità tra la gente. Nel corso del Medioevo nacquero anche le diverse nazioni, con città borghesi, la musica e la poesia popolari, personaggi fiabeschi come Biancaneve e una folta schiera di splendidi principi e maestosi re, coraggiosi cavalieri e splendide e leggiadre donzelle. Il Medioevo non fu soltanto un periodo buio e triste, ma in particolare i primi secoli furono davvero una fase di decadenza culturale.
L’epoca romana si era contraddistinta per il suo alto grado di civiltà. Le città erano dotate di un sistema fognario pubblico, come erano pubblici i bagni e le biblioteche, per non parlare delle imponenti realizzazioni architettoniche. Questa cultura si disintegrò nei primi secoli del Medioevo e ciò coinvolse anche il commercio e l’economia basata sul denaro. Nel Medioevo si assisté al ritorno di un’economia di sussistenza del tipo domestico e alla forma di baratto, soprattutto per quanto riguardava i prodotti in natura. L’economia fu caratterizzata anche dal feudalesimo, in cui alcuni grandi signori, feudatari, possedevano la terra che i contadini dovevano coltivare per avere di che vivere. Anche la popolazione calò notevolmente nei primi secoli. Roma, per esempio, aveva raggiunto durante l’antichità un milione di abitanti, ma giù nel 600 il loro numero si era ridotto a quarantamila. Una sparuta popolazione circolava tra i resti delle imponenti costruzioni erette durante il periodo di massimo splendore e, quando c’era bisogno di materiale da costruzione, bastava andare a prendere quello delle rovine.
La potenza politica di Roma si dissolse sul finire del 300 d.C., ma il vescovo di Roma divenne ben presto l’autorità suprema di tutta la Chiesa cattolica. Fu chiamato “papa” o “padre”, e venne considerato il vicario di Gesù sulla terra.. Così Roma assunse la funzione di “capitale della Chiesa”. Il vecchio impero romano si divise a poco a poco in tre aree culturali: nell’Europa occidentale si diffuse una cultura cristiana di lingua latina, con Roma capitale; nell’Europa orientale una cultura cristiana di lingua greca: la capitale era Costantinopoli, che in seguito prese il nome greco di Bisanzio. Ma anche l’Africa settentrionale e il Medio Oriente avevano fatto parte dell’impero romano. In quest’area si sviluppò nel Medioevo una cultura musulmana in lingua araba.
Dopo la morte di Maometto, avvenuta nel 632, sia il Medio Oriente sia l’Africa settentrionale si convertirono all’islamismo. Quest’area culturale araba includeva anche parte della Spagna. L’Islam ebbe i suoi luoghi sacri come la Mecca, Medina, Gerusalemme e Bagdad. Dal punto di vista storico-culturale è importante ricordare che l’antica città ellenistica di Alessandria venne conquistata dagli arabi che ebbero così modo di assimilare la scienza greca. Per tutto il Medioevo, gli arabi furono all’avanguardia nelle scienze quali la matematica, l’astronomia e la medicina. Ancora oggi usiamo i “numeri arabi” e in molti ambiti la cultura araba fu superiore a quella cristiana. La filosofia greca fu come un grande fiume che per un tratto si divide in tre corsi d’acqua che poi si ricongiungono.
La cultura greco-latina venne trasmessa in parte attraverso quella cattolico – romana a occidente, in parte attraverso la cultura romano orientale e in parte attraverso la cultura araba a sud. Semplificando, si può dire che il neoplatonismo fu trasmesso a ovest, la dottrina di Platone a est e quella di Aristotele presso gli arabi a sud, anche se in ognuno di questi tre corsi d’acqua erano comunque presenti tracce di tutto il resto. Il punto fondamentale è che sul finire del Medioevo questi tre fiumi confluiscono nell’Italia settentrionale. L’influenza araba giunse dagli arabi di Spagna, quella greca dalla Grecia e da Bisanzio.
Comincia il “Rinascimento”, la rinascita della cultura dell’antichità e quindi, in un modo o nell’altro, la cultura greca sopravvisse al lungo Medioevo. I filosofi del Medioevo diedero praticamente per scontato che il cristianesimo fosse fonte di verità. Le questioni principali erano altre: bisognava soltanto credere alla rivelazione cristiana o ci si poteva avvicinare alle verità cristiane con l’aiuto della ragione? Che relazione c’era tra i filosofi greci e quanto era contenuto nella Bibbia? Esisteva una contraddizione di fondo tra la Bibbia e la ragione, o era possibile conciliare la fede e il sapere? Quasi tutta la filosofia medioevale si occupò di queste domande.
I due maggiori filosofi medioevali furono Agostino e Tommaso d’Aquino. Agostino (354 – 430) nacque a Tagaste, oggi Souk-Ahras, Numidia – morì a Ippona, oggi Bona, Africa settentrionale. All’età di sedici anni si trasferì a Cartagine a studiare. In seguito si recò a Roma e a Milano, e trascorre gli ultimi anni della sua vita come vescovo di Ippona, alcune miglia a est di Cartagine.

Sant’Agostino d’Ippona

San Tommaso d’Aquino
Agostino non fu sempre cristiano. Conobbe molte religioni e correnti filosofiche prima di convertirsi al cristianesimo. Per un certo periodo di tempo fu manicheo. I manichei erano una setta religiosa della tarda antichità, con una dottrina di salvezza in parte religiosa in parte filosofica. Il pensiero centrale era che il mondo fosse diviso in bene e male, spirito e materia. Attraverso lo spirito, l’uomo poteva sollevarsi al di sopra della materia del mondo e porre così le basi per la salvezza della sua anima. Questa divisione rigorosa tra bene e male non dava pace al giovane Agostino, che nutriva un profondo interesse per il “problema del male”. Agostino si interrogava su quale fosse l’origine del male. Per un certo periodo venne influenzato dalla filosofia stoica e, secondo gli stoici, non esisteva nessuna rigida suddivisione tra il bene e il male; ma soprattutto subì l’influsso dell’altra importante corrente filosofica della tarda antichità: il neoplatonismo, con la sua concezione che l’intera esistenza sia di natura divina. Agostino divenne cristiano, ma il suo cristianesimo è profondamente influenzato dal modo di pensare platonico.
Nel Medioevo cristiano non si ha una evidente rottura nei confronti della filosofia greca: anzi, buona parte di essa penetrò in questo nuovo periodo. E ciò avvenne grazie ai Padri della Chiesa, come Agostino. Egli individuava somiglianze così evidenti tra la filosofia platonica e dottrina cristiana che si chiese se Platone non avesse conosciuto l’Antico Testamento, almeno in parte. È poco probabile. Agostino affermò che, in merito alle questioni religiose, esistono dei limiti che la ragione non può superare. Il cristianesimo è un mistero divino cui possiamo avvicinarci soltanto con la fede. Era arrivato alla conclusione che la filosofia aveva dei limiti al di là dei quali non si poteva andare. Agostino affermò che Dio aveva creato il mondo dal nulla, e questo è un pensiero biblico. I greci erano inclini a credere che il mondo fosse sempre esistito. Tuttavia, prima che Dio creasse il mondo, le “idee” esistevano nella Sua mente, diceva Agostino. Quindi per lui le idee platoniche erano in Dio e in questo modo tenne conto della concezione platonica delle idee eterne. Era d’accordo con Plotino nell’affermare che il male non ha un’esistenza reale e autonoma perché è “assenza di Dio”: in altre parole non esiste, in quanto la creazione di Dio è solo buona. Il male è causato dalla disobbedienza degli uomini, diceva Agostino, e afferma che esiste un insormontabile divario tra Dio e il mondo. Si rifà quindi alla Bibbia e rifiuta la dottrina di Plotino secondo il quale tutto è uno. Ma afferma anche che l’uomo è un essere spirituale: ha un corpo materiale, appartenente al mondo fisico che gli agenti materiali corrodono, ma possiede anche un’anima in grado di conoscere Dio.
Secondo Agostino, tutto il genere umano si è dannato dopo il peccato originale: ciò nonostante Dio ha deciso che alcuni saranno salvati dalla dannazione eterna. In merito al disegno divino Agostino nega che un uomo abbia il diritto di criticare Dio. Nell’affermare questo, fa riferimento a ciò che Paolo scrisse nella Lettera ai Romani: “Ma chi sei tu, o uomo, che ti metti in contraddittorio con Dio? Dirà forse l’oggetto plasmato a colui che lo plasmò: perché mi facesti così? O non ha forse il vasaio piena disponibilità sull’argilla, così da fare della stessa massa argillosa un vaso destinato a un uso onorifico e un vaso destinato a un uso banale?”. Ma Agostino non toglie all’uomo la responsabilità nei confronti della propria vita: possediamo il libero arbitrio, quindi possiamo scegliere come vivere. Secondo Socrate tutti gli uomini hanno le stesse possibilità perché tutti sono dotati della stessa ragione. Agostino invece divide gli uomini in due gruppi, dove uno viene salvato e l’altro no. Con la teologia di Agostino ci si è allontanati dall’umanesimo di Atene. Comunque non fu Agostino a dividere gli uomini in due gruppi: si richiama all’insegnamento contenuto nella Bibbia sulla salvezza e sulla dannazione approfondendo questo tema in una grande opera “De Civitate Dei” (La Città di Dio). L’espressione “Città di Dio” o “Regno di Dio” deriva dalla Bibbia e dalla predicazione di Gesù. Secondo Agostino, è il conflitto tra la città di Dio e la città terrena: la prima aspira alla gloria divina e vive secondo principi di carità e amore; la seconda aspira alla gloria degli uomini ed è dominata da una stolta cupidigia di predominio. Sebbene scelga come simboli Gerusalemme e Roma, nella sua opera, non fa mai coincidere la città di Dio con la Chiesa (perché, dice, anche la Chiesa ha il buono e cattivo). Tuttavia questa fu l’interpretazione che si impose (anche in seguito alla lotta per il potere tra la Chiesa e lo Stato che si protrasse per tutto il Medioevo) e la città di Dio di Agostino finì con l’identificarsi in tutto e per tutto con la Chiesa come istituzione. “Non c’è salvezza al di fuori della Chiesa” si diceva.
Soltanto con la Riforma nel XVI secolo ci si oppose al fatto che l’uomo dovesse passare attraverso la Chiesa per ottenere la salvezza di Dio. È importante tenere presente che Agostino fu il primo filosofo a inserire la storia nella sua filosofia, richiamandosi alla concezione lineare della storia contenuta nell’Antico Testamento, secondo la quale, Dio si serve della storia per realizzare la Città di Dio. La storia è necessaria per educare gli uomini e per annientare il male, per usare le parole di Agostino: “La Divina Provvidenza guida la storia dell’umanità da Adamo sino alla fine della storia, come se la storia fosse un singolo essere umano che si sviluppa gradualmente dall’infanzia alla vecchiaia”. Prima di arrivare al secondo grande filosofo medioevale, Tommaso d’Aquino, trascorrono alcuni secoli nei quali sono i monasteri a dominare l’insegnamento, questo fino all’anno mille. Poi vengono fondate le prime scuole annesse alle cattedrali e nel XII secolo le prime università. Vengono costruite le prime cattedrali gotiche. Le cattedrali furono costruite soltanto per accogliere grandi comunità di fedeli. Furono innalzate in onore a Dio e rappresentano in sé una specie di funzione religiosa. Nell’Alto Medioevo cominciò a farsi sentire l’influenza degli arabi di Spagna. Per tutto il Medioevo gli arabi mantennero viva la tradizione aristotelica con commenti e traduzioni del filosofo greco che vennero poi tradotti in latino e fatti conoscere in occidente. Questo fatto creò un rinnovato interesse per le scienze naturali. Inoltre ripropose il problema del rapporto tra la rivelazione cristiana e la filosofia greca. Ormai nelle questioni proprie alle scienze naturali, il ricorso ad Aristotele divenne obbligato.
Tommaso d’Aquino, il più importante filosofo e teologo medioevale (1225 – 1274), era originario della cittadina di Aquino, tra Roma e Napoli, ma operò anche come maestro in teologia a Parigi. Si può dire che Tommaso “cristianizzò” Aristotele come Agostino, all’inizio del Medioevo, aveva cristianizzato Platone. Quando si parla di cristianizzazione dei due grandi filosofi greci, si intende che furono interpretati e spiegati in modo da non rappresentare più una minaccia per la dottrina cristiana. Tommaso fu tra quelli che cercarono di conciliare la filosofia di Aristotele con il cristianesimo. Creò la grande sintesi tra la fede e il sapere. Secondo Tommaso non esisteva necessariamente una contraddizione tra quello che dice la filosofia, o la ragione, e quello che dice la rivelazione cristiana, o la fede. Per questo, con l’aiuto della ragione, possiamo giungere alle stesse verità contenute nella Bibbia. Per Tommaso ci sono due strade per arrivare a Dio: la prima attraverso la rivelazione o la fede, la seconda attraverso la ragione e l’osservazione basata sui sensi. Di queste due strade , la prima è la più sicura, perché è facile sbagliarsi se si fa affidamento soltanto alla ragione. Per Tommaso era importante dimostrare che esiste una sola verità. Un’affermazione di Aristotele, giusta in base alla ragione, non è in contrasto con la dottrina cristiana. Noi possiamo raggiungere una parte della verità con l’aiuto della ragione e dell’osservazione basata sui sensi: quando Aristotele descrive il regno vegetale o animale, parla di queste verità. Dio attraverso la Bibbia ci ha rivelato l’altra parte. Tuttavia queste due parti coincidono in diversi punti.
Esistono domande cui la Bibbia e la ragione rispondono allo stesso modo. Per esempio: Dio esiste? Anche la filosofia di Aristotele partiva dal presupposto che esiste un Dio, un primo motore, che mette in moto tutti i processi naturali, ma non fornisce una precisa descrizione di Dio. Su questo punto dobbiamo attenerci esclusivamente alla Bibbia e alla predicazione di Gesù. Anche con la ragione possiamo comprendere che tutto ciò che ci circonda deve avere “una causa prima” diceva Tommaso. Esistono dunque sia una “teologia rivelata” sia una “teologia naturale”. Questo vale anche per l’etica: La Bibbia ci spiega come Dio vuole che viviamo. Ma Dio ci ha dato anche una coscienza, la quale ci permette di distinguere ciò che è giusto da ciò che è sbagliato partendo da una base naturale. Sappiamo che è sbagliato fare del male a qualcuno anche se non abbiamo letto la Bibbia. È più o meno come quando sappiamo che c’è il temporale perché vediamo il lampo e sentiamo il tuono. Anche se siamo ciechi, possiamo sentire il tuono e se siamo sordi possiamo vedere il lampo. Naturalmente la cosa migliore è vedere e sentire, ma non esiste contraddizione tra quello che vediamo e quello che sentiamo. Tommaso riprese la filosofia di Aristotele in quegli ambiti in cui essa non entrava in contraddizione con la teologia cristiana, vale a dire che la logica, la teoria della conoscenza e la filosofia della natura. Pochi anni dopo la morte di Tommaso d’Aquino, l’unità culturale cristiana cominciò a incrinarsi. La filosofia e la scienza si staccarono sempre più dalla teologia della Chiesa, e questo comportò anche per la religione un rapporto più libero con la ragione. Molti pensatori sostennero che era impossibile avvicinarsi a Dio per mezzo dell’intelletto perché Dio rimaneva comunque incomprensibile alla nostra mente. Per l’uomo, la cosa più importante non era capire il mistero cristiano, bensì sottomettersi alla volontà di Dio. La maggior libertà di rapporti tra religione e scienza aprì la strada a un nuovo metodo scientifico e a un nuovo fervore religioso che determinarono, nel Quattrocento e nel Cinquecento, la nascita di due importanti movimenti:
IL RINASCIMENTO E LA RIFORMA
Con il temine Rinascimento (Rinascita) si fa riferimento a un periodo storico contraddistinto da una grandiosa fioritura culturale che ebbe inizio a partire dal XIV secolo. Ebbe origine in Italia, ma si diffuse rapidamente in quasi tutta Europa fra XV e il XVI secolo. Ciò che rinacque furono la cultura e le arti antiche. Si parla di “Umanesimo rinascimentale” perché l’uomo tornò a essere il punto di partenza e il centro di tutto, dopo che nel Medioevo ogni aspetto della vita era interpretato alla luce di Dio. Il motto di questo periodo fu “ritornare alle fonti”, in primo luogo quelle dell’Umanesimo antico. Si riaccese l’interesse per la cultura greca, anche perché la si considerava importante da un punto di vista pedagogico: attraverso lo studio delle materie umanistiche si raggiungeva infatti una formazione classica che incoraggiava lo sviluppo delle qualità umane. L’idea di fondo era: “Dobbiamo ricevere un’educazione per diventare esseri umani”. Presupposti fondamentali per l’evoluzione di quel periodo furono alcune scoperte tra cui la bussola, la polvere da sparo e l’arte della stampa. La bussola fu un elemento chiave per i viaggi d’esplorazione. Le nuove armi resero gli europei militarmente superiori. L’arte della stampa fu determinante nella diffusione del pensiero rinascimentale e contribuì a infrangere il monopolio della Chiesa, fino allora unica intermediaria del sapere. In seguito, le invenzioni di nuovi strumenti si susseguirono a grande velocità: il cannocchiale, per esempio, destinato a rivoluzionare l’astronomia.
Vi furono profondi mutamenti nel campo della cultura e dell’economia. Presupposto fondamentale fu il passaggio da un’economia domestica a un’economia monetaria: sul finire del Medioevo, si erano sviluppati nelle città un solido artigianato e un attivo commercio di merci nuove che portarono a una notevole circolazione di denaro e alla creazione del sistema bancario. Nacque così una borghesia affrancata dalle condizioni imposte dalla natura. Tutto ciò che era necessario per vivere poteva essere acquistato con il denaro. Questa evoluzione favorì e sollecitò la fantasia, l’iniziativa e le capacità del singolo individuo. Come la filosofia greca si era staccata dall’immagine mitologica del mondo, analogamente, i borghesi del Rinascimento cominciarono a liberarsi dei feudatari e del potere della Chiesa. Questa evoluzione fu parallela alla riscoperta della cultura greca, resa possibile da un contatto più stretto con gli arabi di Spagna e con la cultura bizantina in Oriente. Anzitutto il Rinascimento portò a una nuova concezione dell’essere umano. Gli umanisti rinascimentali avevano una fede nuova nell’uomo e nel suo valore, una fede che era in netto contrasto con l’insistenza monocorde sulla natura peccaminosa dell’essere umano che aveva caratterizzato tutto il Medioevo.
L’uomo veniva adesso considerato come un essere infinitamente grande e prezioso. Il Rinascimento fu caratterizzato da un più profondo individualismo: non siamo semplicemente uomini, bensì individui unici, e tale pensiero portò al culto del genio. Il nuovo ideale fu il cosiddetto “uomo rinascimentale”, cioè un essere umano impegnato in tutti i campi del sapere, delle arti e delle scienze. La rinnovata attenzione all’uomo determinò anche un profondo interesse per l’anatomia e, come nell’antichità, si ritornò a sezionare i cadaveri per capire come fosse costruito il corpo umano.

Davide di Michelangelo
Un passo importante sia per la scienza sia per l’arte, dove si ritornò a rappresentare l’uomo nudo, si può dire, dopo mille anni di pudore. L’essere umano osò nuovamente essere se stesso: non aveva più nulla di cui vergognarsi. L’essere umano non esisteva soltanto in funzione di Dio, ma Dio aveva creato l’uomo anche in funzione dell’uomo stesso, il quale poteva dunque vivere con gioia la propria vita. Inoltre, dato che poteva svilupparsi liberamente, aveva di fronte a sé un numero infinito di possibilità. La meta era superare ogni limite, e anche questo era nuovo rispetto all’umanesimo antico, che insisteva invece sulla temperanza, sulla serenità e sul dominio di sé, per ciò gli uomini del Rinascimento non furono particolarmente moderati perché sentivano che tutto il mondo si era risvegliato. E c’era una profonda consapevolezza di appartenere a un’epoca.
Fu proprio in quel periodo che fu coniata la parola “Medioevo” come denominazione dell’arco di tempo intercorso tra l’antichità e questa epoca. Si verificò una fioritura senza uguali che investì tutti i campi, dall’arte all’architettura, dalla letteratura alla musica, dalla filosofia alla scienza. Ad esempio: Roma antica, che veniva chiamata “la città delle città” e “il centro del mondo”, durante il Medioevo la città attraversò un periodo di grande decadenza e, nel 1417, contava soltanto 17.000 abitanti. L’obiettivo politico – culturale degli umanisti rinascimentali fu far rinascere Roma. I papi, alcuni dei quali essi stessi umanisti, intrapresero la ricostruzione e l’ampliamento dell’antica basilica di San Pietro, sorta sulla tomba dell’apostolo. Alcune delle più grandi figure del Rinascimento furono coinvolte nel più imponente progetto del mondo; la basilica ha una lunghezza di ca. 200 m., un altezza di 130 m. alla cupola e una superficie di oltre 15.000 mq.. Avviati nel 1506, i lavori di ricostruzione continuarono per centoventi anni, e ne trascorsero altri cinquanta prima che la piazza antistante la basilica fosse finita.
Nel Rinascimento si formò anche una nuova visione della natura. Che l’uomo vivesse con gioia la sua esistenza, senza più considerare la vita sulla terra come una preparazione alla vita celeste, modificò l’atteggiamento verso il mondo fisico. La natura venne considerata come qualcosa di positivo e, secondo molti pensatori, Dio era presente nel creato perché, essendo Egli infinito, doveva trovarsi ovunque. Questa concezione venne chiamata “Panteismo”. I filosofi medioevali avevano affermato che esisteva un’insormontabile divisione tra Dio e il creato. Adesso si diceva che la natura era divina, era una manifestazione di Dio. Queste nuove idee non vennero sempre accolte con benevolenza dalla Chiesa e un esempio drammatico di tale ostilità ci viene offerto dalla vicenda di un filosofo, Giordano Bruno.

Giordano Bruno
Egli affermò non soltanto che Dio è presente in natura – la quale è tutta viva, animata – ma anche che il cosmo è infinito. Fu condannato come eretico e arso vivo in Campo de’ Fiori, a Roma, nel 1600. Questo esempio dimostra che, durante il Rinascimento, si manifestò anche quello che si può definire “antiumanesimo” espressione autoritaria del potere della Chiesa e dello Stato. Fu il periodo dei processi alle streghe, dei roghi degli eretici, della magia e della superstizione, di sanguinose guerre di religione e della brutale conquista dell’America: l’Umanesimo si sviluppò su uno sfondo molto cupo. Nessuna epoca è o soltanto buona o soltanto cattiva. Tuttavia il presupposto fondamentale dello sviluppo tecnico, successivo al Rinascimento, fu la nascita di un nuovo metodo scientifico, cioè di un nuovo atteggiamento nei confronti della scienza. Si basava innanzi tutto su un’indagine della natura compiuta ricorrendo ai propri sensi. Già a partire dal XIV secolo molti studiosi presero a criticare la fede cieca nelle autorità, rappresentate dai dogmi della Chiesa e dalla filosofia della natura di Aristotele.
Nel Rinascimento si affermò l’importanza dell’osservazione diretta, dell’esperienza e della sperimentazione di ogni indagine sulla natura: questo metodo venne chiamato “empirico”. A partire dal Rinascimento, l’uomo non è più soltanto una parte del creato. L’uomo agisce direttamente sulla natura e la plasma secondo le proprie esigenze. Gli uomini avevano camminato sotto il cielo, levando lo sguardo verso il Sole, la luna, le stelle e i pianeti, ma non avevano mai messo in dubbio che la Terra fosse il centro dell’universo. Nessuna osservazione aveva mai confutato la certezza che la terra fosse ferma e che gli altri “corpi celesti” le orbitassero intorno: visione chiamata “geocentrica”. La concezione cristiana di Dio che troneggia su tutti i corpi celesti contribuì a conservare questa visione del mondo. Nel 1543 fu pubblicato uno studio intitolato “Sui movimenti delle sfere celesti”, fatto dall’astronomo polacco Niccolò Copernico, che morì lo stesso giorno in cui uscì il libro. Secondo Copernico, non è il sole a ruotare intorno alla terra, bensì il contrario e le sue osservazioni confermavano questa ipotesi. Secondo lui, gli uomini avevano creduto che il Sole ruotasse intorno alla Terra perché la Terra ruotava sul proprio asse. Copernico mostrò che sia la Terra sia gli altri pianeti avevano un moto circolare intorno al Sole. Questa visione del mondo viene chiamata eliocentrica.

Niccolò Copernico
Ma anche l’ipotesi di Copernico non è del tutto corretta perché affermò che il sole è il centro dell’universo. Oggi sappiamo che il Sole è solo una delle innumerevoli stelle esistenti nel cosmo, e che tutte le stelle che ci circondano formano soltanto una dei miliardi di galassie. Copernico credeva anche che la terra e gli altri pianeti si muovessero circolarmente intorno al Sole. La sua cosmologia era ancora legata alla vecchia concezione secondo la quale i corpi celesti erano perfettamente sferici e si muovevano seguendo orbite circolari. Fin dai tempi di Platone, la sfera e il cerchio erano considerati le figure geometriche perfette, ma all’inizio del Seicento, l’astronomo tedesco Keplero, poté dimostrare che i pianeti si muovono seguendo una traiettoria ellittica, inoltre che la velocità dei pianeti è massima quando sono vicini al Sole, più lenta quando la loro orbita è lontana dal Sole. Soltanto con Keplero si cominciò a prendere in considerazione l’idea che la Terra fosse un pianeta come tutti gli altri: egli sostenne infatti che l’intero universo è governato dalle stesse leggi fisiche.
Quasi contemporaneo di Keplero fu Galileo Galilei. Galileo usava il cannocchiale per esaminare i corpi celesti: studiò i crateri lunari e affermò che la Luna aveva monti e valli come la Terra. Scoprì che Giove aveva quattro lune, quindi la Terra non era l’unico pianeta ad avere una Luna.

Galileo Galilei
Ma cosa più importante Galileo fu il primo a formulare il cosiddetto “principio d’inerzia”; cioè: “un corpo rimane nel suo stato di quiete o di moto – finché non intervengono forze esterne sufficienti a modificare tale stato” Galileo lo utilizzò per confutare una diffusa obiezione alla tesi che la Terra ruoti intorno al proprio asse: se così fosse, si diceva, lanciando verso l’alto in linea retta una pietra, cadrebbe a molti metri di distanza dal punto in cui è stata scagliata, questo non avviene perché ci si trova in un “sistema chiuso” cioè l’aria circostante della terra si muove insieme a essa e i corpi cadono come se la Terra fosse immobile; “principio della relatività galileiana”. La descrizione definitiva del sistema solare e del movimento dei pianeti la si deve a Isaac Newton, (1642 – 1727), che non si limitò a illustrare come avviene il movimento dei pianeti intorno al Sole, ma ne spiegò anche il perché. E fu in grado di farlo anche grazie ai principi formulati da Galileo. Già Keplero aveva osservato che doveva esistere una forza tale per cui i corpi celesti si attraessero a vicenda. Ci doveva essere una forza che manteneva i pianeti nelle loro orbite. Questa forza poteva anche fornire una spiegazione al perché la velocità dei pianeti cambia in rapporto della loro distanza dal Sole. Secondo Keplero, anche l’alta e bassa marea erano causate da una forza proveniente dalla luna. Galileo, a torto, negò questa tesi pensando che le forze di gravitazione non erano in grado di agire a grande distanza, quindi tra i corpi celesti. Newton formulò la “legge della gravitazione universale”: “un oggetto ne attrae un altro con una forza che aumenta in rapporto alla massa degli oggetti e diminuisce in relazione all’aumentare della distanza degli oggetti”.
Newton affermò che quest’attrazione è universale, cioè vale ovunque, anche nello spazio fra i corpi celesti. Si dice che gli fosse venuta quest’idea un giorno quando vide cadere una mela da un albero, si chiese se la luna venisse attratta verso la terra dalla stessa forza e se era per questo che la luna continua a ruotare intorno alla terra. Newton affermò anche che alcune regole fisiche valgono ovunque, in tutto l’universo, e le mise a punto servendosi dei risultati raggiunti da Galileo.

Isaac Newton
Fu in grado di spiegare perché tutti i pianeti ruotano intorno al Sole. La traiettoria ellittica compiuta dai pianeti intorno al Sole è il risultato di due moti diversi: il primo è rettilineo e fu impresso ai pianeti quando si formò il sistema solare, mentre il secondo è un moto diretto verso il sole dovuto alla gravitazione o forza di gravità. La concezione eliocentrica del mondo aveva ottenuto la sua spiegazione definitiva. La nuova concezione del mondo fu sotto molti aspetti un duro colpo, simile a quello che l’umanità dovrà subire nell’Ottocento a causa delle teorie evoluzionistiche di Charles Darwin. In entrambi i casi gli uomini dovettero rinunciare, almeno in parte, alla loro posizione di privilegio nel creato, e in entrambi i casi la Chiesa si oppose strenuamente. La fede di Newton in Dio non vacillò affatto: al contrario, egli considerava le leggi naturali una testimonianza della potenza e della grandezza di Dio. Prima il centro del mondo era rappresentato dalla terra: quando però gli astronomi dimostrarono che non esiste un centro assoluto nell’universo, i punti centrali divennero numerosi quanto gli esseri umani. Il Rinascimento portò inoltre a una nuova visione del rapporto con Dio. A mano a mano che la scienza e la filosofia si staccavano dalla teologia, la devozione cristiana crebbe. E la concezione individualistica rinascimentale dell’essere umano assume grande importanza anche nella fede religiosa. Il rapporto del singolo individuo con Dio divenne più importante di quello con la Chiesa come istituzione. Nella Chiesa cattolica medioevale la liturgia latina e la preghiera erano la spina dorsale delle funzioni religiose: però soltanto i sacerdoti e i monaci leggevano la Bibbia, perché era scritta in latino. A partire dal Rinascimento, la Bibbia fu tradotta dall’ebraico e dal greco nelle lingue volgari, e questo fu molto importante per la Riforma. Vi furono riformatori che preferirono rimanere nell’ambito della Chiesa cattolica romana. Uno di questi fu Erasmo da Rotterdam.
Martin Lutero invece, ruppe con la Chiesa cattolica. Secondo Lutero, l’uomo non ha bisogno della Chiesa o dei sacerdoti per ottenere il perdono di Dio, e ancor meno il perdono di Dio dipende dal pagamento delle indulgenze alla Chiesa. Il cosiddetto commercio delle indulgenze fu comunque vietato dalla Chiesa cattolica intorno alla metà del XVI secolo.
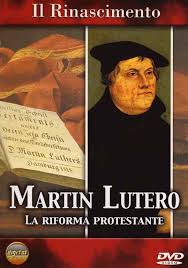
Martin Lutero
Lutero prese posizione contro molte verità di fede e usi religiosi che la Chiesa aveva fatto suoi durante il Medioevo. Voleva tornare al cristianesimo primitivo, quello che troviamo esposto nel Nuovo Testamento. “Soltanto le Scritture”, disse. Con questo motto Lutero voleva tornare alle fonti del cristianesimo, proprio come gli umanisti rinascimentali volevano ritornare alle fonti antiche dell’arte e della cultura. Tradusse la Bibbia in tedesco, ponendo al contempo le basi della lingua tedesca. Ognuno doveva essere in grado di leggere la Bibbia e di essere, in un certo senso, il sacerdote di se stesso. Lutero intendeva dire che i sacerdoti non occupano una posizione di privilegio nei confronti di Dio. Anche nelle comunità luterane furono designati, per motivi pratici, alcuni sacerdoti che officiavano le funzioni religiose e si occupavano delle incombenze religiose quotidiane, tuttavia, secondo Lutero, non era attraverso i rituali che l’uomo otteneva il perdono di Dio e l’assoluzione dai suoi peccati. L’uomo riceve la salvezza completamente gratis, soltanto attraverso la fede. Lutero arrivò a questa conclusione leggendo la Bibbia all’età di trentacinque anni. Il fatto che le lingue volgari subentrassero al latino fu tipico del Rinascimento. Ma Lutero non fu un umanista come Ficino o Pico della Mirandola. Fu criticato da umanisti come Erasmo da Rotterdam per la sua visione troppo negativa dell’uomo. Lutero sosteneva infatti che l’essere umano è totalmente corrotto dal peccato originale e può essere graziato soltanto dalla misericordia di Dio.
IL SEICENTO (PERIODO BAROCCO)
Il termine “barocco” significa “perla irregolare”. Tipiche dell’arte barocca furono le forme esuberanti e ricche di contrasti, a differenza di quelle più lineari, più armoniche del Rinascimento. Il XVI secolo fu caratterizzato dalla continua tensione di opposti inconciliabili: da un lato la gioia di vivere cara al Rinascimento, dall’altro il rifiuto più assoluto del mondo e una vita religiosa ritirata. Nell’arte e nella vita reale troviamo manifestazione di grande sforzo, mentre allo stesso tempo nascono movimenti monastici che si allontanano dal mondo. Una delle espressioni più ricorrenti nel periodo Barocco fu quella latina “carpe diem”, cioè afferra il presente. Un’altra, anche questa latina, fu “memento mori”, ricordati che devi morire. Nella pittura lo stesso quadro poteva raffigurare insieme immagini sfarzose e macabre. Un tratto caratteristico del Barocco è senza dubbio l’amore per lo sfarzo, le cose preziose, il lusso ma, nello stesso tempo, anche il senso della caducità, la quasi ossessiva consapevolezza che tutte le belle cose che ci circondano un giorno moriranno e si decomporranno. Anche dal punto di vista politico il Barocco fu un’epoca di grandi contrasti. Anzitutto l’Europa fu dilaniata da guerre continue: la peggiore fu la cosiddetta “guerra dei trent’anni” che infuriò su gran parte del continente dal 1618 al 1648 e che colpì soprattutto la Prussia. Come conseguenza di questa lunghissima guerra, la Francia divenne a poco a poco lo Stato più potente d’Europa. La causa principale della guerra fu la lotta tra protestanti e cattolici, ma fu anche una guerra per il potere politico.
Il Seicento fu caratterizzato da enormi differenze di condizione sociale, dallo sfarzo della nobiltà francese e della corte di Versailles alla grande povertà della gente. E ogni manifestazione di sfarzo corrisponde a una manifestazione di potere. La situazione politica del tempo può essere paragonata all’architettura e all’arte barocche: gli edifici barocchi erano contorti e complicati di volume, stucchi e decorazioni, mentre la vita politica era complicata da assassinii a tradimento, intrighi e congiure. Il massimo simbolo del tempo era il teatro, che rappresentava molto più di una forma artistica. Nel corso del Seicento fu ripetuto che “la vita è un teatro”. Il teatro moderno si sviluppò proprio in questo periodo, con tutte le sue macchine teatrali e le sue scenografie. In teatro si costruiva un’illusione, per poi svelare alla fine che tutto quanto era successo sulla scena non era altro che un’illusione. In questo modo il teatro divenne l’immagine della vita umana nella sua generalità.
Il teatro poté mostrare che “la Superbia partì a cavallo e tornò a piedi”, offrendo così una rappresentazione impietosa della miseria umana. Già in Shakespeare, che scrisse le sue opere teatrali più famose intorno all’anno 1600, quindi si trova a cavallo tra il Rinascimento e il Barocco, compaiono molte riflessioni sulla vita intesa come teatro. In “Come vi piace” afferma: “Tutto il mondo è un palcoscenico, e gli uomini e le donne sono soltanto attori che hanno le loro uscite e le loro entrate, e ognuno, nel tempo che gli è stato dato, recita molte parti…”

William Shakespeare
E nel Macbeth dice: “La vita non è che un’ombra in cammino, un povero attore, che s’agita e si pavoneggia per un’ora sul palcoscenico e del quale poi non si sa più nulla. È un racconto narrato da un’idiota, pieno di strepito e di furore, senza alcun significato”. In Shakespeare ricorre spesso il tema della brevità della vita: “Essere o non essere, questo è il problema!” E Amleto: “Un giorno vaghiamo sulla Terra, il giorno dopo non ci siamo più”.
Il drammaturgo Pedro Calderon della Barca, che nacque a Madrid nell’anno 1600, scrisse una commedia intitolata: “La vita è sogno” dove si dice: “Cos’è la vita? Follia. cos’è la vita? Un’illusione, un’ombra, una finzione, e anche il bene più grande ha poco valore, perché la vita è un sogno…”. Anche la filosofia fu caratterizzata da eccessi fra modi di pensare totalmente opposti. Per alcuni filosofi l’esistenza è fondamentalmente di natura spirituale, e questa concezione venne chiamata “idealismo”, mentre quella opposta è detta “materialismo”, un termine che indica una filosofia decisa a riportare tutti i fenomeni dell’esistenza a concrete grandezze fisiche. Anche il materialismo ebbe molti sostenitori nel Seicento.
Il più importante fu il filosofo inglese Thomas Hobbes. A suo parere, tutti i fenomeni, anche gli uomini e gli animali, sono formati esclusivamente di particelle di materia. Persino la coscienza umana, o anima, è dovuta ai movimenti di piccolissime particelle nel cervello. Idealismo e materialismo sono come due fili che percorrono tutta la storia della filosofia, ma raramente queste due concezioni hanno vissuto l’una accanto all’altra come nell’epoca barocca. Il materialismo ricevette nuove conferme dalle scoperte delle scienze naturali. Newton affermò che le leggi del moto valgono in tutto l’universo. Secondo lui tutti i mutamenti che avvengono in natura, sulla terra come nello spazio, sono dovuti alla legge di gravitazione e alle leggi sul moto dei corpi. Tutto insomma è regolato da queste leggi inviolabili, o dalla stessa meccanica. In linea di principio, è possibile calcolare ogni mutamento in natura con precisione matematica. In questo modo Newton diede un assetto definitivo a quella che definisce la concezione meccanicistica del mondo. La parola “meccanico” deriva dal greco “mechané”, cioè macchina. È importante sapere che né Hobbes né Newton vedevano alcuna contraddizione fra la concezione meccanicistica del mondo e la fede in Dio. Questa opinione non fu invece più diffusa tra i materialisti del Settecento e dell’Ottocento.
Nel 1748, il medico e filosofo francese La Mettrie scrisse un libro intitolato “L’Homme machine”, sostenendo che come le gambe sono dotate di muscoli per camminare, così il cervello possiede “muscoli” per pensare. Qualche tempo dopo, il matematico francese Laplace espresse così una concezione meccanicistica: “se un’intelligenza conoscesse la posizione di tutte le particelle di materia in un dato momento, niente sarebbe insicuro, e il futuro come il passato sarebbero li davanti ai suoi occhi”. In altre parole, tutto quello che succede è stabilito in anticipo e tutto ciò che avverrà è già implicito. Questo modo di pensare viene chiamato “determinismo”. Ma se tutto è il risultato di processi meccanici, compresi i nostri pensieri e i nostri sogni, significa che gli uomini non hanno nessuna libertà, si nega cioè il libero arbitrio. Nell’Ottocento, un materialista tedesco disse che i processi mentali stanno al cervello come la bile al fegato e l’urina ai reni. Ma sia l’urina che la bile sono qualcosa di concreto, mentre i pensieri non lo sono.
C’è una storia che esprime questo punto di vista. C’erano un astronauta russo e uno specialista russo del cervello che cominciarono a discutere di religione. Lo specialista era cristiano, l’astronauta no. “Sono stato molte volte nello spazio”, si vantava l’astronauta, “ma non ho mai visto né Dio né gli angeli”. “E io ho operato molti cervelli intelligenti, ma non ho mai visto un pensiero”, rispose lo specialista.
I due filosofi più importanti del XVII secolo furon Cartesio e Spinoza. Anche loro si occuparono del rapporto tra “anima” e “corpo”. René Descartes (latinizzato in Cartesio) nacque a Le Haye, in Francia nel 1596 e viaggiò molto per l’Europa. Già da giovane coltivava il desiderio di raggiungere una conoscenza sicura della natura dell’uomo e dell’universo, ma dopo essersi dedicato agli studi di filosofia, divenne sempre più consapevole della propria ignoranza. Come Socrate, era convinto che possiamo raggiungere un sapere sicuro soltanto per mezzo della ragione. Non possiamo basarci su quello che ci dicono i vecchi libri e tantomeno fare affidamento sui nostri sensi.

Rene Descartes – Cartesio
Un filo conduttore unisce Socrate – Platone e Cartesio, passando per Agostino: erano tutti convinti razionalisti, per cui la ragione rappresenta per loro l’unica fonte sicura di conoscenza. Cartesio decise di girare l’Europa alla ricerca di quella scienza che poteva trovare o in se stesso o nei grandi libri del mondo. Scelse la vita militare e così soggiornò in diversi luoghi dell’Europa centrale. In seguito visse alcuni anni a Parigi e, nel 1629, si trasferì in Olanda, dove rimase per quasi vent’anni. Nel 1649 si recò in Svezia, su invito della regina Cristina. La permanenza in questo paese dal clima freddo gli causò una broncopolmonite che gli fu fatale: morì nell’inverno del 1650 a cinquantaquattro anni. Dopo la sua morte, la figura di Cartesio acquistò un’importanza enorme per tutta la filosofia. Non è esagerato dire che fu lui a porre le fondamenta della filosofia di questo periodo; infatti, dopo l’inebriante riscoperta rinascimentale dell’uomo e della natura, si avvertì l’esigenza di raccogliere le conoscenze in un sistema filosofico coerente. Il primo grande costruttore moderno di sistemi fu Cartesio, cui seguiranno Spinoza, Leibniz, Locke, Berkeley, Hume e Kant.
Con sistema filosofico si intende una filosofia che viene costruita sin dalle fondamenta e che cerca di trovare risposte a tutte le domande filosofiche più importanti. Nell’antichità, i grandi costruttori di sistemi furono Platone e Aristotele; nel Medioevo, Tommaso d’Aquino gettò un ponte tra la filosofia di Aristotele e la teologia cristiana. Il Rinascimento fu invece contraddistinto da una confusione di pensieri vecchi e nuovi sulla natura e sulla scienza, su Dio e sull’uomo. Soltanto nel Seicento la filosofia cercò di elaborare il nuovo modo di pensare in chiaro sistema filosofico. Il primo a farlo fu Cartesio, che diede l’avvio a uno dei progetti filosofici più importanti per le generazioni successive. Gli premeva innanzi tutto stabilire ciò che siamo in grado di sapere, quindi fondamentale era la domanda sulla certezza della nostra conoscenza. L’altra grande domanda riguardava il rapporto tra l’anima e il corpo. Entrambi i problemi caratterizzeranno la discussione filosofica nei centocinquanta anni successivi. Proprio nell’epoca di Cartesio la scienza aveva sviluppato un metodo che permetteva una descrizione precisa e inconfutabile dei processi naturali. Cartesio si chiese se non esistesse un “metodo” simile anche per la speculazione filosofica. La nuova fisica, inoltre, aveva posto il problema della natura della materia, cioè di ciò che determina i processi fisici in natura. Un numero sempre maggiore di studiosi adottava un’interpretazione meccanicistica della natura, tuttavia più il mondo fisico veniva considerato meccanicisticamente, più la questione del rapporto tra anima e corpo diventava pressante. Il significato originario delle parole “anima” e “spirito” – in quasi tutte le lingue europee – è anche “soffio di vita” o “respiro”. Per Aristotele, l’anima era presente in tutti gli organismi come “principio vitale” dell’organismo stesso, quindi indissolubile del corpo; per questo parlava di “anima vegetale” e “anima sensitiva”.
Soltanto nel XVI secolo i filosofi introdussero una radicale divisione tra anima e corpo. Il motivo fu che ogni cosa – anche il corpo di un’animale o di un uomo venga concepita come un processo meccanico, di conseguenza, l’anima non poteva far parte di questa “macchina fisiologica”. Che cos’era allora l’anima? E come poteva qualcosa di spirituale mettere in moto un processo meccanico? Per esempio: se l’uomo decide di sollevare un braccio, il braccio si solleva, se pensa a qualcosa di triste improvvisamente comincia a piangere. Deve esserci allora qualche collegamento misterioso tra il corpo e la coscienza. Fu proprio questo che si chiese Cartesio. Come Platone era convinto che esistesse una rigida divisione tra spirito e materia, tuttavia Platone non aveva fornito alcuna risposta alla domanda su come il corpo influenzi l’anima e viceversa. Nel “Discorso sul metodo” si domandò a quale metodo filosofico si debba adeguare quando deve risolvere un problema filosofico. La scienza infatti aveva già elaborato un proprio metodo. In primo luogo Cartesio afferma che non bisogna mai accettare nulla per vero se non lo si riconosce evidentemente tale. Per arrivare a questo, è spesso indispensabile suddividere un problema complesso in parti, cioè ogni singolo pensiero deve essere “pesato e misurato”, esattamente come Galileo esigeva che tutto venisse misurato e tutto ciò che non si poteva misurare fosse reso misurabile. Secondo Cartesio, inoltre, il filosofo doveva procedere dagli oggetti più semplici a quelli composti. Infine bisognava fare continue enumerazioni e revisioni generali per assicurarsi di non aver trascurato nulla. Soltanto a questo punto una conclusione filosofica era a portata di mano. Cartesio voleva servirsi del metodo matematico anche per le questioni filosofiche, dimostrare le verità filosofiche esattamente come si dimostra un teorema matematico, ricorrendo allo stesso strumento, cioè la ragione, perché soltanto la ragione è in grado di darci un sapere certo, mentre i sensi non sono affidabili; (i sensi sono ingannevoli – razionalismo di Parmenide). L’obiettivo di Cartesio era raggiungere un sapere sicuro sulla natura dell’esistenza e per questo affermò che, come presupposto fondamentale, bisogna dubitare di tutto. L’unica cosa di cui puoi essere sicuro è di dover dubitare di tutto, tuttavia, se dubiti, allora è certo che stai pensando, e, se pensi, è dunque certo che sei un essere pensante.
Come si espresse egli stesso: “Cogito, ergo sum!”. Come per Platone, ciò che cogliamo con la ragione è più reale di ciò che percepiamo con i sensi. Oltre al fatto di essere un io pensante, Cartesio si chiede se esiste un qualcos’altro che egli conosce con la stessa sicurezza intuitiva. Giunge alla conclusione di possedere anche l’idea chiara e distinta di un essere perfetto. Sostiene, infatti, che l’idea di un essere perfetto non può provenire da qualcosa di imperfetto, per cui l’idea di un essere perfetto deve derivare da questo essere perfetto: in altre parole da Dio. Che esiste Dio è per Cartesio altrettanto evidente come il fatto che, se uno pensa, deve essere un io pensante. Per quanto riguarda tutte le idee del mondo esterno, per esempio il sole e la luna, si potrebbe pensare che siano soltanto visioni oniriche, ma anche il mondo esterno possiede proprietà che noi possiamo riconoscere con la ragione. Sono relazioni matematiche, che possiamo quindi misurare: la lunghezza, la larghezza e la profondità. Queste proprietà “quantitative” sono chiare ed evidenti alla ragione. Le proprietà “qualitative” come il colore, l’odore e il gusto sono legate ai nostri sensi, e non descrivono veramente il mondo esterno.
Ma la realtà esterna è molto diversa dalla realtà del pensiero. Cartesio dice che ci sono due diverse forme di realtà. Una è detta “res cogitans”, cioè una sostanza la cui essenza è il pensare o l’anima; l’altra è detta “res extensa”, la sostanza estesa o la materia. L’anima è solo cosciente, non occupa alcuno spazio fisico e pertanto non può essere divisa in parti più piccole. La materia al contrario è estesa, occupa spazio e può essere divisa in parti più piccole ma non è cosciente. Il pensiero è completamente libero rispetto alla materia e viceversa. Secondo Cartesio il corpo umano è un meccanismo molto sofisticato. I processi fisiologici non godono di nessuna libertà, ma devono seguire le proprie leggi. Ciò che pensiamo con la ragione non avviene nel corpo, bensì nell’anima, che è completamente libera rispetto alla realtà estesa. Lo stesso Cartesio non poteva negare che ci sia una continua azione reciproca tra anima e corpo. Finché l’anima è nel corpo, sosteneva, è legata a esso per mezzo di una ghiandola, la “ghiandola pineale”, posta al centro del cervello. Mediante tale ghiandola si ha un continuo processo di azione e reazione tra “spirito” e “materia”. In questo modo l’anima viene continuamente turbata da sentimenti e affezioni che sono dovuti ai movimenti corporei. Tuttavia l’anima può anche staccarsi da questi impulsi, operando liberamente rispetto al corpo in modo che la ragione assuma la guida. Anche se uno ha il mal di stomaco, la somma degli angoli di un triangolo è sempre di 180°. In questo modo il pensiero ha la capacità di elevarsi dai bisogni fisici e può agire ragionevolmente. L’anima dunque è superiore al corpo. Le membra possono invecchiarsi e indebolirsi, ma due più due farà sempre quattro finché ci sarà in noi la ragione che, a differenza del corpo, non invecchia. Per Cartesio la ragione è l’anima. Le affezioni e gli stati d’animo più bassi come il desiderio e l’odio sono legati alla fisiologia del corpo, quindi alla realtà estesa. Il pensiero di Cartesio fu determinante soprattutto per un altro filosofo: Baruch Spinoza, olandese, che visse tra il 1632 e il 1677.
Spinoza apparteneva alla comunità ebraica di Amsterdam ma, nel 1656, venne espulso e scomunicato con l’accusa di eresia. Nell’epoca moderna, pochi filosofi furono derisi e perseguitati a causa delle loro idee come quest’uomo; cercarono perfino di ucciderlo. Il motivo di questo accanimento era dovuto alle critiche che Spinoza aveva mosso alla religione ufficiale: secondo lui, tanto il cristianesimo quanto l’ebraismo erano tenuti in vita soltanto dalla rigidezza dei dogmi e dai rituali esteriori. Inoltre Spinoza fu il primo ad affrontare la Bibbia da un punto di vista che oggi si può definire “storico – critico”. Spinoza rifiutò l’idea che la Bibbia fosse stata completamente ispirata da Dio. Quando leggiamo la Bibbia, dobbiamo tenere presente in quale periodo storico venne scritta: una lettura “critica” permette di scoprire numerose discordanze esistenti tra i diversi libri. La predicazione di Gesù rappresentò la liberazione dal dogmatismo e dalla rigidezza dell’ebraismo. Gesù predicò una “religione della ragione” che considerava l’amore il valore più alto, un amore che, secondo Spinoza, è rivolto sia verso Dio sia verso il prossimo.
Tuttavia anche il cristianesimo finì con l’irrigidirsi in dogmi e in rituali esteriori. Quando la situazione si aggravò, Spinoza venne abbandonato anche dalla famiglia che cercò di privarlo dell’eredità a causa della sua eterodossia. Il paradosso sta nel fatto che sono pochi quelli che hanno difeso la libertà di parola e la tolleranza religiosa con maggior fervore di Spinoza. L’opposizione che incontrò quasi ovunque fu determinante nella sua scelta di dedicare tutta la sua vita alla filosofia. Per mantenersi molava lenti ottiche. È quasi simbolico che vivesse proprio di questo lavoro: i filosofi hanno il compito di aiutare gli uomini a vedere l’esistenza sotto una nuova prospettiva, e uno dei capisaldi della filosofia di Spinoza è proprio interpretare le cose “dal punto di vista dell’eternità”. Il suo libro più importante: “Ethica more geometrico demonstrata” cioè “l’Etica dimostrata secondo l’ordine geometrico”. Con “Etica” i filosofi intendono quella parte della filosofia che studia la condotta umana. Per Socrate e Aristotele era compito dell’etica indicare il modo in cui gli uomini potessero condurre un’esistenza felice.
Oggi l’etica si è quasi ridotta a una serie di regole che ci insegnano a vivere senza pestare i piedi agli altri. Quando Spinoza si serve della parola “etica” intende “arte di vivere” o “morale”. Nella sua Etica vuole dimostrare come la vita dell’uomo sia decisa dalle leggi della natura. Spinoza non ha una concezione “dualistica” della realtà come Cartesio, bensì “monista”: egli riconduce l’intera natura e tutte le relazioni della vita alla medesima sostanza. Anche Cartesio aveva detto che soltanto Dio esiste in virtù di se stesso. Soltanto allorché Spinoza equipara Dio e la natura, o Dio e il creato, si allontana decisamente da Cartesio e dal pensiero ebraico e cristiano. Ma quando Spinoza usa la parola “natura”, non si riferisce soltanto alla natura estesa: con Sostanza, Dio o Natura intende tutto ciò che è fatto di spirito, quindi sia il pensiero sia l’estensione. Secondo Spinoza noi esseri umani conosciamo due delle proprietà “attributi” di Dio, che sono il pensiero e l’estensione di Cartesio. In pratica dice Spinoza: tutto ciò che è natura è o pensiero o estensione. I singoli fenomeni della vita di tutti i giorni, per esempio un fiore o una poesia, rappresentano diversi modi degli attributi pensiero ed estensione. La Sostanza, o Dio o la Natura, si manifesta in modi diversi: un fiore è un modo dell’attributo estensione, mentre una poesia su questo fiore costituisce un modo dell’attributo pensiero. Entrambi però sono in ultimo espressione della Sostanza. Esempio: quando mi fa male la pancia, chi sta male? Io, e quando rifletto sul fatto che mi è venuto il mal di pancia, chi pensa? Sempre io. Questo perché io sono uno e una sola persona che può avere mal di pancia e subito dopo provare uno stato d’animo. Analogamente, per Spinoza, tutte le cose fisiche che esistono o avvengono intorno a noi sono espressione di Dio o della natura. Lo stesso vale per i pensieri che vengono formulati. Esiste un unico Dio, o un’unica natura, o un’unica Sostanza. Quando una persona pensa, è lei che pensa. E quando si muove, è lei che si muove, ma è anche espressione di qualcosa di infinitamente più grande. Ma se ha la libertà di muoversi, si può muovere soltanto secondo la sua natura. Non può mettersi a saltare con una mano o a rimbalzare.
Secondo Spinoza, Dio (o le leggi naturali) è la “causa immanente” (cioè interna) di tutto quello che succede. Non è una causa esterna, perché Dio si manifesta soltanto attraverso le leggi naturali e quindi Dio (o la natura) è la “causa immanente” di tutto quanto avviene. Ciò significa che tutto in natura avviene secondo necessità. Spinoza aveva una concezione deterministica della vita della natura. Ognuno vive secondo le leggi della natura, ma dietro ogni cosa che facciamo, si celano moltissime cause, e tutte assai complesse. Esempio: due alberi sono piantati in un grande giardino. Uno in un punto dove il terreno è fertile, ricco d’acqua e ben esposto al sole, l’altro invece su un terreno arido e in ombra. Ovviamente il primo ha le migliori condizioni di crescita. Secondo Spinoza, questo albero è libero di sviluppare le sue possibilità. Ma un melo non può produrre prugne. Questo vale anche per gli uomini: il nostro sviluppo e la nostra crescita personale possono essere ostacolati per esempio dalla situazione politica. In questo modo una costrizione esterna ci frena. Soltanto quando possiamo sviluppare “liberamente” le nostre possibilità viviamo come uomini liberi, pur rimanendo vincolati da inclinazioni interne e da condizioni esterne. Spinoza sostiene che esiste un unico essere che è “causa di sé” pienamente e totalmente e può quindi agire in piena libertà: soltanto Dio (o la natura) rappresenta una manifestazione libera e “non casuale” di questo genere. Un uomo può lottare per ottenere una libertà che gli permetta di vivere senza coercizioni esterne, ma non potrà mai raggiungere il “libero arbitrio”.
Secondo Spinoza, sono le passioni umane, come l’ambizione o il desiderio, che ci impediscono di raggiungere la vera felicità e l’armonia. Tuttavia, se sappiamo che tutto avviene secondo necessità, possiamo raggiungere una conoscenza intuitiva della natura come totalità e sentire in modo chiaro e inequivocabile che tutto è connesso e collegato, che tutto è uno. La meta finale è cogliere tutto ciò che è un’unica veduta d’insieme. Soltanto in quel momento raggiungiamo la massima felicità e serenità di spirito. Fu questo che Spinoza chiamò “sub specie aeternitatis”, cioè vedere tutto dal punto di vista dell’eternità. L’atteggiamento razionalistico fu tipico della filosofia del Seicento. Nel Settecento, questa concezione venne sottoposta a critiche sempre più serrate. Molti filosofi affermarono che la nostra coscienza è completamente priva di contenuto se prima non abbiamo avuto esperienze sensoriali. Questo modo di vedere venne chiamato “Empirismo”. Gli empiristi, o filosofi dell’esperienza, più importanti furono: John Locke, David Hume e George Berkeley, tutti e tre inglesi. I razionalisti più importanti del Seicento furono il francese Cartesio, l’olandese Spinoza e il tedesco Gottfried Leibniz. Per questo motivo si parla di un “empirismo inglese” e di un “razionalismo continentale”. Un empirista vuole derivare tutta la conoscenza del mondo da ciò che i sensi raccontano. La formulazione più antica di un modo di pensare empirista risale ad Aristotele, il quale disse che “non c’è niente nell’intelletto che non sia stato prima nei sensi”. Questa affermazione conteneva una puntuale critica a Platone, secondo il quale, invece l’uomo aveva in sé, innate, le idee. Locke ripete le stesse parole di Aristotele, usandole però contro Cartesio. Non abbiamo idee innate, non sappiamo assolutamente nulla del mondo in cui viviamo prima di averlo percepito con i sensi. Se possediamo un’idea che non può essere ricollegata a fatti di cui si è avuto esperienza, questa idea è falsa. Quando, per esempio, usiamo parole come “Dio”, “eternità”, la ragione funziona a vuoto, perché nessuno ha mai avuto esperienza di Dio o dell’eternità. Sono soltanto costruzioni della mente. Per gli empiristi inglesi era importante esaminare ogni idea umana per scoprire se si fondasse su esperienze autentiche.
John Locke, che visse tra il 1632 – 1704 scrisse “Saggio sull’intelletto umano”, pubblicato nel 1690. In quest’opera Locke cerca di chiarire due problemi: anzitutto si chiede dove gli uomini traggono i loro pensieri e le loro idee, poi si domanda se possiamo fidarci di ciò che ci raccontano i sensi. Locke era convinto che tutte le nostre idee non fossero altro che un riflesso di ciò che abbiamo visto e sentito. Prima di percepire qualcosa con i sensi, la nostra coscienza è una specie di tabula rasa. Poi cominciamo a percepire il mondo che ci circonda, vediamo forme e colori, sentiamo odori e sapori, udiamo e tocchiamo. In tal modo nascono quelle che Locke chiamò “idee semplici”. Ma l’intelletto non si limita a raccogliere passivamente queste impressioni esterne, qualcosa avviene anche in esso: ogni idea semplice viene rielaborata attraverso il pensiero, la riflessione, la fede e il dubbio, in questo modo nascono le riflessioni. Locke separa quindi la sensazione dalla riflessione, perché la mente non riceve le impressioni sensoriali in modo passivo, bensì le ordina e le rielabora a mano a mano che arrivano, osserva che ciò che cogliamo attraverso i sensi sono “idee semplici”. Esempio: quando uno mangia una mela, non la percepisce tutta in un’unica impressione. In realtà riceve una serie di idee semplici: è qualcosa di rosso – ha un buon sapore – ha un sapore ricco. Solo dopo averne mangiate diverse, pensa che sta mangiando una mela. Solo a quel punto, abbiamo creato l’idea complessa di una mela. Locke si pone il secondo problema e si chiede se il mondo è davvero come lo percepiamo, allora divise le qualità sensoriali in “primarie” e “secondarie”. Con “qualità primarie” si intendono l’estensione, il peso, la forma, il movimento e il numero. Siamo certi che i sensi riproducono tali qualità reali degli oggetti, ma noi ne percepiamo anche altre: diciamo che qualcosa è dolce o amaro, verde o rosso, caldo o freddo. Queste qualità furono chiamate da Locke “qualità secondarie”.
Le impressioni sensoriali quali il colore, l’odore, il sapore e il suono non riproducono infatti le qualità reali dell’oggetto, ma registrano soltanto l’influenza che la realtà esterna esercita sui nostri sensi. Le qualità primarie, come forma e peso, sono qualcosa su cui tutti concordano, invece le qualità secondarie, come colore e sapore, variano da uomo a uomo e da animale a animale e dipendono dall’apparato sensoriale del singolo essere. Per quanto riguarda la “realtà estesa”, Locke concorda con Cartesio nell’affermare che esistono qualità che l’uomo è in grado di comprendere attraverso la ragione. Anche in altri ambiti Locke ammise una conoscenza che chiamò intuitiva o dimostrativa. Per esempio, riguardo ad alcune norme etiche. Come pure accolse il concetto razionalista che Locke condivise fu quella secondo cui la ragione umana può arrivare all’idea di Dio. Ma Locke non ne fa soltanto una questione di fede. Secondo lui la conoscenza dell’esistenza di Dio può essere raggiunta dalla ragione umana e quello è un concetto razionalista. C’è da aggiungere che Locke trattò i temi della libertà di pensiero e della tolleranza e sostenne la parità dei sessi. La sottomissione della donna all’uomo è un’invenzione umana. Locke fu uno dei primi filosofi dell’età moderna a occuparsi del ruolo dei sessi, fu anche uno dei primi a sostenere idee liberali che vennero riprese nel Settecento dagli illuministi francesi: per esempio fu il primo a parlare del “principio della divisione dei poteri”. Locke aveva insistito sulla separazione fra il potere esecutivo e quello legislativo, in modo da evitare la tirannia. Fu contemporaneo di Luigi XIV che aveva concentrato tutto il potere nelle sue mani. “Lo Stato sono io”, diceva. Era un monarca assoluto e del “suo” Stato oggi diremmo che rappresentava una condizione di assenza di diritti. Secondo Locke, per assicurare uno Stato di diritto, erano i rappresentanti del popolo che dovevano legiferare, e al governo, o al re, toccava soltanto il compito di dare attuazione alle leggi.
Il filosofo illuminista Montesquieu introdusse invece la ripartizione: “Potere Legislativo Parlamento; Potere Giudiziario – Tribunali; Potere Esecutivo – Governo”.
David Hume, (1711-1776) è considerato il filosofo più importante tra gli empiristi, particolare perché la sua filosofia fece da sprone al grande filosofo Immanuel Kant. Hume nacque a Edimburgo, in Scozia, e la sua famiglia voleva che studiasse legge. La sua opera, più importante, il “Trattato sulla Natura Umana”, fu pubblicata quando aveva ventotto anni, ma lo stesso Hume affermò di aver avuto l’idea di questo libro già all’età di quindici anni. Da empirista, considerava suo compito il mettere ordine nelle nebulose costruzioni intellettuali elaborate dai filosofi. L’espressione scritta e quella orale si rifacevano ancora a concetti che risalivano alla filosofia medioevale e al razionalismo del Seicento. Hume voleva richiamarsi alla percezione originaria del mondo da parte della natura umana. Nessuna filosofia, affermava, sarà mai in grado di condurci al di la delle esperienze di tutti i giorni. Hume vuole ritornare al modo di vivere e di sentire dei bambini, quando cioè i pensieri e le riflessioni non hanno ancora invaso la coscienza. Afferma che gli uomini hanno due tipi di rappresentazioni: le “impressioni” e le “idee”. Con “impressioni” intende ogni percezione immediata della realtà esteriore; con “idea”, il ricordo di questa impressione. L’impressione è molto più forte e viva del ricordo connesso alla riflessione nell’impressione. È l’impressione a essere la causa diretta dell’idea che si nasconde nella coscienza. Hume sostiene poi che tanto un’impressione quanto un’idea possono essere “semplici” o “complesse”.
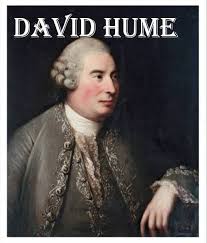
Secondo Hume, a volte noi “componiamo” le idee senza che esse siano unite nella realtà: si creano così false idee o rappresentazioni che non esistono nella realtà. Gli angeli, Pegaso (il cavallo alato) sono due esempi. In questi casi dobbiamo riconoscere che la coscienza ha ritagliato e incollato di propria iniziativa. Nel caso di Pegaso ha preso le ali da un’impressione e i cavalli da un’altra e li ha uniti insieme. Tutti questi elementi sono stati percepiti e sono approdati nella coscienza come impressioni autentiche. Niente è stato inventato dalla coscienza, che ha semplicemente ritagliato e incollato creando così false idee o rappresentazioni. Hume vuole vagliare ogni idea per scoprire se sia composta in modo tale da trovare riscontro nella realtà oppure no. Allora si chiede: da quali impressioni ha origine quest’idea? Prima di tutto deve scoprire da quali idee semplici è formata un’idea complessa. Così facendo mise a punto un metodo critico per analizzare le idee umane, e fare pulizia nei pensieri e nei concetti. Hume sostiene che tutti i materiali di cui sono composti i nostri sogni devono essere pervenuti alla coscienza sotto forma di impressioni semplici. Una persona che non ha mai visto l’oro non è in grado di immaginare un oggetto d’oro. Egli vuole mettere in discussione tutte le idee e le rappresentazioni non riconducibili a corrispondenti impressioni sensoriali, vuole cioè eliminare tutto quel parlare privo di senso che ha dominato così a lungo il pensiero metafisico e lo ha fatto cadere in discredito. Anche oggi ci serviamo di idee complesse senza chiederci se abbiano validità.
È il caso dell’idea dell’io, il nucleo della personalità di un individuo. Quest’idea costituiva la base della filosofia di Cartesio. Anzitutto c’è da chiedersi se l’idea dell’io sia semplice o complessa. L’idea “io” è una lunga catena di impressioni semplici che non viviamo mai contemporaneamente. Non è “nient’altro che un fascio o una raccolta di diverse percezioni che si susseguono velocemente e che sono in continuo flusso e movimento”, dice Hume. La mente è “una specie di teatro dove le varie percezioni si mostrano, passano, ritornano, escono e si mescolano in una varietà di atteggiamenti e situazioni”. Sono come le immagini di un film che scorre sullo schermo: non vediamo le singole immagini, in realtà è una somma di istanti. L’analisi di Hume sulla coscienza umana nonché il suo rifiuto per l’esistenza di un nucleo immutabile della personalità erano già stati formulati prima, quasi duemilacinquecento anni, da Buddha. Buddha considerava la vita umana come una serie continua di processi mentali e fisici che mutano l’uomo ogni istante: il neonato non è uguale all’adulto e io non sono lo stesso di ieri. Buddha sosteneva che di nulla si poteva dire: “questo è mio” oppure: “questo sono io”. Non esiste nessun io, ne un nucleo immutabile della personalità. Come conseguenza di un io immutabile, molti razionalisti avevano dato per scontato che l’essere umano avesse un’anima immortale, ma questa idea è falsa sia per Hume che per Buddha, quest’ultimo ai suoi discepoli disse prima di morire: “effimero è tutto ciò che è composto”. Comunque sappiamo che Hume negò la possibilità di dimostrare l’immortalità dell’anima e l’esistenza di Dio. Questo non significa che escludesse le due cose, ma riteneva che la pretesa di dimostrare la fede religiosa con la ragione umana fosse un non senso razionalista.
Hume era un agnostico. Non negò la fede cristiana né quella dei miracoli, ma in entrambi i casi si trattava per l’appunto di fede e non di sapere o di ragione. Poi Hume parla del potere dell’abitudine, si richiama alla “legge di casualità”. Questa legge afferma che tutto ciò che avviene deve avere una causa, esempio delle due biglie: se una ne colpisce un’altra è la causa del suo movimento. Ma secondo Hume abbiamo sperimentato che un avvenimento segue l’altro nel tempo e non che il secondo avviene a causa del primo, per lui l’aspettativa che un evento succeda all’altro non si trova nelle cose stesse, bensì nella nostra coscienza, che ha a che fare con l’abitudine. Quando parliamo di “legge naturale” o di “relazione di causa – effetto”, stiamo parlando in realtà dell’abitudine umana e non di qualcosa di razionale. Le leggi della natura non sono né razionali né irrazionali: ci sono e basta. Hume non nega che esistano inviolabili leggi di natura ma, poiché non siamo in grado di sperimentarle possiamo trarne conclusioni errate.
Se ho visto solo cavalli neri, ciò non significa che tutti i cavalli sono neri. Tanto per uno scienziato quanto per un filosofo è importante non escludere la possibilità che ne esiste uno bianco. Mettere in guardia gli uomini dall’essere precipitosi nelle loro conclusioni è uno dei compiti più importanti della filosofia. In effetti sono proprio tali conclusioni avventate a essere la causa di molte superstizioni. Vedere un gatto nero attraversare la strada e poco dopo cadere non significa che esista una relazione di causa – effetto tra i due avvenimenti. Quando si desidera valutare l’efficacia di un farmaco, lo si somministra a due gruppi di persone: solo un gruppo assume veramente il farmaco, mentre all’altro si somministra (ovviamente senza che lo sappiano) placebo. Se oltre al primo gruppo, anche il secondo trae benefici dal farmaco, ciò significa che non è stata la medicina a operare la guarigione, bensì un altro fattore di carattere psicologico. Anche per quanto riguarda l’etica e la morale, Hume criticò il modo di pensare razionalista, secondo il quale la ragione umana è in grado di distinguere tra il bene e il male. Questa concezione del diritto naturale la si incontra in vari filosofi da Socrate a Locke ma, secondo Hume, non è la ragione a stabilire le nostre parole e le nostre azioni, ma i sentimenti. Se decidi di aiutare qualcuno, lo fai spinto dai tuoi sentimenti, non dalla ragione. Agire in modo responsabile non significa potenziare e affinare la ragione, ma potenziare e affinare i nostri sentimenti per il bene degli altri.
George Berkeley fu un vescovo irlandese vissuto tra il 1685 e il 1753. Era un filosofo che pensava che la filosofia del tempo e la scienza rappresentassero una minaccia per la concezione cristiana della vita. Inoltre era convinto che un materialismo sempre più conseguente costituisse un pericolo per la fede cristiana, secondo la quale Dio aveva creato e conservava tutto ciò che esiste in natura, allo stesso tempo Berkeley fu uno degli empiristi più coerenti. Sosteneva che non possiamo conoscere niente altro del mondo oltre a quello che percepiamo con i sensi, e si spinse anche oltre. Secondo Berkeley, le cose del mondo sono proprio come noi le percepiamo, ma non sono “cose”. Disse che l’unica cosa che esiste è ciò che percepiamo con i sensi, ma noi non percepiamo la “materia” o la “sostanza materiale”. Presupporre il fatto che noi percepiamo qualcosa che abbia una “sostanza” preesistente significa saltare a una conclusione affrettata: non abbiamo prove suffragate dall’esperienza per giungere a un’affermazione di questo tipo. Secondo Berkeley l’anima può essere causa delle idee, ma soltanto un’altra volontà o spirito può essere causa delle idee che costituiscono il nostro mondo materiale. Tutto è dovuto a questo spirito che, diceva Berkeley: “opera ogni cosa e per opera del quale tutte le cose esistono”. Naturalmente lui pensa a Dio.

George Berkeley
Berkeley non mette in dubbio soltanto la realtà materiale, si chiede anche se “lo spazio e il tempo abbiano un’esistenza autonoma e assoluta. Perfino la nostra esperienza del tempo e dello spazio può essere qualcosa che si trova soltanto nella nostra coscienza…”. Berkeley nega l’esistenza di un mondo materiale al di fuori della conoscenza umana, sostenendo che le nostre percezioni sensoriali sono generate da Dio. È famoso inoltre per la sua critica alle idee astratte. La sua opera principale: “Trattato sui principi della conoscenza umana” del 1710. Aristotele sostenne che non è possibile alcuna conoscenza se prima di tutto non è passato attraverso i sensi; Platone invece sosteneva che non esiste niente in natura che non sia prima esistito nel mondo delle idee.
L’ILLUMINISMO
Movimento culturale che, collocandosi fra le grandi rivoluzioni “borghesi”, quella inglese del 1688 e quella francese del 1789, esprime una nuova concezione del mondo, accolta e fatta propria dalla borghesia progressista. Il motivo dominante dell’Illuminismo è la celebrazione della ragione umana, che si affranca dal suo stato di soggezione, combattendo contro i pregiudizi di ogni natura che ostacolano il cammino della civiltà e si oppongono al progresso e alla felicità degli uomini. L’Illuminismo non si presenta come una scuola ben definita, non ambisce a essere un sistema, proprio perché ripudia lo “spirito di sistema”, tipico delle grandi costruzioni dottrinarie della vecchia metafisica; esso però non rinuncia allo “spirito sistematico” di un sapere fondato sull’esperienza e dotato di rigore tipico del metodo scientifico ed empiristico, appreso alla scuola del pensiero di Locke e della scienza di Newton. Anche il filone razionalistico che fa capo a Cartesio ha influito sulla genesi dell’Illuminismo, specie per quanto attiene alla critica dell’autorità e della tradizione; ma la ragione che gli illuministi esaltano non è quella sistematico – deduttiva di Cartesio, di Spinoza o di Leibniz: essa è la ragione saldamente ancorata all’esperienza, che costituisce l’esclusivo campo d’indagine, con la conseguente ripulsa di ogni metafisica e l’esclusione di ogni intervento divino nella formazione del sapere umano. L’empirismo viene anzi radicalizzato nella teoria del sensismo, lucidamente sostenuta da Condillac, secondo cui non vi sono idee innate, ma tutte le nostre idee derivano dalle sensazioni. La fiducia nella ragione, intesa come una forza autonoma e critica, capace di vagliare idee e istituzioni, rifiutando la soggezione all’autorità dei poteri del trono e dell’altare, è il motivo comune del movimento illuminista. Altri elementi comuni sono l’idea di progresso e il cosmopolitismo intellettuale.
Gli illuministi credono nella possibilità di migliorare radicalmente la condizione dell’uomo mediante il progresso scientifico: espressione monumentale di questa loro fede e, insieme, della loro capacità divulgativa è il Dizionario ragionato delle Scienze, delle Arti e dei Mestieri di Diderot e D’Alembert (Enciclopedia), una grandiosa opera collettiva cui si deve uno dei più vasti e radicali rivolgimenti della cultura europea. Gli illuministi, inoltre, credono nella necessità di superare ogni preclusione nazionalistica e si sentono cittadini del mondo: in tale prospettiva cosmopolita il francese diventa la lingua culturale dell’Europa settecentesca. Malgrado l’evidenza e la chiarezza dei suoi principi fondamentali, il movimento illuminista presenta al suo interno contrasti e contraddizioni profonde, a cominciare dal settore delle dottrine politiche. Montesquieu, nello Spirito delle leggi (1748), esamina i diversi tipi di governo e teorizza il principio della separazione dei poteri, nel quadro di una visione laica dello Stato che fa di lui uno dei padri del liberalismo. L’ordinamento costituzionale da lui previsto non implica però l’abolizione dei privilegi aristocratici.

Diderot e D’alembert
Gli si contrappone Rousseau ispiratore, col suo “Contratto sociale” (1762), del giacobinismo e delle forme più avanzate di democrazia borghese: teorico della sovranità popolare e della democrazia diretta, egli sostiene la necessità di uno Stato che si identifichi con il popolo e in cui il concetto di uomo e quello di cittadino coincidano. Ma la dottrina politica che finisce con il prevalere nell’età illuministica è quella, sostenuta da Voltaire, del dispotismo illuminato, fondato sulla collaborazione tra la monarchia e i Philosophes e considerato l’unico sistema che possa garantire, mediante le riforme, gli interessi della ricca e colta borghesia in uno Stato dove, secondo Federico II di Prussia, il principe deve essere il primo servitore dei suoi sudditi. Disposto ad abolire i privilegi aristocratici ed ecclesiastici, ma non a riconoscere il diritto di eguaglianza alla “canaglia”, Voltaire pensa che il genere umano non possa sussistere senza un gran numero di uomini che non posseggono nulla. Va però riconosciuto che, in quanto fa appello alla ragione, tutto il movimento illuministico è potenzialmente democratico e, d’altra parte, la diffidenza verso il popolo si spiega storicamente se si tiene conto delle condizioni di ignoranza, di arretratezza, di subordinazione alle forze reazionarie in cui versava il popolo in quel tempo; occorre anche ricordare che è stato l’illuminismo a gettare le basi di società future più giuste.

Voltaire e J.J. Rousseau
Si può dire che il baricentro filosofico europeo si trovò in Inghilterra nella prima metà del Settecento, in Francia alla metà del Settecento e in Germania verso la fine del secolo. Alcune linee di pensiero furono comuni a molti illuministi francesi quali Montesquieu, Voltaire e Rousseau.
- La Rivolta contro il Potere Costituito.
- Il Razionalismo.
- Il Pensiero dell’Illuminismo.
- L’Ottimismo Culturale.
- Il Ritorno alla Natura.
- Il Cristianesimo Umanizzato.
- I Diritti Umani.
LA RIVOLTA CONTRO IL POTERE COSTITUITO
Molti illuministi francesi si recarono in Inghilterra (sotto molti punti di vista, era molto più tollerante e liberale della Francia), e rimasero affascinati dalla scienza naturale inglese, soprattutto dalla fisica universale di Newton. Trassero anche grande ispirazione dalla filosofia inglese, specialmente dalle teorie di Locke. Tornati in Francia, dichiararono guerra alle vecchie autorità. Secondo loro era fondamentale assumere un atteggiamento scettico verso tutte le verità tramandate: ogni individuo doveva trovare da solo le risposte a tutte le domande, e qui appare l’influsso di Cartesio. La rivolta contro l’autorità voleva dire la rivolta contro lo strapotere della Chiesa, del re e dell’aristocrazia, istituzioni che nel Settecento, erano molto più potenti in Francia che in Inghilterra.
IL RAZIONALISMO
Analogamente agli umanisti dell’antichità come Socrate e gli stoici, i filosofi illuministi nutrivano una fede incrollabile nella ragione umana. Questa caratteristica fu così pregnante che molti definirono l’illuminismo francese “razionalismo”. La nuova scienza naturale aveva rivelato che la natura era ordinata razionalmente, per cui il compito che si assunsero i filosofi illuministi fu porre le basi per un’etica, una religione e una morale conformi all’immutabile ragione umana. Di qui si fa strada un vero e proprio pensiero illuminista. Ampi strati della popolazione dovevano essere “illuminati”, questo era il presupposto fondamentale per la creazione di una società migliore. Si pensava infatti che lo stato di bisogno e di oppressione in cui versava il popolo fosse dovuto all’ignoranza e alla superstizione: venne quindi data grande importanza all’educazione dei bambini e degli adulti. Non è un caso che la “Pedagogia” come scienza sia nata proprio nel periodo illuminista. Il monumento al pensiero illuminista fu “L’Encyclopédie” che venne pubblicata in 28 volumi dal 1751 al 1772, con l’apporto di tutti i maggiori filosofi illuministi. Qui è possibile trovare di tutto, si diceva. Dal modo di fabbricare un ago a come si fonde un cannone.
L’OTTIMISMO CULTURALE
Secondo i filosofi illuministi, non appena la ragione e il sapere si fossero diffusi l’umanità avrebbe fatto grandi progressi. Era soltanto una questione di tempo, e poi l’irrazionalità e l’ignoranza avrebbero ceduto il passo all’umanità illuminata. Questo modo di pensare ha dominato tutta l’Europa occidentale fino a qualche decennio fa: oggi non siamo più così convinti che tutto lo “sviluppo” abbia fine positivo. Bisogna notare però che la critica verso la “civiltà” venne già sostenuta da alcuni filosofi illuministi.
RITORNO ALLA NATURA
Ritornare alla natura fu il loro motto, anche se con “natura” essi intendevano qualcosa di anomalo a “ragione” perché la ragione umana – al contrario della Chiesa e della civiltà – è data all’uomo dalla natura. Si arrivò a sostenere che i popoli primitivi erano spesso più sani e felici di quelli europei, proprio perché non erano stati civilizzati. Fu Rousseau ad affermare che “bisogna tornare alla natura” perché la è buona e l’uomo lo è altrettanto “di natura”. Il male invece si trova nella società, nelle istituzioni. Secondo Rousseau, il bambino deve poter vivere nel suo stato di innocenza “naturale” il più a lungo possibile.
Si può dire che il riconoscimento di un valore proprio dell’infanzia venga soltanto con l’illuminismo. Prima essa veniva semplicemente considerata uno stadio preparatorio alla vita adulta. Ma siamo esseri umani e viviamo la nostra esistenza sulla Terra anche quando siamo bambini. Anche la religione doveva essere conforme alla ragione “naturale” umana. Numerosi furono i pensatori che lottarono per quella che potrebbe essere chiamata una “concezione umanizzata del cristianesimo”. C’erano ovviamente anche molti materialisti coerenti che non credevano in Dio e si proclamavano atei; tuttavia per la maggior parte dei filosofi illuministi, era irrazionale pensare a un mondo senza Dio perché l’universo era ordinato razionalmente (un pensiero, questo, condiviso anche da Newton). In modo analogo si considerava ragionevole credere nell’immortalità dell’anima: come per Cartesio, la questione riguardava la ragione più che la fede. Secondo l’illuminismo, il cristianesimo doveva essere depurato di tutti quei dogmi irragionevoli che erano stati aggiunti alla predicazione di Cristo nel corso della storia della Chiesa. Molti aderirono al cosiddetto “deismo”. È una concezione secondo la quale Dio creò l’universo molto, molto tempo fa, e da allora non si è rivelato al mondo, Dio si riduce così a una “creatura superiore” che si manifesta agli uomini attraverso la natura e le sue leggi, e non in modo “sovrannaturale”. Avevamo incontrato un “Dio filosofico” già in Aristotele: per lui Dio era la “causa prima” o il “primo motore dell’universo”.
DIRITTI UMANI
In generale si può dire che la filosofia illuministica francese era più rivolta alla pratica di quella inglese, cioè agirono partendo dalle loro conclusioni filosofiche. I francesi non si accontentarono di formulare teorie sul posto che l’uomo deve occupare nella società, ma lottarono per quelli che chiamavano i “diritti naturali” dei cittadini. Anzitutto si schierarono contro la censura e a favore della libertà di stampa. Al singolo doveva essere garantito il diritto di pensare e di poter esprimere liberamente le proprie opinioni in campo religioso, morale e politico. Ma lottarono anche per abolire la schiavitù dei negri e per far riservare un trattamento più umano ai carcerati. Il principio dell’inviolabilità dell’individuo fu messo per iscritto nella “Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino” che venne approvata dall’Assemblea Nazionale nel 1789 e che è alla base della Costituzione Norvegese del 1814.

I filosofi illuministi volevano fissare certi diritti che, a loro parere, spettano a tutti gli esseri umani, in virtù del fatto che sono nati uomini. Tuttora singoli individui o gruppi etnici si appellano a questi diritti naturali per opporsi ai soprusi, alla schiavitù e all’oppressione. La Rivoluzione del 1789 fissò un certo numero di diritti validi per tutti i “cittadini”, ma con questo termine si faceva riferimento a quelli di sesso maschile. Tuttavia proprio durante la Rivoluzione francese si hanno i primi esempi di lotta per la parità delle donne. Già nel 1787 il filosofo illuminista Condorcet aveva pubblicato un’opera nella quale sosteneva che la donna deve avere gli stessi diritti naturali degli uomini. Nella Rivoluzione del 1789 le donne furono molto attive: la folla che il 5 e il 6 ottobre 1789 marciò sulla reggia di Versailles, costringendo il re a una fuga precipitosa verso il palazzo delle Tuileries, era composta principalmente da donne. A Parigi, poi, si costituirono numerosi gruppi di donne, i quali, oltre alla richiesta di vedersi riconosciuti gli stessi diritti degli uomini, rivendicavano anche cambiamenti nelle leggi che regolavano il matrimonio e i rapporti sociali delle donne. Come succederà spesso anche in seguito, la questione dei diritti delle donne fu sollevata nel corso di una rivoluzione: non appena tutto tornò a posto, secondo un nuovo ordine, riprese il vecchio predominio maschilista.

Marie Olympe de Gouces
Nel 1791 (due anni dopo la rivoluzione) una donna molto attiva sul fronte dell’uguaglianza dei diritti; Marie-Olympe de Gouges (1775-1793), scrittrice, ebbe un ruolo di grande importanza durante la Rivoluzione francese, soprattutto grazie a numerosi opuscoli sulle questioni sociali e a una serie di opere teatrali. Nel 1791 pubblicò “La Dichiarazione sui Diritti della Donna”. Fu ghigliottinata nel 1793 perché aveva osato difendere Luigi XVI e attaccare Robespierre. Nella sua dichiarazione si esigeva la parità dei diritti tra uomo e donna. Quella sui “diritti dell’uomo e del cittadino” non conteneva alcun articolo sui diritti naturali delle donne. Da allora l’attività politica fu proibita alle donne. Soltanto nell’Ottocento le donne europee cominciarono davvero a combattere per i loro diritti e a poco a poco questa lotta diede i suoi frutti. Ma in Norvegia, per esempio, le donne non ottennero il diritto di voto prima del 1913 e tuttora in molti Paesi le donne hanno ancora molte cose per cui lottare. Va sottolineata l’importanza che la filosofia illuministica francese ha avuto per gli ideali e i principi su cui venne fondato l’ONU. Duecento anni fa il motto “Libertà, Uguaglianza e Fraternità” contribuì a unire la borghesia francese. Oggi le stesse parole devono legare tutto il mondo.
Illuminismo – le idee immortali che parlano al nostro tempo. Difendere quei valori significa anche liberarli da alcuni dogmatismi: è sbagliato, per esempio, imporre la tolleranza con la forza. L’intolleranza, il fanatismo e l’oscurantismo, che sono i tradizionali nemici dell’illuminismo, conquistano ogni giorno nuovi spazi. Difendere l’illuminismo significa anche criticarlo. Gli irrigidimenti e gli stravolgimenti del progetto illuminista vanno combattuti, perché certo dogmatismo si ritorce inevitabilmente contro l’illuminismo stesso. La scienza è certamente figlia dell’illuminismo, perché incarna la nostra liberazione dal peso delle tradizioni e delle credenze. Ma quando essa vuole essere padrona del mondo, quando pretende di dettare le finalità della società, allora le sue conseguenze diventano negative. La scienza che diventa scientismo, proponendosi come una regola morale della società, può avere effetti disastrosi. Un’altra deriva pericolosa è quella di chi, in nome dell’universalismo, pensa di poter imporre con la forza un ideale generoso come quello dell’illuminismo. In passato, lo pensava il dispotismo illuminato, che impediva al popolo di fare le proprie scelte. Oggi, lo pensano coloro che s’illudono d’imporre la democrazia e la tolleranza con la forza. L’illuminismo invita gli uomini a formulare e a scegliere da soli le norme a cui aderire. Questo passaggio dalla sottomissione all’emancipazione rappresenta una svolta senza precedenti, che ancora oggi è bene tenere a mente.
L’Europa è un continente frammentario, con molti stati, ciascuno con le proprie tradizioni, culture e religioni. Sono mondi simili, ma differenti. Per Hume, tale pluralismo ha abituato gli europei all’osservazione e alla critica degli altri, ma anche di se stessi. Inoltre, nella tradizione europea c’è un riconoscimento dell’individuo all’interno della società. Ciò ha consentitola nascita della democrazia, che è figlia dell’illuminismo, vale a dire un ordine politico che riconosce contemporaneamente l’autonomia del popolo e quella dell’individuo. Il progetto illuminista non è monolitico. Al suo interno si discute molto e le posizioni sono spesso distanti. All’epoca, ad esempio, Rousseau era percepito come un nemico degli enciclopedisti. Anche Gian Battista Vico era considerato un anticartesiano, quindi lontano dai principi dell’illuminismo. Dal principio d’autonomia che rifiuta le tutele esterne deriva la critica della religione, intesa come forza che controlla lo spazio sociale. Voltaire, infatti attacca la Chiesa perché è un’istituzione che tortura e condanna chi si allontana dal dogma. Egli però non è ateo. Come non lo sono Lessing, Kant o Rousseau, il quale ad esempio combatte contro il materialismo determinista di chi nega la dimensione spirituale dell’uomo. Per gli illuministi, che spesso si rifanno alla religione naturale, è però importante liberare la società dalla tutela delle religioni, sul terreno della conoscenza, che deve essere sempre libera, come su quello dell’educazione o della giustizia. In pratica, preparano la separazione tra Stato e Chiesa. Per quanto riguarda la religione come esperienza interiore, essi difendono la più completa tolleranza religiosa. Per gli illuministi, tutte le religioni vanno rispettate. Per loro non esiste più un’unica religione data da Dio una volta per tutte. Essi affermano la libertà di scelta e di coscienza. Nel mondo esistono numerose credenze e tutte meritano rispetto. L’illuminismo si oppone sempre al fanatismo religioso. Chi vuol impedire la critica alle religioni va contro un principio fondamentale dell’illuminismo, per il quale tutto deve poter essere criticato. Tuttavia, lo stesso illuminismo ci insegna che non possiamo imporre i nostri valori agli altri con la violenza, perché ciò significa rifiutare agli altri quella libertà che rivendichiamo per noi stessi. La libertà di coscienza non può essere imposta senza domandarsi cosa pensino gli altri. All’intolleranza si risponde con la tolleranza. È una posizione difficile, ma è la sola coerente. Non possiamo comportarci come coloro che condanniamo. Ciò è purtroppo avvenuto molte volte in passato. Anche nel secolo dei lumi, quando gli europei nelle colonie non rispettavano assolutamente i principi di libertà e uguaglianza proclamati nei loro paesi, mantenendo i colonizzati in uno stato di inferiorità.
- Illuminismo – le idee immortali che parlano al nostro tempo. Difendere quei valori significa anche liberarli da alcuni dogmatismi: è sbagliato, per esempio, imporre la tolleranza con la forza.
- L’intolleranza, il fanatismo e l’oscurantismo, che sono i tradizionali nemici dell’illuminismo, conquistano ogni giorno nuovi spazi. Difendere l’illuminismo significa anche criticarlo. Gli irrigidimenti e gli stravolgimenti del progetto illuminista vanno combattuti, perché certo dogmatismo si ritorce inevitabilmente contro l’illuminismo stesso.
- La scienza è certamente figlia dell’illuminismo, perché incarna la nostra liberazione dal peso delle tradizioni e delle credenze. Ma quando essa vuole essere padrona del mondo, quando pretende di dettare le finalità della società, allora le sue conseguenze diventano negative. La scienza che diventa scientismo, proponendosi come unica regola morale della società, può avere effetti disastrosi. Un’altra deriva pericolosa è quella di chi, in nome dell’universalismo, pensa di poter imporre con la forza un ideale generoso come quello dell’illuminismo. In passato, lo pensava il dispotismo illuminato, che impediva al popolo di fare le proprie scelte. Oggi, lo pensano coloro che s’illudono d’imporre la democrazia e la tolleranza con la forza.
- L’illuminismo invita gli uomini a formulare e a scegliere da soli le norme a cui aderire. Questo passaggio dalla sottomissione all’emancipazione rappresenta una scelta senza precedenti, che ancora oggi è bene tenere a mente.
- L’Europa è un continente frammentario, con molti stati, ciascuno con le proprie tradizioni, culture e religioni. Sono mondi simili, ma differenti. Per Hume, tale pluralismo ha abituato gli europei all’osservazione e alla critica degli altri, ma anche di se stessi. Inoltre, nella tradizione europea c’è un riconoscimento dell’individuo all’interno della società. Ciò ha consentito la nascita della democrazia, che è figlia dell’illuminismo, vale a dire un ordine politico che riconosce contemporaneamente l’autonomia del popolo e quella dell’individuo. Il progetto illuminista non è monolitico. Al suo interno si discute molto e le posizioni sono spesso distanti. All’epoca, ad esempio, Rousseau era percepito come un nemico degli enciclopedisti. Anche Gian Battista Vico era considerato un anticartesiano, quindi lontano dai principi dell’illuminismo.
- Dal principio d’autonomia che rifiuta le tutele esterne deriva le critica della religione, intesa come forza che controlla lo spazio sociale. Voltaire, infatti, attacca la Chiesa perché è un’istituzione che tortura e condanna che si allontana dal dogma. Egli però non è ateo. Come non lo sono Lessing, Kant o Rousseau, il quale ad esempio combatte contro il materialismo determinista di chi nega la dimensione spirituale dell’uomo. Per gli illuministi, che spesso si rifanno alla religione naturale, è però importante liberare la società dalla tutela delle religioni, sul terreno della conoscenza, che dev’essere sempre libera, come su quello dell’educazione o della giustizia. In pratica, preparano la separazione tra Stato e Chiesa. Per quanto riguarda la religione come esperienza interiore, essi difendono la più completa tolleranza religiosa.
- Per gli illuministi tutte le religioni vanno rispettate. Per loro non esiste più un’unica religione data da un Dio una volta per tutte. Essi affermano la libertà di scelta e di coscienza. Nel mondo esistono numerose credenze e tutte meritano rispetto.
- L’illuminismo si oppone sempre al fanatismo religioso. Chi vuole impedire la critica alle religioni va contro il principio fondamentale dell’illuminismo, per il quale tutto deve poter essere criticato. Tuttavia, lo stesso illuminismo ci insegna che non possiamo imporre i nostri valori agli altri con la violenza, perché ciò significa rifiutare agli altri quella libertà che rivendichiamo per noi stessi. La libertà di coscienza non può essere imposta senza domandarsi cosa pensino gli altri. All’intolleranza si risponde con la tolleranza. È una posizione difficile, ma è la sola coerente. Non possiamo comportarci come coloro che condanniamo. Ciò purtroppo è avvenuto molte volte in passato. Anche nel secolo dei lumi, quando gli europei nelle colonie non rispettavano assolutamente i principi di libertà e uguaglianza proclamati nei loro paesi, mantenendo i colonizzati in uno stato d’inferiorità.
IL ROMANTICISMO
Si può definire l’ultima grande epoca culturale europea. Il Romanticismo è un complesso movimento culturale che improntò il pensiero, le lettere, le arti e il costume dell’Europa. Cominciò alla fine del Settecento e si protrasse fino alla metà dell’Ottocento. Il termine romantic, usato per la prima volta nell’Inghilterra del Seicento in senso spregiativo per indicare cose “romanzesche”, fuori della realtà, venne assunto da J.G.Herder come sinonimo di “medievale” e da Novalis come equivalente di “poetico” (in tedesco, Romantik) e divenne il vessillo della nuova scuola che in antitesi al Classicismo, si ricollegò al Medioevo.
Diffusosi dalla Germania in tutta Europa, il Romanticismo assunse caratteristiche diverse nei vari Paesi, adeguandosi alle particolari esigenze storico – culturali di ogni realtà nazionale. In Inghilterra il primo “manifesto” romantico è il programma premesso da W. Wordsworth e S.T. Coleridge alle Ballate liriche (1798), anche se già da tempo circolava in Europa la voga del romanzo sepolcrale inglese e dell’ossianismo. G. G. Byron, P.B.Shelley, J.Keats furono i maggiori poeti romantici inglesi e W. Scott diffuse in Europa la voga del romanzo storico. In Francia fu l’opera Della Germania (1813) di M.me de Stael a divulgare le nuove teorie romantiche. Anticipato da F.R. de Chateaubriand, il Romanticismo francese si raccolse intorno al cenacolo di C. Nodier, al “salotto rosso” di V. Hugo e all’ “atelier” di T. Gautier. Con Hugo, caposcuola del movimento e autore della celebre prefazione al Cromwell (1827), “manifesto” della nuova scuola, i maggiori esponenti del Romanticismo francese furono A.de Lamartine, A. de Vigny, A. de Musset, G. de Nerval. In Italia, infine, la poetica romantica si affermò intorno al 1816 con le polemiche sorte intorno alla pubblicazione sulla Biblioteca italiana di Milano, di un articolo di M.me de Stael Sull’utilità delle traduzioni.
La polemica classico – romantica, accesasi subito dopo, vide schierarsi in difesa del Classicismo V. Monti e P. Giordani e a favore delle nuove teorie un gruppo di scrittori raccolti intorno al Conciliatore, che pubblicarono una serie di “manifesti”, il più noto dei quali è la Lettera semiseria di Grisostomo di G. Berchet (1816). La tendenza prevalente del Romanticismo italiano fu quella realistica, culminante nell’opera narrativa di A. Manzoni e di I. Nievo e nella poesia dialettale di C. Porta. e di G. Belli.

Giacomo Leopardi
Complessivamente modesti furono invece gli esiti della poesia sentimentale (a parte la solitaria e grandiosa esperienza di G. Leopardi, che oltrepassa tuttavia i limiti del Romanticismo), destinati a decadere nella lirica dolciastra e lacrimosa del “secondo Romanticismo”. Dopo il 1850 non ha più senso parlare di epoche che abbracciano la poesia, la filosofia, l’arte, la scienza e la musica. Rappresentò l’ultimo “atteggiamento comune” nei confronti dell’esistenza. Nacque in Germania come reazione all’esasperato culto illuministico della ragione. Dopo Kant, i giovani tedeschi sembravano respirare più liberamente. Le nuove parole d’ordine furono “sentimento”, “fantasia”, “nostalgia”. Anche alcuni pensatori illuministi, tra i quali Rousseau, avevano sostenuto l’importanza dei sentimenti, criticando il peso eccessivo dato alla ragione. Nel Romanticismo, ogni singolo individuo aveva, per così dire, via libera per una personale interpretazione dell’esistenza. I romantici professavano uno sfrenato “culto dell’io”. E quintessenza della personalità romantica apparve il genio artistico. Ci sono molti punti in comune tra il Rinascimento e il Romanticismo e uno è il grande peso che viene dato all’arte ai fini della conoscenza umana. Nel Romanticismo, ogni singolo individuo aveva via libera per una personale interpretazione dell’esistenza. I romantici professavano uno sfrenato culto dell’io. Quintessenza della personalità romantica apparve il genio artistico. Già Kant aveva affermato che il genio è l’artista che innova, che produce la sua opera in modo originale. Ci sono molti punti in comune tra il Rinascimento e il Romanticismo, e uno è il grande peso che viene dato all’arte ai fini della conoscenza umana.
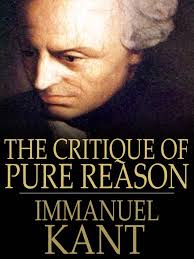
Anche qui Kant era stato un precursore: nella sua Critica del giudizio aveva cercato di spiegare che cosa avviene allorché contempliamo qualcosa di bello, per esempio un’opera d’arte. Quando ci accostiamo a essa senza altri interessi se non quello di sentirla il più profondamente possibile, allora oltrepassiamo i limiti di ciò che noi possiamo sapere, i limiti cioè della nostra ragione. L’artista è in grado di trasmetterci qualcosa che i filosofi non possono esprimere. Questa era l’idea di Kant e, con lui, dei romantici. Secondo Kant l’artista gioca liberamente con la sua facoltà conoscitiva. Il poeta tedesco Friedrich Schiller sviluppò ulteriormente il pensiero di Kant: l’attività dell’artista per lui è come un gioco, e solo quando l’essere umano gioca è libero perché è lui a creare le proprie leggi. Secondo i romantici, soltanto l’arte ci può avvicinare all’ineffabile. Si attribuì all’artista una forza immaginativa in grado di creare il mondo. Nella sua estasi artistica poteva sentire che la divisione tra sogno e realtà scompariva. Novalis, uno dei giovani geni romantici, disse che il mondo diventa sogno, e il sogno diventa mondo. Il desiderio, la nostalgia, di qualcosa di lontano e di irraggiungibile fu tipico dei romantici. Potevano anche anelare a un tempo passato, per esempio al Medioevo, che venne prepotentemente rivalutato rispetto al giudizio negativo espresso dagli illuministi. I romantici sentivano inoltre il desiderio e la nostalgia per le culture lontane, come per l’Oriente e il suo misticismo. E del pari si sentivano attratti dalla notte, dall’alba, dalle antiche rovine e dal soprannaturale. Erano affascinati dai lati oscuri dell’esistenza, cioè da tutto ciò che è buio, misterioso, ossessivo. Il Romanticismo fu innanzitutto un fenomeno cittadino: nella prima metà dell’800 si sviluppò una fiorente cultura in molte città europee, soprattutto in Germania. I tipici “romantici” erano giovani, molto spesso studenti, avevano un atteggiamento di vita spiccatamente “antiborghese” e giudicavano per esempio i padroni di casa e i difensori dell’ordine costituito “piccolo borghesi”, “filistei” o più semplicemente “nemici”.
Si potrebbe definire il Romanticismo – almeno nella sua prima fase, agli inizi dell’800 – come il primo movimento giovanile di rivolta in Europa: furono molti i punti in comune con la cultura hippie che nacque più di centocinquant’anni dopo. Si diceva che l’ozio è l’ideale del genio e l’indolenza la virtù romantica. Il dovere per i romantici era vivere profondamente la vita o allontanarsene sognando un’altra realtà. Il commercio e le faccende di tutti i giorni erano cose da piccolo borghesi. Gli amori trasognati erano tipici del Romanticismo. Novalis si fidanzò con una giovane di appena quattordici anni, che però morì quattro giorni dopo aver compiuto quindici anni. Novalis continuò ad amarla per tutta la sua breve vita, infatti morì a ventinove anni. Molti romantici morirono in giovane età, soprattutto di tubercolosi. Alcuni si suicidarono. Quelli che invecchiarono, verso i trent’anni abbandonarono le idee romantiche e diventarono in molti casi borghesi e conservatori. Il tema dell’amore irraggiungibile venne già introdotto da W. Goethe nel suo romanzo epistolare “I dolori del giovane Werther”, pubblicato nel 1774. Questo libro si conclude con la morte del protagonista, che si spara perché non può avere colei che ama. Fu dimostrato che il numero dei suicidi aumentò dopo la comparsa del romanzo, che per questo motivo venne proibito per un certo periodo di tempo in Danimarca e in Norvegia. Non era poi così innocuo essere romantici: entravano in gioco sentimenti molto forti. Uno dei tratti più importanti del Romanticismo fu l’anelito verso la natura e la sua mistica. Come detto, il Romanticismo fu un fenomeno cittadino e difatti questo sentimento della natura nasce più facilmente in città che in campagna. Il Romanticismo rappresentò anche una reazione all’universo meccanicistico dell’illuminismo e a ragione molti hanno visto nel Romanticismo la rinascita dell’antico senso cosmico, cioè la natura considerata una totalità. In questo i romantici si riallacciarono a Spinoza, ma anche a Plotino e ai filosofi rinascimentali come Jacob Bohme e Giordano Bruno. Comune a tutti loro era il fatto che sentissero un “io” divino nella natura. Cartesio e Hume avevano nettamente distinto l’io da una parte e la natura “estesa” dall’altra. Anche Kant aveva separato l’io conoscente e la natura “in se”. Usarono anche le espressioni “anima del mondo” o “spirito del mondo”. Il filosofo più influente fu Schelling, che visse tra il 1775 e il 1854. Schelling cercò di abolire la distinzione tra “spirito” e “materia”: secondo lui tutta la natura, cioè sia l’anima umana sia la realtà fisica, è espressione di un solo Dio o “spirito del mondo”.
La natura è lo spirito visibile, lo spirito è la natura invisibile, disse, affermando che nella natura possiamo intuire uno “spirito strutturante”. Sostenne anche che “la materia è un’intelligenza sopita”. Schelling vedeva nella natura uno “spirito del mondo”, uno spirito che scorgeva anche nella coscienza umana. Sotto questo punto di vista la natura e la coscienza umana sono in realtà espressione della stessa cosa. Lo “spirito del mondo” può essere ricercato sia nella natura sia nella nostra anima: per questo Novalis poté affermare che “la via misteriosa va verso l’interno”. Secondo lui l’essere umano porta dentro di sé tutto l’universo e l’uomo può fare esperienza vissuta del mistero del mondo penetrando in se stesso. Per molti romantici, la filosofia, la ricerca della natura e la poesia confluivano in un’unità più elevata: scrivere poesie chiusi nella propria stanza o studiare la vita dei fiori e la composizione delle pietre erano aspetti della stessa cosa, perché la natura non è un meccanismo morto, bensì uno “spirito del mondo vivo”.
Il naturalista Henrik Steffens, nato in Norvegia ma trapiantato in Germania, si recò nel 1801 a Copenaghen per tenere alcune lezioni sul Romanticismo tedesco. Steffens definì il movimento romantico con queste parole: “Stanchi dell’eterno tentativo di penetrare con la forza nella materia, scegliemmo un’altra strada per avvicinarci rapidamente all’infinito. Entrammo in noi stessi e creammo un nuovo mondo”. Schelling pensava anche a un’evoluzione della natura che, partendo dalla terra e dai sassi, arrivava alla consapevolezza umana. Mostrò che, attraverso vari passaggi, si va gradualmente dalla natura inanimata a forme di vita sempre più complesse. Nella concezione romantica, la natura veniva considerata come un organismo, cioè una totalità che sviluppa continuamente le proprie possibilità: la natura è come un fiore che apre le foglie e i petali o come un poeta che crea le sue poesie. La filosofia naturale romantica aveva connotazioni sia aristoteliche sia neoplatoniche. Aristotele aveva una visione più organica dei processi naturali di quella meccanica dei materialisti. Troviamo considerazioni analoghe anche in una nuova concezione della storia.
Il filosofo Johann Gottfried Herder, che visse tra il 1744 e il 1803, ebbe grande importanza per i romantici. Secondo lui, anche il corso della storia è il risultato di un processo orientato verso un fine. Per questo diciamo che ebbe una concezione dinamica della storia. I filosofi dell’Illuminismo avevano avuto per lo più una visione “statica” della storia: per loro esisteva una ragione universale che poteva essere più o meno presente nelle diverse epoche. Herder affermò che ogni epoca storica possiede un suo valore intrinseco. Analogamente, ogni popolo possiede caratteristiche distintive, “un’anima popolare”. La questione è se e come possiamo calarci in altri tempi e culture. Se vogliamo capire meglio la situazione di un’altra persona, dobbiamo immedesimarci in lei: la stessa cosa andava fatta per le altre culture. Oggi è diventata quasi una cosa ovvia, ma nel periodo romantico era una nozione nuova. Il Romanticismo contribuì anche a rafforzare il sentimento di identità nazionale. Non a caso la lotta per l’indipendenza nazionale norvegese si scatenò intorno al 1814. Si suole distinguere tra due forme di Romanticismo. Parliamo di Romanticismo universale, includendo in questo termine l’interesse per la natura, l’anima del mondo, il genio artistico. Questa forma di Romanticismo fu cronologicamente la prima ed ebbe la sua massima fioritura nella città tedesca di Jena, intorno all’anno 1800.
L’altra forma fu quella chiamata Romanticismo nazionale che si sviluppò più tardi ed ebbe il suo centro a Heidelberg, sempre in Germania. I “nazional – romantici” si occuparono in particolare della storia, della lingua e della cultura “popolari” perché anche il “popolo” veniva considerato un organismo che sviluppa le proprie possibilità, esattamente come avviene per la natura e la storia. Ciò che collega queste due forme di Romanticismo è la parola chiave “organismo”. I romantici consideravano una pianta e un popolo come organismi viventi. Lo stesso valeva per una poesia, per una lingua e anche per l’intera natura. Non esistono profonde differenze tra il Romanticismo nazionale e quello universale. Lo spirito del mondo era presente sia nel popolo sia nella cultura popolare, nella natura e nell’arte. Già Herder aveva raccolto canti popolari provenienti da tutto il mondo, dando alla sua raccolta il significativo titolo: Le voci dei popoli in canti. Ecco: definì la poesia popolare la “lingua madre dei popoli”. A Heidelberg si cominciarono a raccogliere canti e fiabe popolari: “Biancaneve, Cappuccetto Rosso, Cenerentola, Hansel e Gretel,” e molte, molte altre. Musicisti di tutta Europa cominciarono a servirsi nelle loro composizioni di motivi musicali popolari: in questo modo cercarono di gettare un ponte tra la musica popolare e quella d’autore.Nella musica popolare è quasi impossibile identificare un compositore: essendo legata a occasioni private o sociali – come i canti di lavoro e quelli eseguiti durante le feste -, è nata dal popolo ed è stata tramandata senza che nessuno si sia mai preoccupato di darle una forma definitiva; la musica d’autore invece è stata composta da una determinata persona, ed è stata scritta in modo preciso e compiuto. Una distinzione analoga si può fare tra fiabe popolari e fiabe d’autore. La fiaba rappresentò l’ideale letterario dei romantici, come il teatro fu la forma d’arte prediletta dal Barocco. Essa dava la massima libertà al poeta di giocare con la propria capacità creativa.
I filosofi del Romanticismo concepivano lo spirito del mondo come un io che, in uno stato più o meno onirico, crea le cose del mondo. Il filosofo Johann Gottlieb Fichte affermò che la natura ha origine da un’attività rappresentativa superiore e Nicosia. Schelling disse senza mezzi termini che il mondo è in Dio. Dio non è cosciente di tutto, esistono anche aspetti della natura che rappresentano l’inconscio in Dio, perché anche Dio ha un “lato oscuro”. “Il pensiero mi atterrisce e mi affascina al contempo” diceva Berkeley. Quasi allo stesso modo si concepiva il rapporto fra il poeta e la sua opera. La fiaba dava al poeta la possibilità di giocare con la sua forza d’immaginazione creatrice di mondi. L’atto creativo non era sempre consapevole: Il poeta poteva sentire che la storia che stava scrivendo nasceva dall’impulso di una forza intima. Mentre scriveva, poteva sentirsi quasi in uno stato ipnotico. Ma di colpo poteva anche rompere quell’illusione, intervenendo nella storia con piccoli commenti ironici rivolti al lettore in modo da rammentare per un attimo a quest’ultimo che la fiaba era una fiaba. In questo modo, il poeta poteva ricordare al lettore che anche la sua stessa esistenza era una fiaba. Questo modo di rompere l’illusione viene chiamato “ironia romantica”. Ibsen fece per esempio dire a uno dei personaggi di Peer Gynt che “non si muore nel quinto atto”. Con questa battuta il personaggio afferma di essere soltanto frutto dalla fantasia.
Nella pittura Géricault e Delacroix, sono considerati i maggiori rappresentanti del Romanticismo pittorico, ma anche l’intimismo di Corot, dei paesaggisti di Barbizon e l’appassionata satira politica di Daumier nacquero da una consapevole polemica contro la poetica dell’accademia classica.
Possono ricordarsi in Italia, oltre ai puristi, F. Hayez e G. Carnevali; in Spagna i modesti seguaci di F. Goya, L. Alenza y Nieto e R. Esteve y Vitella: in Gran Bretagna D. Scott; in Germania A. Rethel.
Nella musica i protagonisti della prima generazione romantica sono correntemente considerati i compositori attivi a partire dal secondo decennio dell’800, da C.M. Weber a F. Schubert, a R. Schumann, F Mendelsshon, F. Chopin, H. Berlioz, F. Liszt.
ARGOMENTI
(a cura di Bruno Silvestrini)
AMICIZIA

Le vere amicizie richiedono tempo. Esse sono difficili da trovare e faticose da mantenere. Ogni genitore sa quanto sia cruciale la scelta degli amici per ogni bambino. Le amicizie infantili rivelano ai genitori quale strada i loro figli stiano prendendo. Esse sono importanti, perché i buoni amici ti aiutano a progredire, mentre i cattivi amici ti fanno retrocedere. Ma è altrettanto importante, come esempio per i figli, che essi sappiano chi sono i nostri amici. I buoni amici fanno crescere, ma ciò deve valere anche nel senso che siate voi i buoni amici, che fanno crescere gli altri. L’essenza dell’amicizia sta nell’acquisire il punto di vista degli amici, il che equivale a prendere sul serio la vita degli altri non per il nostro, ma per il loro interesse. Nelle migliori amicizie possiamo intravedere il paradigma morale di ogni relazione umana nella sua forma più pura. L’amicizia è qualcosa di più della mera conoscenza ed esige un’attenzione maggiore del semplice affetto. Di solito sorge da interessi vicendevoli e da scopi comuni, e questi sono rafforzati da impulsi benevoli che crescono in seguito. I tratti dell’amicizia, cioè la sincerità, la trasparenza, l’accettazione tanto della critica quanto dell’ammirazione o della lode, la disponibilità, l’assistenza fino al punto del sacrificio personale, costituiscono altrettanti motivi di incoraggiamento alla maturazione e anche all’elevazione morale. Niente influisce di più sulla vita di un bambino che la forza morale di un esempio.
AUTORITÀ

La tradizionale domanda di fondo intorno alle fonti di autorità della conoscenza corrisponde proprio alla tradizionale questione di fondo della filosofia dello Stato, come essa fu edificata da Platone: “Chi deve governare?” Le risposte tradizionali erano: “i migliori” oppure “i più saggi” ma anche altre risposte in apparenza libertarie, come “il popolo” o “la maggioranza”. Le risposte rimangono invischiate nella autoritaria formulazione della domanda. Essa spinge ad alternative stupide del tipo: “chi deve governare i capitalisti o i lavoratori?” (Questa domanda è analoga alla questione gnoseologica: qual è la fonte ultima della nostra conoscenza? L’intelletto o la percezione sensoriale?). La domanda “chi deve governare?” è palesemente posta in maniera sbagliata, e le risposte che essa provoca sono autoritarie. Potrebbe avere una formulazione diversa e più modesta: “cosa possiamo fare per organizzare le nostre istituzioni politiche in modo tale che governanti cattivi e inetti (che naturalmente cerchiamo di evitare, ma ciò nonostante possiamo avere con grande facilità) arrechino danni il più possibile lievi?”. La democrazia ci permette di liberarci senza spargimenti di sangue di governanti cattivi.
CORAGGIO

Compiendo azioni giuste diventiamo giusti, azioni temperanti, temperanti, azioni coraggiose coraggiosi. (Aristotele; Etica Nicomachea). Una persona coraggiosa non è quella che non ha mai paura. Questa sembra piuttosto una persona imprudente e sconsiderata e rappresenta un pericolo più che un aiuto in una situazione di emergenza. Il coraggio consiste nel sapere ciò che davvero dobbiamo temere. (Platone). Chi non è disposto a lottare per le proprie idee, o non vale niente lui o non valgono niente le sue idee. (Ezra Pound).
CONOSCENZA

Gnoseologia: l’indagine e la dottrina filosofica relativa al problema della conoscenza cioè della verifica delle forme e dei limiti dell’attività conoscitiva umana. La conoscenza è ricerca della verità, non è ricerca di certezza. Errare è umano: tutte le conoscenze umane sono fallibili e perciò incerte. Ne consegue l’obbligo di distinguere nettamente tra verità e certezza. Che errare sia umano significa che dobbiamo sempre lottare contro l’errore, ma nemmeno con la massima meticolosità potremo mai essere del tutto sicuri di non avere commesso uno sbaglio. Che cos’è la verità? Kant nella sua opera principale “Critica della ragion pura”, rifiuta di fornire una risposta più diffusa di quella secondo cui la verità sarebbe: “accordo della conoscenza col suo oggetto”.
Secondo K. Popper: “Una teoria o una preposizione è vera quando lo stato di cose descritto dalla teoria concorda con la realtà”. E anche: ” Ogni asserzione formulata univocamente o è vera o è falsa; e se è falsa, allora è vera la sua negazione”. Se si è chiamati davanti alla corte come testimoni, viene ingiunto di dire la verità. Le asserzioni devono cioè concordare con i fatti, non devono essere influenzate dalle proprie convinzioni soggettive né da quelle di altri uomini. Se l’asserzione non concorda con i fatti, allora o si è mentito o ci si è sbagliati, a meno che non si affermi che la verità è quanto viene accettato e propagandato dalla società, dalla maggioranza, dal mio gruppo di interesse o forse dalla televisione. Per la dottrina e la prassi giuridica la formula: “in caso di dubbio l’imputato è assolto”.
Quello che i giudici devono fare, è giudicare se il caso che hanno davanti è un caso dubbio o meno. La verità è qualcosa di oggettivo, la certezza qualcosa di soggettivo. Quando ad un processo i giurati giungono ad un accordo “convenzione” questo si chiama “verdetto”. La convenzione è ben lungi dall’essere arbitraria. E’ dovere di ogni giurato tentare di trovare la verità obiettiva, secondo la migliore conoscenza e coscienza. Ma al tempo stesso egli deve essere consapevole della propria fallibilità, della propria incertezza. E nel caso di un ragionevole dubbio nel rinvenimento della verità egli dovrà pronunciarsi a favore dell’imputato.
“I do not believe in belief” – non credo nella credenza. Credo che la verità oggettiva sia un valore, dunque un valore etico e la malvagità sia il massimo non – valore.
La scienza è un’attività critica. Noi verifichiamo criticamente le nostre ipotesi. Le critichiamo per trovare gli errori, nella speranza di eliminarli e di avvicinarci così maggiormente alla verità.
Consideriamo una nuova ipotesi ad esempio sia migliore di un’altra, quando soddisfa tre esigenze: in primo luogo la nuova ipotesi deve spiegare tutte quelle cose che la vecchia non ha spiegato con successo. In secondo luogo deve evitare almeno alcuni degli errori della vecchia ipotesi. Il terzo luogo deve spiegare possibilmente cose che la vecchia ipotesi non poteva spiegare o prevedere. Tutti i grandi scienziati della natura furono di una grande modestia intellettuale;
Newton disse: “Non so come appaio al mondo. A me stesso appaio come un bambino che gioca sulla spiaggia. Mi diverto a raccogliere qua e la un ciottolo più liscio degli altri o una conchiglia più graziosa, mentre il grande oceano della verità si stende inesplorato dinnanzi a me”.
Einstein chiamò la sua teoria della relatività: “mosca effimera”. Tutti i grandi scienziati avevano ben chiaro che ogni soluzione di un problema scientifico solleva molti nuovi problemi irrisolti. La ricerca scientifica è il metodo migliore per illuminarci circa il nostro non sapere. Nella nostra infinita ignoranza siamo tutti uguali.
Quando formuli un’asserzione, devi anche giustificarla. E questo significa che devi essere in grado di rispondere alle seguenti domande: Dove hai saputo ciò? Su quali fonti poggia la tua asserzione? Quali percezioni stanno al fondo di essa?. Quali sono le fonti migliori della nostra conoscenza le fonti più affidabili, fonti che non inducano in errore? Simili fonti ideali e infallibili non esistono, così come non esistono governi ideali e infallibili, e che tutte le fonti della nostra conoscenza talvolta ci inducono in errore. Allora: “Esiste una via per scoprire ed eliminare gli errori?”.
Nella convinzione che non esistano fonti pure, inalterate e infallibili: “Cosa possiamo fare per scoprire l’errore?”. Risposta: “Con la critica esercitata su teorie e supposizioni altrui e – posto che possiamo educarci a ciò – con la critica alle nostre stesse teorie e ai tentativi speculativi di trovare soluzioni”. “Razionalismo critico”. (da: “Alla Ricerca di un Mondo migliore”di Karl Popper).
DESTINO – LIBERTÀ

Il problema dell’opposizione destino – libertà è tra le antitesi, quello che maggiormente ha tormentato l’umanità nel suo pensarsi già decisa o in grado di decidere le proprie azioni. Ogni cultura, anche se ha già conosciuto la scienza e l’impostazione razionale del pensiero, possiede un certo numero di parole che adombrano il senso del destino. Tali sono “sorte”, “fatalità”, “caso”, “predestinazione”, “vocazione”. Su di esse gravita un immagine del mondo che non è l’immagine che l’uomo s’è razionalmente costruito. Il destino sfugge alla logica della ragione. A queste riflessioni induce Alessandro d’Afrodisia. Nato ad Afrodisia di Caria, visse tra il II e il III secolo dopo Cristo ad Atene, dove insegnava filosofia aristotelica nella “Scuola Superiore di Studi Filosofici” fondata dall’imperatore Marco Aurelio e finanziata dallo Stato.
Amico del medico Galeno di Pergamo con cui non mancò di polemizzare. Alessandro d’Afrodisia scrisse una serie di commentari ai testi aristotelici che costituirono una fonte cosi preziosa per la cultura filosofica araba e rinascimentale da determinare, nel Rinascimento italiano, la formazione di una corrente denominata “alessandrismo” con cui Galileo ebbe a polemizzare per liberare la nascente ricerca scientifica a sfondo sperimentale dall’ipoteca del procedimento deduttivo di matrice aristotelica. La più antica cultura mediterranea raffigurava il destino come una dea che, con il fuso e il filo, tesseva il destino degli uomini.
I suoi nomi, a secondo delle regioni del Mediterraneo sono: Ilizia, la Nascita; Rapsò, la Tessitrice; Adrastia, l’Implacabile; Aisa, l’Equità; Nemesi, la Giusta Assegnatrice delle parti; da cui deriva la parola Heimarmene che, nel greco classico e nella cultura gnostica e fino al V secolo d. C., designa il destino.
L’idea del destino percorre la cultura greca da Omero ai tragici dove ciascun personaggio, epico o tragico, interpreta la “parte assegnata dalla volontà o dalla mente di Zeus”.
Ciò significa non che l’uomo è assistito dalla provvidenza di Dio come nella concezione cristiana, ma che l’uomo non è padrone del proprio destino il quale tesse il suo disegno in quella dimensione trascendente che l’uomo non può controllare. Ma una prima eccezione a questa visione del mondo l’abbiamo nell’Odissea dove si racconta di Egisto, l’amante di Clitennestra e l’istigatore dell’assassinio di Agamennone, che di sua iniziativa “ha aggiunto” al destino assegnatogli la propria azione delittuosa e il castigo conseguente.
Una seconda eccezione la troviamo in Senofane secondo il quale l’uomo inventa e introduce nella realtà naturale cose che gli dei non avrebbero mai fatto apparire.
Qualcosa dunque sfugge al destino e precisamente: la morale e la tecnica. Se tutto dipendesse dal destino nessuna azione sarebbe imputabile e quindi nessuna morale sarebbe possibile. Allo stesso modo se nulla nella natura potesse essere mutato, anche la tecnica, che in parte modifica l’ordine della natura, sarebbe impossibile.
Con questo doppio registro, dove accanto al destino si ammette quel margine di libertà che rende possibile la fondazione di una morale e la pratica della tecnica, giungiamo all’età di Pericle (V sec. a. C.) dove il destino viene ridotto a due figure: “la necessità della natura” (ananke) che agisce in maniera meccanica e deterministica, e il caso (tyche) che, come precisa Anassagora, dipende dall’ “ignoranza delle cause”.
Aristotele, introduce, accanto alla figura della necessità, per cui ciò che è in potenza si traduce in atto, e dell’impossibilità, per cui ciò che è in potenza non si traduce in atto, la categoria della possibilità per cui ciò che è in potenza può tradursi e non tradursi in atto.
Quel che allora si discuteva si ripropone nell’età moderna con la nascita della scienza, che pensa a se stessa in modo deterministico, e con la divisione tra cattolici e protestanti, dove decisivo è il problema della libera scelta o della predestinazione.
Lo stesso dicasi per l’età contemporanea dove la psicoanalisi fa dipendere lo spazio della libertà dai limiti imposti dall’ordine pulsionale, e, più recentemente, la genetica che, restringendo i margini di libertà, riduce quelli della responsabilità e dell’imputabilità su cui sono cresciute tutte le morali.
Alessandro d’Afrodisia rifiuta il destino perché altrimenti la morale sarebbe impossibile. L’argomento come si vede è debole, sarebbe come negare che ciascuno di noi abbia una sua determinata identità perché questa determinazione ridurrebbe gli spazi della libertà. Identità e libertà sono infatti tra loro conflittuali, come lo sono destino e libera scelta.
Il problema è a tutt’oggi insoluto. Ma una cosa non va trascurata: la libertà si fonda sulla possibilità di fare accadere o non accadere qualche cosa. Quindi è lo spazio del nulla (il non accadere) quello che rende possibile la libertà.
FEDE

Nella dottrina cristiana Fede – Speranza e Carità sono considerate virtù “teologali”. Ma non c’è nulla di specificamente cristiano nel riconoscere che in generale la fede religiosa da un maggiore significato alla vita morale dell’intera umanità. È una forza potente nell’esperienza umana. Niente è capace di tenere unite le persone tra loro quanto la fede. D’altro lato, i conflitti tra fedi diverse dividono le persone in modo talvolta assai violento.
La storia delle religioni conferma tristemente la naturale inclinazione dell’uomo per il settarismo. In un mondo che fosse privo di fedi religiose, non ci sarebbero certo le guerre di religione, ma nessuno ci assicura che sarebbe comunque un mondo di pace. Facciamo torto alla fede quando attribuiamo ad essa la causa dei conflitti.
La fede contribuisce alla formazione e alla qualità degli ideali che guidano le nostre aspirazioni e inoltre influenza il modo in cui noi guardiamo e ci comportiamo verso gli altri. Un essere umano senza fede, che non rispetta nulla, è un uomo moralmente alla deriva.
Le maggiori fedi mondiali sono come delle scialuppe di salvataggio a lungo sperimentate dai naufraghi; esse contribuiscono ad ancorare a una realtà più ampia coloro che sono allo sbando.
La fede offre un importante contributo alla stabilità sociale e allo sviluppo morale di persone e gruppi. Uno studio sull’esperienza religiosa dei fedeli condotto dal filosofo e psicologo William James pubblicato con il titolo: “The Varieties of Religions Experience”, scoprì una tendenza universale verso ciò che egli chiamò “monismo” o “ottimismo”.
In un mondo cosi frammentato e pieno di dolore, la fede nella sua unità e bontà di base rappresenta un incoraggiamento fondamentale per tutti coloro che, all’interno di una qualsiasi grande tradizione religiosa, lavorano in superficie per carità, gioia, pace, ecc. .
A tutti i genitori che considerano la fede una tecnica sleale che influenza la mente dei bambini, inculcando delle opinioni prima che essi arrivino all’età della discrezione in cui saranno capaci di scegliere da solo.
C’è un aneddoto illuminante di Samuel Taylor Coleridge tratto dal “Table Talk”. “Mostrai (a John Thelwall) il mio giardino e gli dissi che quello era il mio orto botanico. “Come mai”, egli disse, “è coperto da erbacce?” – “Oh”, replicai, “è solo perché non ha raggiunto l’età della discrezione e della scelta. Come lei vede, le erbacce sono libere di crescere, poiché ho pensato che non sarebbe giusto condizionare il suolo a produrre rose e fragole”.
La parola responsabilità rinvia all’idea di risposta. Essere responsabili significa perciò, in qualche modo, essere in grado di fornire una risposta. Un comportamento irresponsabile equivale a un comportamento immaturo. Al contrario, assumersi la responsabilità è un segno di maturità.
Quando ci sforziamo di aiutare i nostri figli a diventare persone responsabili, li stiamo aiutando a raggiungere la maturità. Siamo tutti responsabili di ciò che abbiamo fatto di noi stessi. Dire: “sono fatto così” non giustifica un comportamento sconsiderato. Non risponde neanche a verità, perché noi non siamo mai “fatti così”. Aristotele fu tra i primi ad affermare che noi diventiamo ciò che siamo attraverso le decisioni che prendiamo.
Il filosofo inglese Mary Midgley nel suo libro “Beast and Man” sostiene che “il punto centrale dell’Esistenzialismo è l’accettazione della responsabilità di essere ciò che abbiamo scelto di essere, ed il rifiuto di false scuse”.
Soren Kierkegaard, uno dei pionieri dell’Esistenzialismo deplora gli effetti negativi che ha la folla sul nostro senso di responsabilità. Egli scrisse in “Il punto di vista sulla mia opera come autore”: “La folla è nel suo stesso concetto la menzogna, in ragione del fatto che rende completamente irresponsabile e impenitente l’individuo, o almeno ne indebolisce il senso di responsabilità riducendolo a qualcosa di irrilevante”.
Nelle sue “Confessioni” sant’Agostino fa di questo indebolito senso di responsabilità il punto centrale delle sue meditazioni sulla propria gioventù dissoluta: “Tutto ciò perché non abbiamo il coraggio di tirarci indietro quando gli altri ci dicono: Avanti! Fallo!”.
Le persone responsabili sono anche persone mature che si fanno carico del proprio comportamento, che sono padrone delle proprie azioni e che rispondono ad esse.
Noi riusciremo a sviluppare un maturo senso di responsabilità nei nostri figli allo stesso modo in cui li aiutiamo a coltivare gli aspetti positivi del carattere: attraverso la pratica e l’esempio.
I lavori domestici, i compiti per la casa, le attività extrascolastiche e il volontariato possono contribuire alla maturazione solo se l’esempio dei genitori e le loro aspettative saranno chiare, coerenti e commisurate allo sviluppo delle capacità del bambino.
ONESTÀ

Essere onesti significa essere veri, genuini, autentici; essere disonesti, falsi, ambigui, fittizi. L’onestà esprime sia il rispetto per sé che il rispetto per gli altri. La disonestà non rispetta né se stessi né gli altri. L’onestà rende la vita aperta, affidabile e trasparente; esprime l’inclinazione a vivere nella luce. La disonestà cerca l’ombra, la dissimulazione, il sotterfugio. È una disposizione a vivere in parte nell’oscurità. “Odio, come odio le porte dell’Ade, colui che altro dice e altro cela nell’animo”, grida Achille angosciato nell’Iliade di Omero.
È l’onestà che cercava il filosofo cinico Diogene ad Atene e Corinto: “Con la candela e la lanterna, quando il sole brillava io cercavo gli uomini onesti, ma non ne trovai alcuno”.
Come si coltiva l’onestà? Come tutte le altre virtù, è meglio sviluppata quando è in armonia con le altre. Più è esercitata e più facilmente diventa un’inclinazione naturale. Bisogna essere consapevoli che l’onestà è la condizione fondamentale delle relazioni umane, dei rapporti di amicizia e della vita di tutte le comunità sane. Ma va coltivata seriamente e per se stessa, non come una strategia finalizzata alla convenienza. Immanuel Kant afferma che l’onestà è preferibile a qualunque tattica.
Tra la condotta personale seria e la paura di essere scoperti cioè tutta la distanza che intercorre tra l’onestà e l’opportunismo. È bene aver chiaro ciò che veramente importa: essere onesti nell’intimità dell’animo. L’onestà, a differenza dei vestiti nuovi, non passa mai di moda.
Essere onesti significa anche riconoscere che non esiste una verità assoluta (coloro che lo affermano diventano spesso fanatici), ma solo punti di vista relativi. L’onestà diventa allora la virtù che riconosce all’altro il diritto di dissentire e di sostenere liberamente la propria opinione.
Luigi Pirandello (1867 – 1936) ha dedicato praticamente tutta la sua opera a sostenere che non esiste una verità uguale per tutti, ma che ciascuno mette in scena , con la sua stessa vita, la propria verità.
OZIO

A coloro che mi hanno dedicato senza guardare l’orologio e senza alcun calcolo un po’ del loro tempo. L’ozio è parte della nostra libertà, e chiunque ce lo tolga ci priva anche di essa.
Oggi c’è molta libertà in vendita. La maggioranza degli uomini non riesce a capire cosa sia la libertà. Possiamo osservare che abbiamo identificato la libertà con l’esercizio della democrazia, anche se quest’ultimo concetto è rivendicato ormai da tutti i partiti e non è agevole orientarsi nella scelta delle interpretazioni. Di certo si è compreso che la libertà umana dipende da un certo sistema politico, ma esso non basta più a garantirla. L’uomo si è accorto che altri poteri minacciano la sua libertà. E quando negli anni Novanta la rivoluzione elettronica fu un fatto compiuto, quello che poteva essere un sospetto si trasformò in certezza. Abbandonati i grandi ideali, crollate le ideologie che comunque avevano costituito un punto di riferimento, l’uomo di fine millennio si trovò più solo di quanto avrebbe immaginato cinquant’anni prima.
Nel settimo libro delle “Vite dei Filosofi” di Diogene Laerzio è riportata la concezione degli antichi stoici per i quali “la libertà consiste nell’autodeterminazione e quindi solo il sapiente è libero”.
“Nell’Affittacamere” Fedor Dostoevskij: “Da la libertà all’uomo debole, ed egli si legherà e te la riporterà. Per il cuore debole la libertà non ha senso”.
Dopo la Prima guerra mondiale la vendita della libertà si celebrò puntualmente con i dittatori. In cambio Mussolini e Hitler promisero occupazione, potenza, ordine e cose simili; Stalin fece intravedere il sogno di una società di uomini eguali.
Il filosofo inglese Thomas Hobbes nella sua opera “Leviatano” del 1651, si legge: “Un uomo libero è colui che, in quelle cose che con la sua forza e il suo impegno è in grado di fare, non viene ostacolato nel fare quanto ha volontà di fare”.
Gogol “Anime Morte” in cui l’assessore collegiale Pavel Ivanovic Cicikov che decide di comperare servi della gleba defunti dopo il censimento, per i quali i proprietari però continuano a pagare il testatico per potersene servire ai fini delle assegnazioni delle terre.
Ci sono acquirenti del nostro tempo, il medesimo che con un aggettivo equivoco si è definito “libero”, ed è quella parte di vita di cui ogni uomo dispone dopo gli obblighi del lavoro. In fondo, per molti , altro non è che del “tempo morto”. E’ certo che sempre più persone sprecano (o vendono) il bene più prezioso che abbiamo e vivono assillati dall’orologio.
L’uomo ha guadagnato molto tempo per se stesso, ma ne ha sempre meno… il nostro tempo si assottiglia continuamente, ci siamo sbarazzati di quelle nicchie di vita che il passato aveva riservato alla nostra comprensione spirituale. Non è vero, obietteranno in molti, oggi l’anima è curata e studiata, analizzata come non mai. Che si vada sempre più da psicologi o psicoanalisti è indiscutibile, ma forse proprio per tale motivo è malata. Questi medici dell’anima curano una vera e propria epidemia, un disagio, un cattivo rapporto con il tempo.
Nel passato, probabilmente, siffatti problemi erano ignorati, coperti. Ma è innegabile che alcune qualità, molte terapie si siano perdute venendo meno la tensione spirituale che era recata dalla fede. La crisi della religione è anche la nostra. La morte di Dio non è il trionfo della tecnica, ma il tramonto dell’anima. Una rivendicazione per riavere l’ozio equivale a un progresso spirituale.
Seneca nelle “Lettere a Lucilio” scrive: “non vitae, sed scholae discimus” (impariamo non per la vita ma per la scuola) coglie l’essenza di quella istituzione che rilascia diplomi e che periodicamente ha bisogno delle riforme. Egli amava l’esatto contrario: “Non scholae, sed vitae discimus”.
Leon Battista Alberti (XV sec.) da: “I Libri della Famiglia”- “Perdesi adunque il tempo nollo adoperando, e di colui sarà il tempo che saprà adoperarlo”. Il grande genio dell’umanesimo non esalta l’ozio, ma il buon uso del tempo.
Lo storico britannico Richard Henry Tawney in “The Acquisitive Society ha scritto: “Le società industriali dimenticano i fini stessi in vista dei quali vale la pena di acquistare ricchezze nel loro febbrile ed esclusivo interesse per i mezzi con cui le ricchezze si possono acquistare”.
Ha scritto Giuseppe Prezzolini ne il “Centivio”: “Uno dei pregiudizi più ridicoli degli uomini è quello del tempo perso. Nessun tempo è in realtà perso. Le ore d’ozio collaborano a formare la nostra personalità come le ore di lavoro, forse meglio”
Chi non sa oziare difficilmente sa vivere.
Tommaso Moro nell’ “Utopia” (1516) fissa a sei ore giornaliere il tempo della fatica; Tommaso Campanella nella “Città del Sole” (1611) scende a quattro.
Lenin in un articolo del 1914 profetizza che quando i proletari avranno vinto la loro lotta ne basteranno tre.
Bertrand Russell nell’ “Elogio dell’Ozio” quattro ore.
Negli anni Novanta, l’economista americano Jeremy Rifkin profetizzò la fine del lavoro. La produzione cadrà in mano agli automi e il computer ingloberà il terziario. Una sorta di eutanasia del lavoro, però avvolta in uno scenario apocalittico. Non è un fatto auspicabile. A quel punto le macchine decideranno anche della nostra vita oltre che della libertà.
Kazimir Malevic, figura dell’avanguardia russa “La pigrizia come verità affettiva dell’uomo” “La pigrizia rappresenta il principale incentivo al lavoro, poiché soltanto attraverso il lavoro si può accedere alla pigrizia”. Da: “Le Virtù dell’Ozio”(di: Armando Torno)
Il lavoro è fatto naturale e condivisibile. Tutto cambia quando l’accanimento produttivo cancella l’uomo.
Da sempre l’uomo cerca nell’ozio, o quanto meno dalla non fatica, una dimensione più naturale, più adatta ai suoi desideri.
L’uomo ha una vita materiale sola, che ci affanniamo per cose effimere, che si potrebbe vivere meglio se non volessimo accumulare cose e mezzi come se fossimo eterni.
Tutte le epoche hanno rimpianto qualcosa di perduto, senza poi riuscire a specificare cosa fosse.
Chi è dappertutto non è in nessun luogo. A chi passa la vita viaggiando accade di avere molte conoscenze, ma nessuna amicizia. (Seneca; Lettere a Lucilio)
“Carpe diem, quam minimum credula postero” Godi il giorno che passa, confida meno che puoi nel domani. (Orazio)
“Non est, crede mihi, sapientis dicere “Vivam”. Sera nimis vita est crastina: vivi hodie”. – Non è , credimi, cosa da saggi dire: “Vivrò”. Troppo tarda è la vita che verrà: vivi oggi. (Marziale; Epigrammi)
La ricchezza spirituale è l’unica spendibile nei giorni difficili.
Non lascia nulla al caso, nulla, a parte, come tutti la propria vita.
“C’è di quelli cui la vita solitaria sembra più funesta della morte, foriera di morte. Questo avviene di solito agli ignoranti che, mancando un interlocutore, non hanno argomenti di cui sappiano parlare con se stessi o con i libri, e perciò rimangono muti. La solitudine senza cultura è certo un esilio, un carcere, una tortura. Aggiungivi la cultura: diventa la patria, la libertà, il godimento”. (Petrarca; De vita Solitaria)
“Sorgea la notte intanto, e sotto l’ali ricopriva del cielo i campi immensi; e ‘l sonno, ozio dell’alme, oblio de’ mali, lusingando sopia le cure e i sensi”. (T. Tasso; Gerusalemme Liberata – VIII, LVII).
VERITÀ

I greci per esprimere la “verità” usavano un concetto negativo, formato da un “alpha” privativo e dal verbo “lathein” che significa “essere nascosto”, da cui le nostre parole “latente”, “latitante”.
Nulla da spartire con il latino “veritas” che rimanda non a ciò che si manifesta, ma a ciò che si custodisce, si trattiene, si conserva. La “verità” in senso greco svela la “natura” che i greci chiamavano “physis”, e per i quali la natura, nell’accezione di physis, è l’essere nel suo originario manifestarsi. La radice “phu” (da cui il latino e l’italiano “fui” come tempo remoto del verbo essere) è la radice comune a “physis” (natura) e a “Phainestai” (manifestare). La verità greca è allora l’originaria manifestazione dell’essere che, sottraendosi al nascondimento (“la natura ama nascondersi” diceva Eraclito), si palesa e si dà in visione. “Visione” in greco si dice “idea”, la radice “id” la ritroviamo nel verbo latino “video” (vedere) e “videor” (apparire, sembrare), ma il “vedere non è più l’originario apparire dell’essere, ma lo sguardo che l’uomo dispiega sull’essere. Il concetto di verità subisce un essenziale mutamento nel mito platonico della caverna dove è possibile scorgere, accanto alla più alta comprensione della verità come manifestazione dell’essere (aletheia), anche la presenza di quella sconcertante deviazione che determinerà per l’occidente l’oblio dell’essere e della sua verità. Nel mito si racconta di un prigioniero che, liberatosi dai ceppi che lo tratteneva nel fondo della caverna, dove si stagliavano le ombre proiettate dai simulacri portati dagli uomini, e sporgenti al di sopra di un muricciolo che sorgeva alle sue spalle, si volge e vede dapprima i simulacri che sono copia delle cose che dimorano sotto la luce del sole, e quindi le cose di cui prima possedeva solo incerte e fugaci immagini. L’interpretazione del mito è possibile solo sulla base della verità come aletheia, come non nascondimento. Nel processo di liberazione, infatti, si assiste la progressivo non-nascondersi e quindi al progressivo non rivelarsi prima delle ombre proiettate dal fuoco sotterraneo, poi dei simulacri delle cose, e infine delle cose che dimorano sotto la luce del sole. L’essenza del mito è raccolta nel passaggio che dal buio della caverna conduce alla luce del giorno e viceversa. Il passaggio dall’oscurità alla luce determina nel prigioniero un offuscamento dovuto all’intensificarsi della luminosità che, accecando lo sguardo “l’idein”, che esprime appunto l’atto del vedere, nasconde “l’eidos” ovvero ciò che si offrirà allo sguardo una volta che questo si sarà assuefatto alla luminosità.
Platone chiamava “paideia” (educazione) il progressivo assuefarsi alla luminosità dell’essere, che strappa le cose dal nascondimento solo per coloro che si sono assuefatti alla luce. La “paideia” è oltrepassamento dell'”apeideusia”, ovvero di quell’ignoranza in cui rimangono coloro che non sopportando il bagliore accecante del fuoco e del sole, si trattengono presso le ombre che sono solo il riflesso delle cose vere. Ma proprio qui si assiste a quel capovolgimento dell’essenza della verità che deciderà la storia dell’occidente, nella sua versione metafisica (articolata sul dualismo mondo-dio) nella struttura della conoscenza (soggettiva e intersoggettiva), nell’etica dei valori (possibili solo presupponendo una gerarchia dell’essere), e nella centralità antropologica (che prevede l’uomo al centro del mondo). Se infatti la successione dei passaggi che dalle tenebre della caverna conducono alla luce del giorno si lasciano comprendere a partire dalla verità come manifestazione (aletheia), l’essere, raffigurato dal sole, a proposito del quale Platone scrive che: “Produce le stagioni che è il corso degli anni, e tutto presiede in questo regno dell’essere visibile ed è causa di tutti quei fenomeni che i prigionieri vedevano” (Repubblica, libro VII), non è più inteso come manifestazione di ciò che si manifesta, quindi come aletheia ma è inteso come quell’Ente che Platone chiama “Agathon”, che presiede l’essere e l’apparire di ogni cosa.
Il significato del termine Agathon, che noi traduciamo con “Bene” non ha solo un significato morale in quanto fonda una gerarchia di valori, ma va innanzitutto inserito in quel contesto metafisico che è volto alla ricerca della causa prima da cui ogni cosa dipende.
Tommaso D’Aquino nel “De Veritate” I, 4 scrive: “Verità e corrispondenza (adaequatio) tra l’intelletto e la cosa. Questa corrispondenza non può essere se non nell’intelletto”. In questo modo la verità non è più manifestazione dell’essere, ma correttezza del giudicare umano (orthotes, adaequatio). Questa trasformazione dell’essenza della verità ha portato l’uomo al centro dell’essere e ridotto l’essere a soggetto del suo dominio. Dopo la deviazione platonica del concetto di verità e ancor più dopo la radicalizzazione di questa deviazione ad opera della scienza moderna, l’uomo non può riscattarsi dal suo errare e non si congeda da quel modo di pensare, divenuto abituale in occidente, che è il “calcolare”. Nel pensiero che calcola, a differenza del pensiero che pensa, non c’è salvezza, anzi li si nasconde il rischio più inquietante, perché, scrive Heidegger: “Ciò che è veramente inquietante non è che il mondo si trasformi in un completo dominio della tecnica.
Di gran lunga più inquietante è che l’uomo non è affatto preparato a questo radicale mutamento del mondo. Di gran lunga più inquietante è che non siamo capaci di raggiungere, attraverso un pensiero pensante, un confronto adeguato con ciò che sta veramente emergendo nella nostra epoca.
Con Ulisse, forse per la prima volta nella storia, appare tutta la debolezza e l’insignificanza della verità. Che la verità sia vera è inessenziale, l’importante è che sia persuasiva. Anche Cassandra dice la verità, ma le sue parole non essendo accompagnate da persuasione (peitho), restano inefficaci. I greci, con Ulisse, avevano già capito quello che oggi impariamo dalla politica e dalla pubblicità. Non è importante che le cose che si dicono siano vere, è sufficiente che siano persuasive. La persuasione e non la verità crea consenso.
Freud e Nietzsche ci hanno insegnato che la nostra coscienza è un castello di menzogne edificate sull’inconscio percorso di pulsioni incoffessabili. Per gli antichi greci mentire significa abitare la distanza che intercorre tra apparenza e realtà, e quindi uscire dall’ingenuità di quanti credono che le cose siano come appaiono. Aristotele dice: “Mentire è veramente grave se interessa la giustizia nelle forme della frode, del tradimento o di altri danni alla comunità politica, lo è meno se riguarda la vita privata”. Per Agostino di Tagaste “Il bugiardo è da condannare sia che la menzogna investa la sfera pubblica sia che riguardi quella privata. Ed è bugiardo sia che dice cosa falsa con l’intenzione di ingannare sia chi la dice vera ma sempre con l’intenzione di ingannare.
Chi invece la dice falsa con l’intenzione di dire il vero costui non è da riprovare perché è semplicemente uno sprovveduto”. Ma se l’inganno ha in vista il bene o il minor male? Bugie a chi sta morendo? Crescere figli tra mezze bugie e mezze verità?
Per Agostino il fine non giustifica i mezzi né per il figlio che deve crescere, né per il morente che deve dire addio, né per la città che talvolta può essere meglio governata con le menzogne.
Il fine non giustifica i mezzi, perché nessun fine può dirsi apprezzabile se per la sua realizzazione si chiedono coscienze ingannatrici. E allora che dire di Abramo che invita il figlio Isacco a un sacrificio senza comunicargli che la vittima è lui. Il silenzio, dice Agostino non è una bugia. Davvero possiamo dire che il silenzio non mente? Socrate la pensava diversamente perché, dopo aver identificato la virtù con il sapere, non riteneva si potesse considerare virtuosi gli imbecilli.
La verità sulle persone, sul cosiddetto loro vero carattere, sul loro presunto vero temperamento (per non dire delle loro vere intenzioni) è assai difficile da stabilire. Diciamo pure impossibile.
Ad esempio, qual è il Socrate vero? Quello sublime descritto da Platone o quello comico caricaturato da Aristofane? Eppure l’Atene di quei tempi era un paesone piccolo. Tutti, o quasi, si conoscevano. Tuttavia, lo stesso personaggio storico ispira due ritratti così differenti.
Agli inizi degli anni cinquanta il regista giapponese Akira Kurosawa fece un film originalissimo: “Rashomon”. Vi erano tre personaggi, tre modi diversi di raccontare lo stessissimo fatto di cui ognuno di loro era stato diretto protagonista. Il vecchio regista spiega: “Gli esseri umani sono incapaci di essere onesti con se stessi. Non riescono a parlare di sé senza abbellire il quadro”.
Anche in : Uno nessuno centomila” di Luigi Pirandello il protagonista, Vitangelo Moscarda si rende conto ad un certo punto della sua vita di non avere una immagine sola: ma tante, quante sono le persone che lo osservano, incontrandolo.
Nel mondo c’è bisogno di filosofia più di quanto si possa credere, disciplina antica quanto l’uomo, incline a porsi domande sul senso delle cose, riflessioni per illuminare un tanto difficile cammino. L’antitesi Oriente – Occidente, con tutte le sue diversità; il contrastante modo di vivere la realtà dell’uomo pre – tecnologico e di quello attuale; la parola autorevole delle grandi menti del passato da Platone, a Nietzche, Heidegger e Jaspers, fanno da guida e controcanto al viaggio dentro l’anima dell’uomo, “dalla psicanalisi alla pratica filosofica”.
Ippocrate affermava che: “Il medico che si fa filosofo diventa pari a un dio”. Nella casa di psiche (ovvero dentro la nostra anima) ha preso dimora un ospite inquietante che chiede il senso dell’esistenza. Gli altri ospiti che già abitavano la casa, obiettano che la domanda è vecchia quanto il mondo, perché dal giorno in cui sono nati, gli uomini hanno conosciuto il dolore, la miseria, la malattia, il disgusto, l’infelicità e persino il disagio della civiltà a cui prima le pratiche religiose, poi quelle terapeutiche con la psicoanalisi in prima fila, hanno tentato di porre rimedio.
L’ospite inquietante però insiste nel dire che nell’età della tecnica la domanda di senso è radicalmente diversa, perché non è più provocata dal prevalere del dolore sulle gioie della vita, ma dal fatto che la tecnica rimuove ogni senso che non si risolva nella pura funzionalità ed efficienza dei suoi apparati. L’uomo soffre per l’insensatezza del suo lavoro, per il suo sentirsi soltanto un mezzo nell’universo dei mezzi, senza che all’orizzonte appaia una finalità prossima o una finalità ultima in grado di conferire senso. Sembra infatti che la tecnica non abbia altro scopo che il proprio autopotenziamento. Visto che la psicoanalisi sembra inadeguata, atta solo alla rimozione del dolore, pur curando le sofferenze dell’anima, è indispensabile il ritorno alla filosofia, perché fin dagli albori, la filosofia non ha esitato a rimettere in questione il mondo.
Volgarizzando il concetto, potremmo dire che la psicoanalisi è il medico curante, mentre la filosofia è lo scienziato che studia l’essenza, la ragione profonda della malattia, non esitando a mettere in discussione il mondo. Nel libro di U. Galimberti “La casa di psiche” sono suggestive le pagine in cui sottolinea come l’amore nasca, in quanto dialogo, tra due esseri, mentre il dolore “si radica, nell’assoluta individualità”. Di conseguenza, “l’analisi del dolore è innanzitutto un’analisi del linguaggio e della visione del mondo che lo ospita. Le modalità del suo descriversi sono uno spaccato di filosofia della storia.
Bibliografia:
- Bertrand Russell – Storia della Filosofia Occidentale (voll. I, II, III, IV) Longanesi Editore – anno 1972
- Platone – La Repubblica (Vol I e II) – Ed. Rizzoli – anno 1981
- Diogene Laerzio – Vite dei Filosofi – Ed. Associati anno 1991 – Pag. 642
- Luciano De Crescenzo – Storia della Filosofia Greca – (Vol. I) I Presocratici – Mondadori Ed. – 1983 – Pag. 238
- Luciano De Crescenzo – Storia della Filosofia Greca – (Vol. II) Da Socrate in poi – Mondadori Ed. – 1986 Pag. 231
- Jostein Gaarder – Il Mondo di Sofia – Ed. CDE su licenza della Longanesi & C. – anno 1995
- Le immagini sono tratte da Internet




Nessun commento:
Posta un commento